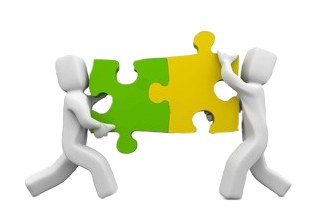
Gli esseri umani sono per natura aggressivi? La guerra è scritta nei nostri geni? In antropologia sono domande che sorgono abbastanza spesso: finchè esisteranno individui e gruppi umani con esigenze simili vi saranno sempre conflitti per le risorse utili a soddisfarle. Non sorprende allora che gli antropologi si misurino con situazioni di ostilità più o meno latente.
Già Bernardo Bernardi, antropologo africanista scomparso recentemente, scriveva in Antropologia del Conflitto che
Durante il lavoro di ricerca di campo, l’antropologo può sorprendersi non tanto delle differenze di carattere degli individui con cui viene a contatto, quanto delle tensioni latenti che non si manifestano all’osservazione normale, ma che esplodono nei momenti più improbabili e per i più insospettati motivi. Spesso sono manifestazioni di antichi risentimenti radicati di generazione in generazione, che informano i rapporti sociali tra persone e persone e tra gruppi etnici discendenti da uno stesso capostipite. Fenomeni del genere si avverano in tutti i rapporti umani, a qualsiasi livello, tanto da indurre a considerare il conflitto una delle componenti ordinarie della vita comune, anzi dell’ordine sociale. E’, quindi, nella prospettiva dell’ordinamento sociale che va condotta l’analisi del conflitto.
Potremmo dire allora che, in fondo, ogni antropologo se ne occupa, non fosse altro che c’è sempre il rapporto/contrasto con l’Alterità e la sua misura. Ed ecco perchè la risoluzione del “conflitto” è un’urgenza molto sentita, e a ragione. Vi sono però antropologi che si occupano specificatamente di risoluzione dei conflitti e di mediazione, soprattutto nell’ambito della cooperazione e dello sviluppo.
Andrea Buti mi ha segnalato William Ury, tra i fondatori del Program on Negotiation (PON) del’Università di Harvard. Ringrazio Andrea per avermi fatto conoscere il suo lavoro: Andrea è un avvocato che si occupa di mediazione e gestione del conflitto, e si interessa di antropologia del conflitto in relazione alla sua attività.
Si potrebbe pensare che l’antropologia del conflitto interessi più che altro l’antropologia culturale. Ma anche gli antropologi fisici se ne occupano e le meccaniche alla base degli stati di tensione sono ben studiate nelle comunità di primati, specialmente tra le scimmie antropomorfe.
Dal punto di vista dell’antropologia fisica parlare di antropologia del conflitto non equivale a studiare le basi biologiche dell’aggressività. Quest’ultima ha sì componenti innate, ma dirette alla sopravvivenza dell’individuo, non all’organizzazione delle ostilità tra individui. Lo esprime bene l’etologo umano Irenäus Eibl-Eibesfeldt, ne Le invarianti nell’evoluzione delle specie, dove si interroga sulle domande poste all’inizio di questo post giungendo alla conclusione che
Siamo di natura socievole e portati all’amore, a creare dei legami personalizzati. In un altro libro, Guerra e pace, specificai che la guerra, come aggressione di gruppo distruttiva, strategicamente pianificata e condotta con armi e volta a distruggere l’avversario, non è scritta nei nostri geni, ma è un risultato della evoluzione culturale. Essa può sicuramente avvalersi di disposizioni di comportamento innate; altre disposizioni invece, come la compassione e l’umiltà, vengono purtroppo disattivate dall’indottrinamento. Abbiamo osservato tra l’altro, che i nemici vengono resi oggetti impersonali sia nelle nazioni tecnologicamente avanzate sia nelle popolazioni tribali. Il conflitto viene spostato, per così dire, su un livello di disumanizzazione.
Come prodotto dell’evoluzione culturale, la guerra può essere senz’altro essere tenuta sotto controllo attraverso la cultura stessa. E’ però necessario capire e riconoscere che, finora, essa ha assolto la funzione di assicurare le risorse, funzione che va invece compiuta in modo incruento, se si desidera la pace. [...]
L’uomo è sostanzialmente capace di mantenere la pace, anzi, anela la pace, e ciò vale non solo per gli uomini del mondo occidentale.
Dunque, se la natura dei conflitti è soprattutto culturale, perchè l’antropologia fisica continua a occuparsene? In realtà la questione affonda le sue radici nella stessa evoluzione umana e in particolare nell’evoluzione del cervello in relazione alla socialità.
David Barash, tra i fondatori della sociobiologia e autore de Il gioco della sopravvivenza, ha studiato il comportamento umano in questo ambito attraverso i modelli matematici della Teoria dei Giochi.
Secondo Barash, il confronto dell’uomo con i suoi simili e con l’ambiente ha fatto sì che i comportamenti vantaggiosi siano diventati parte integrante della specie. A questo confronto continuo dobbiamo “coscienza” e “razionalità”: la prima necessaria per avere consapevolezza di se stessi e di provare empatia per gli altri, la seconda per elaborare soluzioni efficaci dei problemi quotidiani.
Soffermiamoci un attimo sull’empatia: non significa pietà, ma immedesimarsi nell’altro per capirne le intenzioni e anticiparle, soprattutto se si tratta di un rivale. Secondo Barash, al fine di evitare un gioco continuo di rimandi (“io so che lui sa che io so, quindi…”), l’evoluzione ha posto un freno allo sviluppo delle capacità empatiche umane.
L’empatia non si è dunque evoluta per cementare i rapporti sociali, ma per facilitare la sopravvivenza dell’individuo. Le scelte che si compiono, allora, sono tutte dettate da esigenze egoistiche, anche se non lo sono in apparenza. Ma le dinamiche di gruppo fanno sì che il conseguimento del vantaggio personale sia mediato dal vantaggio per il gruppo. Dice Barash:
per ogni argomentazione che identifica l’interesse personale nell’azione individuale, ve n’è un’altra che enfatizza i vantaggi della cooperazione.
La Teoria dei Giochi è sostanzialmente una teoria del conflitto e parte dal presupposto che la probabilità di scontro è molto alta. Il suo scopo quindi non è tanto evitare il confronto, quanto saperlo gestire nel modo migliore e possibilmente pacifico. L’analisi di una situazione conflittuale mostra quelle caratteristiche che non sono subito evidenti e quindi subito sfruttabili sul piano della cooperazione.
Da questo punto di vista è notevole che, negli ultimi anni, l’attenzione dei primatologi si sia spostata non tanto sulle modalità con cui scoppia l’ostilità, ma su come i primati si riconciliano. Frans de Waal è uno dei più accaniti sostenitori di questo “rovesciamento” dei punti di vista, tanto da parlare di antropologia della riconciliazione.
Ne La scimmia che siamo, Frans de Waal racconta di una conferenza che stava tenendo, e
In tono di rimprovero avevo fatto presente al mio uditorio il fatto che sappiamo di più sulla riconciliazione fra gli altri primati che non nella nostra specie, e questo è vero ancora oggi. Gli psicologi tendono a concentrarsi sul comportamento anormale o problematico, per esempio sulla prepotenza, e quindi sappiamo sorprendentemente poco dei modi spontanei e normali in cui il conflitto viene attenuato o superato. A difesa di questa deprecabile situazione, uno scienziato presente ribattè che la riconciliazione umana è di gran lunga più complicata che nelle scimmie non antropomorfe, influenzata com’è dall’istruzione e dalla cultura. Negli altri primati, disse, si tratta di semplice istinto.
Il termine “istinto” mi era rimasto in testa, anche se non so quasi più cosa voglia dire, perchè un comportamento assolutamente innato è impossibile da trovare. Tanto come gli esseri umani, gli altri primati si sviluppano lentamente e per anni vengono influenzati dall’ambiente in cui crescono, compreso il tessuto sociale. In effetti sappiamo che i primati mutuano l’uno dall’altro tutta una serie di comportamenti e di abilità e di conseguenza gruppi della stessa specie possono comportarsi in maniera del tutto differente, quindi non c’è da meravigliarsi che i primatologi parlino sempre più di variabilità “culturale”.
E qui chiudo il cerchio con uno stralcio tratto da La gestione costruttiva del Conflitto attraverso la mediazione, dell’avvocato Alessandro Bruni, che raccoglie sia gli spunti tratti dall’antropologia culturale di William Ury che della Teoria dei Giochi di David Barash:
Solitamente sembra più facile e meno faticoso (ma solo apparentemente) decidere di “rimanere nemici”, di vivere la strana eccitazione della contrapposizione con gli altri: la tendenza è quella di vincere unilateralmente più che si può (e finché si può), in una replica del gioco a somma zero (io vinco/tu perdi; +1-1=0).
In realtà, come si insegna al Program On Negotiation dell’Università di Harvard, Massachusetts, (USA), cooperare è più conveniente che competere: in buona parte delle relazioni sociali la possibilità di vincere entrambi porta a far capire che si vince di più se si vince tutti (sistema win-win, contrapposto a quello win-lose).
Secondo la teoria dei giochi questo risultato viene definito “a somma positiva”. In realtà può dirsi che si tratta del successo di un’opposizione cooperativa tendente all’equilibrio stabile e duraturo.
Ma gli antropologi come possono capitalizzare, sul piano professionale, queste argomentazioni? E’ possibile utilizzare gli antropologi in situazioni di conflitto, che si tratti di stati di guerra o “semplici” mediazioni sul piano civile?
Sono già state ideate applicazioni sul campo, come lo Human Terrain System, il programma dell’esercito statunitense per interagire più facilmente con le popolazioni locali in territori militarmente occupati di cui, tra gli altri, ha dissertato l’antropologo Nicola Perugini.
Ma si tratta di progetti che pongono seri problemi di etica professionale. Non a caso l’American Anthropological Association ha dovuto adottare una risoluzione al riguardo. Tuttavia non si può negare la necessità e l’importanza di interventi mirati ad esempio all’integrazione dei migranti o alla mediazione delle opportunità in una società che si reputi civile.
Un altro esempio: come evidenziato in questo post, gli avvocati sono professionisti che sentono la necessità di una conoscenza antropologica della mediazione, e che in mancanza di antropologi con una loro specifica professionalità, devono per forza di cose “arrangiarsi”. Sembra dunque che l’antropologia abbia un altro ambito di intervento e di “mercato”, come è possibile intervenire secondo voi?







Inviato il 12 ottobre a 08:39
OGGI IL MIO PENSIERO VA AL DISCERNIMENTO DELLE AZIONI CHE UOMINI E DONNE METTONO IN CAMPO QUOTIDIANAMENTE! OGGI PIU' CHE MAI SENTO QUANTO LE AZIONI NEGATIVE SONO POTENZIALMENTE IN GRADO DI MOLTIPLICARSI, MENTRE LE AZIONI POSITIVE POSSONO ESSERE DISTRUTTE DA MOLTE CIRCOSTANZE AVVERSE!MI VIENE DA RIFLETTERE SU QUANTO LA CUTURA INFLUISCA SUL BENESSERE PISCO-SOCIALE DELL'INDIVIDUO E DI UNA COMUNITA'..............??????????????????