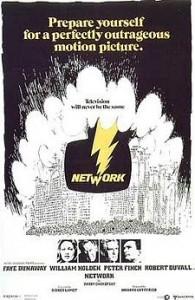Pubblicato da giovanniag su aprile 4, 2012
Riporto qui la versione completa di un saggio di Caterina Pardi su cinque grandi film del recente passato imperniato sul tema della televisione e della comunicazione. I cinque film sono stati oggetto di separati post sul blog Postpopuli.it.
—
Caterina Pardi
“Cinema e televisione — cinque film a confronto:
Quinto Potere, Oltre il giardino, Assassini nati, Da morire,
Good Night. And good luck.“
—
La televisione senza etica: Quinto Potere di S. Lumet
Dopo essere stato licenziato dalla rete Ubs a causa del crollo di ascolti del suo editoriale, il presentatore televisivo Howard Beale (Peter Finch) dichiara davanti alle telecamere di volersi suicidare in diretta. L’intervento crea scalpore e scandalo, facendo salire vertiginosamente l’indice d’ascolto della trasmissione. Beale, depresso ma in preda a una sorta di folgorazione, si sente investito di un ruolo messianico: parlare alla gente per mettere a nudo e denunciare le ipocrisie della società; i dirigenti della rete, presentendo la possibilità di accaparrarsi uno show di successo, decidono cinicamente di sfruttarlo cucendogli addosso l’immagine di “folle predicatore dell’etere” per poi, non appena l’indice di ascolto subisce un nuovo calo, sbarazzarsene “terminandolo” in diretta.
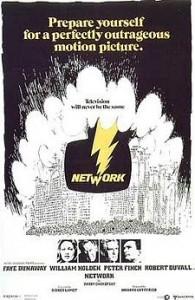
- Locandina del film (da wikipedia)
Con un’enfasi dai toni talvolta apocalittici, Quinto Potere (Network,1976) rivolge una critica impietosa al sistema delle grandi imprese di comunicazione. Mostro onnivoro che tutto fagocita, omogeneizza ed espelle, il sistema dei mass media appare come un potente strumento di manipolazione delle coscienze, di riproduzione del sistema costituito attraverso l’induzione di idee e desideri funzionali allo status quo.
Adorno e Horkheimer, nel loro più celebre libro, individuano nella televisione un incontrollabile e invincibile potere omologante, capace di erodere o disinnescare gli spazi informativi ed espressivi indipendenti, costituzionalmente allergico a ogni produzione libera e autonoma di significati; Quinto potere ci introduce nel luogo in cui tale processo di censura/assimilazione dell’Altro ha origine: la redazione di un importante telegiornale.
I dirigenti della Ubs, innescando un’escalation irreversibile di concessioni ad audience e profitto, subordinano consapevolmente la qualità della programmazione, sia da un punto di vista etico che estetico, ai loro interessi. Licenziato l’illuminato responsabile del reparto informazioni Max Shoemaker (William Holden), a prendere le redini del programma è la cinica Diana Christensen (Faye Dunaway) che, con la complicità del presidente della rete Frank Hackett (Robert Duvall), non esita a creare una sorta di telegiornale – spettacolo. Si tratta di un contenitore polimorfico nel quale, sotto il comune denominatore dell’entertainment, s’intrecciano inchiesta politica, oroscopo, documentario e varietà. E il giornalista Beale ne è il delirante anchor-man.
Ciò a cui si assiste si potrebbe definire, usando sempre attuali categorie habermasiane, una vera e propria presa di potere: la conquista di un’importante area del “mondo-della-vita”— quello dell’informazione — ad opera della “razionalità strumentale”, una modalità di agire – in origine propria solo dei “sottosistemi” economico e politico – che mira non all’autocomprensione della società, ma al convincimento e al conseguimento di interessi economici e politici particolari. Il termine “mondo-della-vita” indica “l’insieme di linguaggio, conoscenze, concezioni tramite cui capiamo il mondo e da cui, attivandole come motivazioni e forme comunicative, traiamo gli orientamenti per la nostra vita di tutti giorni”.

Quinto potere (qui a destra Peter Finch in una scena del film, foto Wikipedia) ci mostra come nella comunicazione mediatica la rappresentazione di un fatto non sia più legata alla verità e alla profondità delle interpretazioni formulate dal giornalista, libere da istanze di dominio, secondo le norme della “razionalità comunicativa” (che prescrivono la priorità dell’argomentazione razionale) ma ad intenti manipolatori e persuasivi realizzati attraverso processi di narrativizzazione e spettacolarizzazione della notizia.
Non solo. L’indifferenza (e insofferenza) del sistema televisivo alle necessità comunicative può essere rilevata e criticata pubblicamente senza che esso ne esca minimamente intaccato: le “idee sovversive” del “folle predicatore dell’etere” Howard Beale vengono riassorbite senza danno dall’organizzazione; la ribellione dei telespettatori sotto l’unico grido “Sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più” diventa nient’altro che un tormentone televisivo. Per Marcuse il sistema dei media ha acquisito la capacità di riassorbire le forme culturali che gli si oppongono:
Con la sua graduale scomparsa, il Grande Rifiuto viene a sua volta rifiutato: “l’altra dimensione” viene assorbita nello stato di cose prevalente. Le opere nate dalla condizione alienata (in questo caso si parla di alienazione artistica) sono incorporate in questa società e circolano come parte integrante dell’attrezzatura che adorna lo stato di cose prevalente e ne illustra la psicologia. Esse diventano in tal modo strumenti pubblicitari — servono a vendere, a confortare o a eccitare.
L’idea che ogni forma di arte e di critica sia destinata a essere inglobata e in qualche modo “neutralizzata” dal sistema oggi andrebbe forse mitigata, non estesa all’intero sistema delle comunicazioni – radicalmente mutato dai tempi in cui il fondamentale volume di Marcuse vide la luce – tuttavia è perfettamente idonea a descrivere il precedente regime; essa costituisce un utile riferimento nell’analisi di Quinto potere, che pare evidentemente condensare quelle preoccupazioni. Preoccupazioni che si riattualizzano ogni volta che una forza, pubblica o privata, sembra intervenire a limitare o asservire un libero territorio — come accade anche oggi per la rete, sempre vigile nell’individuare i tentativi di ridimensionare le possibilità comunicative e informative degli utenti e la tendenza a sfruttare i contenuti condivisi a fini di marketing.
Quando Howard Beale dichiara in diretta televisiva l’intenzione di suicidarsi, i dirigenti del network, in preda al panico, temono inizialmente di subire forti ripercussioni, di essere sanzionati dal pubblico e dalla Federal Communication Commission. Invece l’intervento di Beale si rivela una miniera di ascolti e i dirigenti, anziché licenziarlo, decidono di creare un programma basato sulle sue esternazioni. Il flusso televisivo è talmente “vischioso” che persino un gruppo terroristico può tranquillamente venire a fare parte della sua indiscernente trama.
Il film è efficace nel mostrare come una violazione del codice etico e del buon gusto in nome del denaro e del successo possa provocare un “effetto domino”, generandone un’altra e poi un’altra ancora. Un esempio analogo, in salsa repubblica delle banane, sono le nostre televisioni, pubbliche e private, durante il periodo berlusconiano, che ha generato una crescente irreperibilità nel flusso televisivo delle categorie del giusto e dell’ingiusto, del vero e del falso.
Tuttavia, sottolineando anche il problema del “corretto uso”, rimandando quindi agli individui la responsabilità del prodotto culturale-comunicativo si scongiura una condanna “ontologica” del mezzo. Il secondo film che andremo ad analizzare amplia ulteriormente le speranze in questo senso.
—
Idealtipo di un reporter: Good Night, and Good Luck, di George Clooney

- La locandina del film (da Wikipedia)
Edward R. Murrow, illuminato anchorman della Cbs (interpretato da David Strathairn), fu responsabile autore (insieme a Dan Rather e Walter Cronkite durante il Vietnam ed il Watergate) di una rivoluzione nel campo dell’etica giornalistica e del linguaggio della comunicazione. Prendendo spunto dalla presentazione del caso di Milo Radulovich, tenente di riserva dell’Aeronautica Usa allontanato per sospette frequentazioni comuniste (del padre!), Murrow sferrò un deciso attacco ai metodi autoritari e anticostituzionali del senatore Mc Carthy. Gli effetti della sua opposizione mediatica furono immediati, dimostrando ancora una volta al mondo le potenzialità del medium televisivo.
Perché raccontare la vicenda di Edward R. Murrow e ritornare nell’America postbellica contagiata dalla paranoia comunista? La scelta di quello specifico periodo della storia dei media e della figura di Murrow non appare casuale, né tanto meno dettata da una semplice preferenza degli autori. Come sostiene Ortoleva, proprio nel periodo a cavallo fra gli anni ’50 e ’60 (epoca del cosiddetto “sistema dei network”) ha inizio quel processo di autoconsapevolezza che consente oggi di considerare (e studiare) i media come struttura complessa ed autonoma, dotata di caratteristiche e poteri propri.
Gli autori sembrano aver sentito la necessità di risvegliare questa consapevolezza, forse oggi troppo spesso offuscata, di ricordare al pubblico cos’è/cosa è stata/cosa potrebbe essere (se lo vogliamo) la televisione e chi sono gli autentici giornalisti. Lo fa in bianco e nero, epicamente ma senza enfasi: il diligente e prudente lavoro del celebre protagonista è quello che dovrebbe svolgere ogni cronista responsabile: se diventa eroico è perché il sistema che lo circonda risulta distorto dalla censura ideologica e dalla propaganda pubblicitaria. Prima ragione.
Siamo anche nel periodo in cui la Ampex lancia il videoregistratore magnetico, consentendo la nascita di un archivio delle trasmissioni via etere. L’attività giornalistica, come vediamo nel film, si serve di filmati (i processi intentati da Mc Carthy, i suoi discorsi pubblici), ma è destinata a diventare essa stessa testimonianza, come ci avverte il profetico Murrow:
“se ci saranno storici che fra 50 o 100 anni vedranno le registrazioni settimanali dei nostri tre network, si troveranno di fronte a immagini in bianco e nero e a colori, prove della decadenza, della vacuità e dell’isolamento dalle realtà del mondo in cui viviamo”.
Come essi costituiscono una testimonianza storica per noi spettatori – ci vuol ricordare Clooney -, così i servizi del telegiornale di oggi potranno servire ai posteri per giudicare la nostra epoca.
Ma qual è il ruolo del reporter? A che principi deve attenersi? Completezza, onestà e soprattutto obiettività, che non significano tuttavia assenza di punto di vista.
Il termine obiettività ha il merito di sottolineare sia l’inevitabile focalizzazione da parte del soggetto, sia la volontà di svincolarsi da deformazioni non pertinenti. Se, da una parte, mostrare entrambe le parti di una controversia è garanzia di equidistanza, dall’altro non si può privare lo spettatore di una direzione interpretativa che lo aiuti a comprendere i fatti. Costituisce un’abdicazione da parte del giornalista.
Su questo argomento Good night. And Good Luck si schiera nettamente: dare un “taglio editoriale” è indispensabile, tanto più quando sono a rischio i diritti costituzionali. “Non posso accettare che per ogni storia ci siano due versioni ugualmente valide”, dice Murrow; allo stesso tempo il giornalista concede al senatore del Wisconsin lo spazio per replicare, conciliando così l’esigenza di rappresentare tutte le posizioni con quella di rivelare onestamente la propria opinione.
Più profondamente, al di sotto di questo primo, più esplicito, livello interpretativo (che emerge dai dialoghi e dalle azioni dei protagonisti), il film ci mostra come i media hanno trasformato la comunicazione, sia in ambito professionale che personale. Le inquadrature insistono sulla presenza continua, fuori e dentro lo studio Cbs, di schermi televisivi.

- David Strathairn nei panni di E. R. Murrow (da Wikipedia)
Persino i colleghi che circondano Murrow ascoltano le sue parole in modo mediato, i loro sguardi interagiscono con l’immagine del suo volto; anche se sono tutti lì – ognuno responsabile di un segmento della trasmissione (performance collettiva, dove ogni dettaglio è attentamente previsto, anche la penna che tocca il ginocchio del conduttore nell’istante in cui il programma va on air) – la loro attenzione è rivolta a un simulacro del loro leader.
Le relazioni più immediate, come l’amore, sono “proibite”: i due giornalisti legati dal vincolo matrimoniale vengono invitati a licenziarsi perché il regolamento vieta che tra colleghi si instaurino rapporti intimi. Schermi, vetri divisori, finestre, cornici di ogni genere s’interpongono fra i personaggi, denunciando esplicitamente la presenza di filtri percettivi ed interpretativi artificiali (per dirla con De Sola Pool) o protesi dei sensi (Mc Luhan).
La comunicazione non è più naturale, neppure tra vicini. La risposta alla frammentazione percettiva è l’instaurarsi di una rete di relazioni comunicative complesse fra primo piano e sfondo (frequente l’uso della sfocatura che sposta l’attenzione da un piano all’altro), fra individuo e gruppo (ritratti della redazione da prospettive difficili, non convenzionali, con i soggetti spesso divisi da fra loro da arredi e linee d’ombra), fra ribalta e retroscena, fra Storia e storie.
In uno scenario comunicativo così articolato, il ricevente conta quanto e forse più dell’emittente (pensiamo ai ritratti pensosi e attenti dei cronisti, rappresentati non solo in fase “emittente/espressiva” ma anche “ricevente/ricettiva”), e la qualità dell’ascolto (dell’individuo come del pubblico) diventa capitale.
Forti sono i valori umani, i principi etici che rendono compatto il gruppo dei giornalisti, simile a un organismo nel quale ogni componente mantiene la propria unicità (anche all’usciere è dedicata un’inquadratura), ma converge verso un obiettivo comune: quest’insieme di valori e principi (diametralmente opposto a quello di Quinto potere) costituisce il “medium dei medium”, un filtro di ordine superiore a tutti gli altri di tipo tecnologico od organizzativo.
—
Il discorso televisivo: Oltre il giardino di H. Ashby

- La locandina del film (da Wikipedia)
Oltre il giardino (Being there, 1979) di Hal Ashby, è una sottile satira della società americana, intrisa di cultura televisiva a tal punto da cadere in pericolosi cortocircuiti comunicativi.
Chance (Peter Sellers), un giardiniere minorato e analfabeta che non ha mai messo piede oltre il microcosmo della casa natale, dopo la morte del proprietario è costretto ad abbandonarlo e ad entrare per la prima volta in contatto con il mondo esterno. Nonostante sia un folle disadattato, grazie alla sua aria da distinto gentiluomo e a una provvidenziale catena di “equivoci verbali”, si integra facilmente nella high-class americana fino a diventare amico di Benjamin Rand (Melvyn Douglas), un potente uomo d’affari e amico intimo del Presidente degli Stati Uniti (Jack Warden) e di sua moglie Eve (Shirley Maclaine). Sorprendentemente, riuscirà ad ottenere la loro incondizionata fiducia e sostegno e a divenire un importante personaggio del mondo della politica e dell’economia.
Una buona metafora per definire la mente di Chance, ‘giardiniere’, protagonista della famosa ‘commedia’ di Ashby, è quella della tabula rasa, con una particolarità: su di essa non è l’esperienza in generale a incidere i suoi segni, ma un unico (e pericoloso) veicolo percettivo: quello televisivo; la conoscenza che ha del mondo è sempre stata filtrata dal tubo catodico e — in questo il geniale paradosso — continua ad esserlo quando esce dal microcosmo in cui è nato e cresciuto ed entra in contatto con la realtà esterna.
Chance esplora l’ambiente come se si trattasse un palinsesto televisivo, credendo di attraversare una successione di scene e situazioni (1) uguali a quelle che si vedono sul piccolo schermo (2) e agendo secondo gli schemi comportamentali da esse prescritti. Il suo principale polo d’attrazione rimane sempre la televisione, anche quando la sua nuova vita ha inizio: nessun incontro, nessun evento reale lo interessa e provoca in lui reazioni attive, fatta eccezione per le immagini, suo unico input.
Chance rappresenta una caricatura di quello che Sartori definisce “homo videns”: un individuo creato dalla televisione, antropologicamente diverso, che facendo esperienza del mondo solo attraverso le immagini non ha acquisito la capacità di astrazione né quella di rappresentazione verbale. Si tratta di una figura-limite, atta ad inquadrare il problema della dialettica fra visivo e discorsivo, fra iconico e verbale, che possono armonizzarsi ma anche confliggere.
Secondo Sartori, “nella televisione il vedere prevale sul parlare, nel senso che la voce in campo, o di un parlante, è secondaria, sta in funzione dell’immagine. Ne consegue che il telespettatore “è più un animale vedente che non un animale simbolico” (3). Secondo questa posizione, per certi aspetti radicale ma capace di individuare una tendenza di certa TV, dal dominio delle immagini sullo spazio mentale discenderebbe un impoverimento delle capacità argomentative, proprio come nel caso limite di Chance (4).

- Peter Sellers nei panni di Chance (da generationfilm.wordpress.com)
Ingenuo e sprovveduto – l’unico argomento di conversazione che conosce è il giardinaggio – si rivolge agli altri solo se interrogato, dà risposte del tutto ovvie e mimetiche rispetto a ciò che fanno e dicono i suoi interlocutori, imita in modo automatico i comportamenti che vede sullo schermo dando vita a gag tragicomiche delle quali solo noi spettatori siamo coscienti.
Nonostante la loro inconsistenza, e indipendentemente dalle intenzioni illocutive dell’ingenuo personaggio, gli atteggiamenti e le parole di Chance “funzionano” poiché sottoposti ad una continua decodifica aberrante: osservazioni letterali sulla cura del giardino sono scambiate dai personaggi che Chance ‘giardiniere’ incontra (Presidente degli Stati Uniti compreso) per profonde metafore sulla guida dello Stato, i suoi silenzi come la manifestazione di una superiore saggezza, la sua anaffettiva indifferenza verso qualunque avvenimento come eccezionale capacità di controllare le emozioni.
Più diventa una figura pubblica, più la leggenda su di lui si arricchisce di particolari inventati, trasformandolo in uomo dalle eccezionali doti umane e intellettuali. Mettendo alla berlina il mito americano del self-made-man, Ashby mostra come la televisione, amplificando le false credenze del potente Benjamin e di sua moglie, sia in grado di trasformare un analfabeta naïf in filosofo e importante figura pubblica.
La performance di Chance all’interno di un talk-show evoca quei vuoti interventi politici che, trovando il loro unico sostegno nella retorica dell’audiovisivo, occultano l’evento oggetto di discussione anziché porsi come filtro interpretativo fra il pubblico ed esso. La satira di Ashby si scaglia contro la trasformazione del dibattito politico operata dal medium televisivo, che spettacolarizza e riduce lo scambio di opinioni a un insieme di formule prive di contenuto e strumentalmente orientate alla seduzione e al consenso, anziché alla comprensione.
Essa sottolinea come il mezzo televisivo sia capace di imporre alla realtà una modalità interpretativa che non trova in essa alcuna giustificazione, ma che si radica in una pratica discorsiva. Come sostiene Bettetini, “le opinioni, le credenze e le abitudini discorsive producono un modello di verosimiglianza che a sua volta dà origine ad un complesso di regole del discorso audiovisivo: si tratta di regole attente all’effetto di verosimiglianza, finalizzate alla sola riproduzione del sistema nel quale si identifica la doxa (o consensus gentium) di un certo contesto sociale” (5).
La rappresentazione audiovisiva si fonda cioè su un sistema logico-retorico, un insieme di norme che stabilisce che cosa sia o meno verosimile (e di conseguenza credibile), ma tale struttura è nella maggior parte dei casi occultata dalla natura fattuale, “evidente” del significante, che maschera l’attività espressiva del mezzo dando l’illusione di una sua neutralità. Chance, in questo senso, è per gli altri come la televisione: non “ricama con le parole”, è “pane al pane” e, ciò che più conta, ha la grande dote di “essere naturale”.
La società descritta da Ashby è talmente abituata al filtro retorico della televisione, lo ha interiorizzato così profondamente, che lo percepisce come “naturale” e “vero”: a Chance, completamente inconsapevole del senso di ciò che lo circonda, ma ciecamente obbediente alle convenzioni retoriche della tv e a una logica naïf che assomiglia ad esse, è destinato un futuro luminoso: tutti credono in lui e in ciò che dice, tutti lo stimano. Egli è una forma vuota, sull’elementarità di ciò che dice ciascuno può proiettare il significato che vuole, e con esso anche i propri bisogni e desideri.

- Chance che cammina sull’acqua (da paperblog.com)
In questo senso è anche, paradossalmente, una figura poetica, poiché il suo candore si contrappone alla mentalità razionale e opportunista degli altri personaggi. Nel suo ‘esserci-per-gli-altri’, lasciarsi definire, plasmare, creare dagli altri, Chance (che in lingua inglese significa “Caso”) incarna quasi una forma di santità, rivelata solo dalla scena finale in cui lo vediamo camminare sulle acque di un lago. In un mondo dominato dalla razionalità strumentale le parole di un idiota o di un folle possono nascondere messaggi divini, al di là di ogni giudizio o errata decodifica.
Note:
(1) Celebre la scena in cui, minacciato da una banda di teppisti, estrae il telecomando per sfuggirgli.
(2) Infatti ogni volta che si imbatte in qualcosa che non ha mai visto in tv o ha visto sotto una prospettiva diversa, rimane sorpreso.
(3) Cfr. G. Sartori, Homo videns, Laterza, Bari 1997, cit. da F. Gusmano in Immagini della TV. Breve analisi della comunicazione televisiva su http://mondodomani.org/dialegesthai/fg01.htm#rif6.
(4) Una frase che Chance ripete spesso, dando luogo a fraintendimenti, è “a me piace guardare”.
(5) G.Bettetini, L’occhio in vendita, Marsilio Editori, Venezia 1985, p.67.
—
Flusso e pulsione: Assassini nati di O. Stone
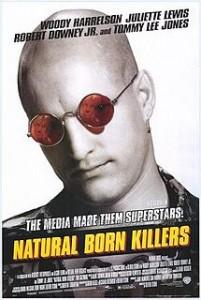
- La locandina
Assassini nati (Natural born killers, Usa 1994, regia di Oliver Stone) è la storia di Mickey (Woody Harrelson) e Mallory Knox (Juliette Lewis), due giovani killer che viaggiano sulle strade del New Mexico seminando paura e morte per puro divertimento. Due creature lanciate a tutta velocità in una dimensione ipermediata e pulsionale, in cui immagini televisive e “realtà” – costantemente accostate, sovrapposte, ibridate – sono ormai indistinguibili.
Stone mescola bianconero, colore, superotto, video, usa velocità diverse rallentate o accelerate; adopera immagini deformate, sovrapposte, in negativo, alterate da filtri ed effetti di ogni tipo; mette insieme frammenti di programmi televisivi (fra cui una geniale sit-com d’orrore domestico), di film, videoclip, cartoni animati, documentari di animali selvaggi.
Questa forsennata e caotica accumulazione visuale rappresenta un risultato estremo dell’espressione dominante della tv americana; ciò che Williams definisce flusso (flow): l’assenza di cesure tra stili, generi e registri veicolati dal medium televisivo e il conseguente sincretismo dell’esperienza che esso veicola.
Dice il sociologo americano: “La differenza del broadcasting rispetto a questi altri sistemi di comunicazione (libro, pamphlet, riunione, commedia) non sta soltanto nel fatto che tali eventi o altri analoghi siano accessibili da casa, premendo un pulsante; ma nel fatto che l’effettivo programma offerto consiste in una sequenza o in un insieme di sequenze alternative di questi o di altri eventi simili, fruibili nella stessa unità spazio temporale e attraverso un’unica operazione”.
La televisione, spiega già nel 1976 Williams, ha abbandonato la programmazione tradizionale, quella dei formati e dei generi distinti e riconoscibili, innescando un processo di ibridazione e frammentazione sotto il comune denominatore dell’entertaiment e della pubblicità.
L’uso del telecomando ha contribuito a determinare questa tendenza: l’autonomia di senso di ciascun frammento narrativo ha infatti, come conseguenza, la possibilità di un’immediata comprensione in grado di catturare l’attenzione dei telespettatori nel corso dello zapping.
Assassini nati non è, banalmente, un film “sull’influenza della violenza televisiva sulle giovani menti”; il suo discorso si estende sul “modo” piuttosto che sui contenuti attraverso cui quel medium rappresenta. Trasformandolo nel proprio strumento espressivo, riesce a cogliere l’essenza inquietante e distruttiva del flow televisivo: sotto e attraverso il flusso d’immagini frenetiche, ribolle e si esprime una dimensione primitiva, indifferente a ogni istanza etica o normativa; qualcosa di molto vicino a ciò che Deleuze definisce mondo originario.
È il mondo delle pulsioni - semplici, come quella omicida e sessuale che guida i protagonisti, ma anche complesse come il sadomasochismo, il parassitismo e l’ossessione per le immagini del cronista Wayne Gale (Robert Downey Jr.).
Ed è il mondo dei pezzi, oggetti parziali o feticci (di carne, cibo, accessori di ogni tipo) verso i quali le pulsioni vanno ad indirizzarsi. Scrive Deleuze: “Il mondo originario non esiste indipendentemente dall’ambiente storico e geografico (ambiente derivato) che gli serve da medium (…) esiste e opera soltanto in fondo a tale ambiente, di cui rivela la violenza e la crudeltà”. Ancora: “è il mondo che si rivela in fondo agli ambienti sociali”.

- Oliver Stone
La particolarità di Assassini Nati è che l’ambiente derivato, attraverso il quale tali pulsioni si esprimono, è puramente mediatico. E gli animali umani, i “predatori” che si muovono al suo interno come in uno spazio naturale, non sono solo Mickey e Mallory Knox: tutti i personaggi (criminali, uomini di legge, giornalisti ed anche le stesse vittime) si rendono artefici della medesima opera di degradazione, mossi dalla stessa pulsione violenta che “esaurisce” l’ambiente facendolo a pezzi, che lacera i corpi, distrugge oggetti e spazi, frammenta e rende ingestibile la visione.
Tale processo avviene all’interno e tramite il flusso televisivo, attraverso il quale si esprimono le pulsioni di morte dell’”animale umano” e che tende – esso stesso – a diventare accumulo di pezzi e feticci, prodotto informe di una pulsione che “lacera, dilania, disarticola” le immagini. Veicolo del processo entropico sono la ripetizione di immagini e la violenza ritualizzata, che neutralizzano ogni istanza critica ed etica, creando una sorta di “regno primordiale” (ma potrebbe essere anche uno stato apocalittico, finale) delle immagini. L’occhio del telespettatore trova una forma di illusorio appagamento in questo perpetuo e gratuito laceramento/interruzione/smembramento della visione, del senso, del pensiero.
I protagonisti non sono dei “ribelli contro il sistema”; al contrario ne fanno profondamente parte e sembrano incarnare un modello estremo di incoscienza consumistica e di istinto distruttivo. Il loro comportamento rappresenta forse un esito estremo di quella che negli anni ’60 Marcuse definiva magistralmente desublimazione repressiva:
“La gamma delle soddisfazioni socialmente permesse e desiderabili è stata molto ampliata, ma per loro tramite il principio del piacere viene ridotto, privato delle istanze irreconciliabili con la società stabilita. Grazie a questo processo di adattamento il piacere genera sottomissione. In contrasto con i piaceri della desublimazione ben adattata, la sublimazione conserva la coscienza delle rinunce cui la società repressiva costringe l’individuo, e per tal via conserva il bisogno di liberazione (…). È vero che ogni sublimazione è imposta dal potere della società, ma la coscienza infelice di questo potere già trapela attraverso l’alienazione (…) al contrario la perdita di coscienza dovuta alle libertà concesse da una società non libera dà origine a una coscienza felice che facilità l’accettazione dei misfatti di questa società. È un indice di declino dell’autonomia e della comprensione. La sublimazione richiede un alto grado di autonomia e di comprensione, essendo una mediazione fra conscio e inconscio, tra processi primari e processi secondari, fra l’intelletto e l’istinto, tra la rinuncia e la ribellione. Nelle sue forme più compiute come nell’opera artistica, la sublimazione diventa il potere cognitivo che sconfigge le forze repressive nel mentre cede ad esse. (…) Tale desublimazione sarebbe affatto compatibile con forme di aggressività sia sublimate che non sublimate. Queste ultime predominano in tutta la società industrializzata contemporanea.”
[Le foto sono tratte da Wikipedia (n.d.c.)]
—
L’iperrealtà televisiva: Da morire di Gus van Sant
 Da morire (To Die For, Usa 1995), commedia nera firmata Gus van Sant, ci dice, col suo registro radicale e spiazzante, cose molto interessanti sull’influenza dell’informazione e della comunicazione mediatica sulla vita degli americani.
Da morire (To Die For, Usa 1995), commedia nera firmata Gus van Sant, ci dice, col suo registro radicale e spiazzante, cose molto interessanti sull’influenza dell’informazione e della comunicazione mediatica sulla vita degli americani.
Solo degli americani?
Per Suzanne Stone (Nicole Kidman) diventare una famosa giornalista televisiva o, per meglio dire, apparire in video, è un’ossessione fin dall’infanzia.
Pur di raggiungere il suo obiettivo, la diabolica bionda non esita a prostituirsi, plagiare alcuni giovani emarginati, commissionare loro l’omicidio dell’ingenuo marito Larry (Matt Dillon), colpevole solo di ostacolare la sua carriera. Glaciale androide a caccia di successo, la protagonista è un personaggio non molto distante dalla Diana Christensen di Quinto Potere.
La sua filosofia può essere condensata nel motto «Appaio quindi sono».
Da morire si dipana come un lungo patchwork di interviste – quelle all’interno della trasmissione The Laura Show - e di autointerviste, che la protagonista stessa registra su videotape; la testimonianza di ogni personaggio contribuisce a ricostruire il medesimo evento, come accade durante le trasmissioni di infotainment e nei documentari.
Trascinate all’interno del flusso delle immagini televisive, realtà, ricordo e immaginazione si confondono, rendendo difficile la comprensione dell’accaduto. Secondo Baudrillard la televisione crea una iperrealtà o neorealtà che non ha più rapporto con un referente reale o con una realtà originale e, in questo senso, non è né vera né falsa rispetto a qualcosa che la precede. Solo successivamente, quando la quotidianità comincia a imitare i modelli televisivi, il messaggio mediatico diventa vero, o per meglio dire si autoavvera.
Suzanne, con il suo desiderio ossessivo di apparire e controllare, rappresenta il tentativo estremo di fare della vita una simulazione: il suo obiettivo è costruire un sistema di segni privo di contraddizioni e ambiguità, manipolare la realtà come fosse materia di immagini – controllandola e montandola a sua scelta.
Recita il Suzanne-pensiero: «Non sei nessuno in America se non appari in tv. È in tv che capiamo chi realmente siamo. Perché a che serve fare qualcosa che vale, se nessuno ti guarda? E, se il pubblico ti guarda, diventi una persona migliore». Per lei esistenza e identità acquistano valore e verità esclusivamente all’atto di apparire, nel momento in cui sono certificate dallo sguardo dell’altro.
Come sostiene Morsiani «eventi, spazi e memorie sono abilitati nella sola dimensione dell’informazione», e in ciò risiede la ‘pornografia’ delle immagini: il medium televisivo scompone la realtà fino a ridurla a una distesa di pixel asignificante, a puro codice. Allora «il primo piano di un volto, anche quello televisivo della bella Nicole Kidman, può diventare altrettanto osceno di un sesso visto da vicino».

- Nicole Kidman in una scena del film (da delcinema.it)
Suzanne ricorre alla menzogna, al tradimento, al delitto, allo scandalo, e lo fa senza dubbi né esitazioni, tale è la necessità di esistere all’interno di questa iperrealtà, per lei l’unica realtà. Il regista riproduce il continuo intervento manipolativo sia da parte della macchina da presa (la struttura del film denuncia continuamente il testo-cinema, e insistite sono le marche dell’enunciazione), sia da parte della protagonista (l’occhio gelido della telecamera mima quello di Suzanne e viceversa).
Eloquente, a questo proposito, la scena in cui la soggettiva di Suzanne sul volto del marito Larry si restringe con il procedimento dell’iride, proprio come se il suo sguardo avesse le capacità tecniche di una videocamera.
Non a caso il film si apre con questa sua dichiarazione: «Ecco quello che ho scoperto: tutta la vita è un processo di apprendimento. Ogni dettaglio fa parte di un grande disegno complessivo. Certe volte è difficile da decifrare, come quando ci si avvicina troppo allo schermo: non si vede altro che una distesa di puntini. L’intera immagine non si vede finché non ci si allontana ma, una volta allontanati, tutto quanto è messo a fuoco».
Questo è precisamente il messaggio lanciato dalla protagonista: la realtà e la vita devono assumere la forma di un disegno, logico, coerente, nitido. Il problema è che il programma risulta completamente deprivato di due componenti fondamentali: l’amore e la verità.
Come sostiene Baudrillard, instaurando un sistema di scrittura/lettura coerente «si impone lui, il medium, come messaggio, secondo l’espressione di Mc Luhan (…)». Per il sociologo francese, in tale contesto il problema della veridicità si rivela improprio, poiché l’iperrealtà televisiva è, per usare le sue parole, «al di là del vero e del falso»: il messaggio non viene verificato in rapporto a un referente reale o a un originale, ma in rapporto al successivo adempimento, avveramento di ciò che inventa (una verità a posteriori).
È attraverso l’adesione dello spettatore che l’avvenimento narrato diventa reale, ovvero la vita quotidiana imita il modello televisivo.
Suzanne Stone persegue tale adempimento in modo estremo, plasmando la sua vita secondo la logica e i modelli televisivi, sacrificando alle immagini etica, verità, e, infine, la sua stessa carne – come da titolo. Non c’è sorte più appropriata per questa ‘bambola di ghiaccio’ che morire assiderata dietro un gelido schermo, restando per sempre prigioniera della sua immagine.
—
Bibliografia:
R. Barthes, Miti d’oggi, Lerici editori, Milano 1966.
G. Bettetini, L’occhio in vendita, Marsilio Editori, Venezia 1985.
J. Baudrillard, La società dei consumi, Il Mulino, Bologna 1976.
J. Baudrillard, Lo scambio simbolico e la morte, Feltrinelli, Milano 1979.
G. Deleuze, L’immagine – movimento, Ubulibri, Milano 2002.
J. Habermas, Teoria dell’agire comunicativo, Il Mulino, Bologna 1997.
M. Horkheimer,T.W. Adorno, Dialettica dell’illuminismo, Einaudi, Torino,1966.
H. Marcuse, L’uomo a una dimensione, Einaudi, Torino 1967(12ª edizione).
P. Mereghetti, Dizionario dei film 2004, Baldini Castoldi Dalai, Milano 2003.
A. Morsiani, Gus van Sant, Il Castoro, Venezia 2004.
P. Ortoleva, Mediastoria. Comunicazione e cambiamento sociale nel mondo contemporaneo, Il Saggiatore, Milano 2002.
G. Sartori, Homo videns, Laterza, Bari 1997, cit. da F. Gusmano in Immagini della TV.
Breve analisi della comunicazione televisiva sul sito: http://mondodomani.org/dialegesthai/fg01.htm#rif6.
U. Volli, Manuale di semiotica, Laterza, Bari 2000.
R. Williams, Televisione e forma culturale, Editori riuniti, Roma, 2000.