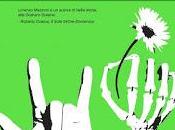Quali sono le cause del successo di una serie televisiva quando questa ha a che vedere con un gruppo di sopravvissuti in un mondo invaso dagli zombi?
Non essendone un appassionato – anzi, diciamolo apertamente, diciamolo chiaramente e subito, non sopportando né i morti viventi né la maggior parte dei film horror (altra cosa è a mio parere la letteratura dei Lovercraft, dei King, degli Shelly, dei Poe…) – la domanda non avrebbe alcuna ragione d’essere posta e, se proprio lo vogliamo, assumerebbe un qualche significato solo nell’ottica di un’analisi sociologica, o antropologica, o psicoanalitica, o che dir si voglia. Se alla fine mi sono deciso a scriverne, dunque, è per un’altro motivo.
Che nel pianeta dei sette miliardi di persone si siano tutti rimbecilliti non pare essere una spiegazione sufficiente a risolvere l’interrogativo (soprattutto quando si è divenuti a propria volta parte del campione preso in esame) e che sia stata un’abile opera di marketing a creare l’ennesimo fenomeno mediatico chiarisce i dettagli senza tuttavia soddisfare l’insieme. Più esauriente, senza dubbio, è l’idea secondo la quale il mondo abbia un inconscio, e questo inconscio si esprima in varie forme (una fra tutte la fiction, qualunque sia il significato che vogliamo dare a tale parola) e che nell’esprimersi, l’inconscio finisca per venir nutrito e a sua volta nutrire tutto ciò che l’uomo coscientemente produce o ha prodotto. Tutto vero, certo. Nondimeno resto dell’opinione che non esista ‘spiegazione’ che spieghi veramente un bel nulla, e che addentrarsi nelle profondità delle Teorie senza dare per scontata la certezza quasi matematica di perdersi, significherebbe prendersi gioco della bontà di chi ci sta leggendo (altra cosa su cui ho sempre avuto dubbi, la bontà di chi legge).
Nel suo “From Caligari to Hitler” Kracauer si prese la briga di analizzare la produzione cinematografica tedesca dal 1918 al 1933 arrivando a sostenere che il cinema (e oggi potremmo dire anche la televisione) nel mettere in luce il taciuto – il sotterraneo – di una società e di una cultura finisca per rappresentarne la mente collettiva.
Poco dopo però Sorlin lo smentì, difendendo addirittura la teoria opposta: ovvero che il cinema raffiguri solo ciò che una società reputa raffigurabile. Non l’inconscio quindi, ma la coscienza.
Vedete? Ho già cominciato a perdermi.
Ma insomma perché, pur ritenendo che la quotidiana fine del mondo a cui ogni giorno assistiamo debba già di per sé essere sufficiente a tenerci a debita distanza da zombi e storie catastrofiche, perché, dicevo, ho finito per venire a mia volta coinvolto nella visione di “The Walking Dead”?
La ragione è di natura puramente narrativa.
“The Walking Dead” è senza dubbio una serie televisva con molti limiti, qualche esagerazione e alcuni difetti. Le debolezze che la contraddistinguono (zombi che appaiono da un momento all’altro anche nel mezzo di spazi aperti, costringendo i vivi a fughe rocambolesche quanto evitabili, gruppi di sopravvissuti che abitano come se niente fosse in case di campagna in mezzo a boschi infestati da morti, frequenti sequenze il cui unico scopo è quello di tenerti attaccato allo schermo in attesa di un imprevisto che non sai se mai si verificherà…) sono state più volte messe in evidenza. Quello che mi pare in pochi abbiano davvero fatto è stato individuarne i punti di forza.
Al di là della qualità cinematografica delle puntate (aspetto che oramai molte produzioni televisive condividono) è la tensione il primo di questi punti.
Colloca infatti un gruppo di sopravvissuti in un contesto infestato da esseri che li vogliono divorare e non solo avrai creato i presupposti necessari a scatenare la scintilla di una possibile storia, ma avrai anche ottenuto tutta l’ansia necessaria a farla procedere. Se dietro ogni carcassa d’auto, se dietro ogni porta, se dietro ogni muro e dentro ogni casa si può nascondere uno zombi, è evidente che allo spettatore non sarà mai concesso di rilasciare la tensione. Ogni puntata di “The Walking Dead” è in questo senso un vero e proprio tour de force cardiocircolatorio, dove anche nei momenti di maggiore calma resta viva l’angoscia di quanto successo poco prima o di quanto succederà l’istante dopo.
Ma la tensione, da sola, non può più di tanto come ben sappiamo. E anzi, ha già dimostrato nel passato anche recente di non poter essere presa a garanzia di felice riuscita narrativa.
Il vero centro nervoso di “The Walking Dead” sta infatti in qualcos’altro (secondo punto): ovvero nel fatto che le situazioni ‘liminari’, che ci piaccia o meno, offrono da sempre la possibilità di sviluppare tematiche anche quotidiane, anche improbabili, anche profonde, anche importanti, anche difficili, con una libertà, anche etica, che le situazioni non-liminari raramente sanno offrire.
Per quanto sia chiaro a tutti che una passeggiata notturna in un bosco o in una città infestata da zombi sia già di per sé un elemento potenzialmente in grado d’inchiodare lo spettatore alla poltrona (la tensione, di nuovo: Hitchcock lo sapeva meglio di chiunque altro) sono le dinamiche interne a coloro che camminano, e le tematiche a questi correlate, i veri motori di una narrazione.
Dunque:
(Ri)colloca questo gruppo di sopravvissuti in un contesto abitato da esseri che li vogliono divorare, e fai in modo che tali esseri siano i rimasugli di un’umanità devastata, ridotta allo stato larvale da un agente/virus sconosciuto. Aggiungi la memoria, il ricordo del mondo com’era, la perdità d’identità, i timori per il futuro e il barlume di qualcosa di umano da far sopravvivere malgrado la disumanità di cui ancora si può essere a propria volta capaci. Inserisci le grandi domande sull’esistenza di Dio, sul senso dell’essere in vita, sul diritto a scegliere la propria morte, sul giudizio nei confronti della propria specie e sulle difficili decisioni da prendere per il bene di chi ancora si ama (in primo luogo, ahimé, se stessi). Mantieni il tutto in un equilibrio instabile, evitando che qualche ingrediente sfugga troppo al controllo e prenda il sopravvento sugli altri, e lascia che sia la tensione, appunto, ad amalgamare il resto.
Se è vero che “The Walking Dead” è una serie televisiva sotto certi aspetti stereotipata, o comunque destinata a un vasto e indiscriminato consumo di massa, è anche vero che l’intero nucleo tematico intorno al quale ruota non sono, come si potrebbe inizialmente pensare, gli zombi, ma tutta una serie di problemi etici che la loro presenza ha scatenato.
Il finale della terza puntata della seconda serie è in questo senso emblematica.
La tensione assicurata dalla presenza degli zombi (sia che ci siano sia che non ci siano lei è sempre lì, pensate a cosa fece Spielberg con “Lo squalo”) si intreccia durante la narrazione a personaggi differenti e a tematiche differenti, ma che in una maniera o nell’altra ruotano attorno al medesimo nucleo problematico: il binomio vita/morte.
Senza voler fare qui alcuno spoil, le ultime sequenze di questa puntata sono un intensissimo contraddittorio di emozioni, un crescendo di pulsioni contrastanti, dove categorie morali date per assodate si ribaltano, e altre considerate perse vengono ricostruite, e dove il climax si scioglie in qualcosa di più spiazzante, di più intimamente terrificante, qualcosa che pone lo spettatore, nessuno escluso, davanti al dilemma centrale di ogni narrazione di questo tipo: “dove sta il limite tra sopravvivenza e umanità?” “E cosa si può davvero diventare (in cosa ci si può davvero trasformare) se costretti, in situazioni liminari?”
Chiunque combatta mostri deve stare attento a non diventarne uno lui stesso scrive Nietzsche, e mi pare che al di là di tutte le stupidaggini da zombi e della generale atmosfera da entertainment che la contraddistingue, è in questa affermazione che vada ricercata la linea narrativa portante di “The Walking Dead”. (Terzo punto: le domande a cui lo spettatore si trova giocoforza costretto a rispondere).
Se il Duemila si è aperto in maniera inquietantemente simbolica con due torri che crollavano, il Novecento (questo secolo di cui tutti hanno parlato e di cui pare che tutto sia stato detto) è trascorso e si è concluso facendo qualcosa di gigantesco e terribile, di cui in pochi sembrano essersi ancora accorti:
ha riportato nell’uomo la paura della propria fine.
E lo ha fatto in maniera tale da lasciarcela a lungo.
In un mondo di robot che cominciano anche a servire ai tavoli, di virus che ciclicamente appaiono e scompaiono, di cataclismi naturali, di inquinamento, di sovraproduzione e d’inarrestabile e sempre più distinguibile sovrapopolazione, tale ‘paura’ significa in primo luogo coscienza inevitabile di una propria possibile estinzione.
“The Walking Dead” (e questo è il quarto punto) è forse il primo e al momento meglio riuscito esempio di una serie di narrazioni che in futuro saranno sempre più spesso incentrate su problematiche di sopravvivenza, come singoli e come specie.
Che si creda o meno a Kracauer, che si abbia o meno lo stomaco per farlo.
Chiunque combatta mostri deve stare attento a non diventarne uno lui stesso, certo. Ma occorre prima sconfiggere quelli che ci dormono dentro.
Filed under: Articoli Tagged: Matteo Telara, paura della fine, sopravvivenza, The Walking Dead