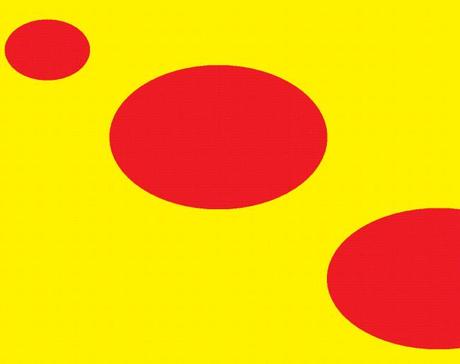
Mi innamoravo sempre delle bambine con le lentiggini. Ai miei occhi di alunno elementare, alto un metro e venti, le lentiggini rappresentavano un visibile segno di superiorità, di distinzione e di bellezza. E ancora non capisco il perché. Forse perché io non ne avevo. E si sa, spesso gli esseri umani sono attratti da ciò che non hanno o che non possono avere. La prima bambina che mi fece innamorare fu Roberta. Aveva le lentiggini. Era bellissima. Ballava danza classica e spesso i suoi capelli neri erano raccolti in uno chignon che le allungava il taglio d’occhi decisamente a mandorla e dal colore verde smeraldo. In realtà tutti i maschietti della mia classe ne erano innamorati. E anche quelli delle altre.
La mia scuola elementare, la scuola ‘Redentore’, era frequentata in larga parte da figli di operai, casalinghe e ferrovieri. Un quartiere popolare, vivo, divertente, soprattutto per un bambino. Far parte di quel gruppo di ragazzini aveva i suoi indiscutibili vantaggi: prima di tutto eravamo liberi. Liberi di scorrazzare per bande, inseguendoci per le strade sporche, tra le Giulietta, le Centoventisette e le Cinquecento parcheggiate per strada, dai paraurti taglienti che spesso sfregiavano i nostri arti inferiori nelle concitate rincorse a perdifiato. L’asfalto era il nostro parco giochi e la salvezza per mamme casalinghe stanche e provate nei mesi di vacanze estive. Ricordo lunghi pomeriggi vissuti in interminabili partite a calcio e a schiaccciate, prima che l’acido lattico facesse la comparsa nei nostri corpi, per ricordarci che ogni partita ha un termine e che per ogni sforzo fisico c’è un contraccambio di dolore e stanchezza.
Le mamme, le autoritarie e generose mamme del quartiere, quando la scuola finiva ci obbligavano a lasciare le case, ci spingevano ad uscire, ci cacciavano perché gli rendevamo il lavoro impossibile. Semplicemente, in casa non c’era spazio per tutti. Quasi tutti i miei piccoli amici di allora abitavano in case piccolissime e sovraffollate. A volte in strutture quasi fatiscenti. Bastava annusare – durante i corpo a corpo in classe – un maglioncino sintetico dell’epoca indossato da qualcuno dei miei compagni, per sentire l’odore dell’ umidità malsana dei loro appartamenti. Onore alle mamme casalinghe del quartiere: grazie a loro e ai loro piccoli e comprensibilissimi esaurimenti nervosi, abbiamo conosciuto subito il sapore della libertà, la gioia – invece che la paura – di stare per strada, la cattiveria e la bontà degli esseri umani, quando si finiva di fare a botte per riprendere a ridere e a giocare insieme, poco dopo.
In questo universo felice e spesso povero, una bambina come Roberta non poteva che diventare un simbolo: la speranza di un mondo più bello, più delicato, più spensierato e rilassato. Forse anche più ricco. Un’idea di bellezza e di eleganza. Quando mostrava i suoi passi di danza alla corte di amichette riunite attorno a lei, noi bambini restavamo incantati, perdutamente innamorati come solo allora è possibile, in una dimensione che travalica gli stessi concetti di purezza e peccato e le distinzioni tra amore fisico e spirituale. Per me era un sentimento nuovo e sconosciuto, incredibile, questa voglia di mettermi in mostra con lei, di distinguermi dagli altri per essere l’unico, il suo.
Era la più brava della classe, ovviamente. E quando decidevo di impegnarmi nello studio non lo facevo per la maestra o per far contenti i miei: lo facevo per lei, volevo raggiungerla. Ma c’era Carlo, Carletto: tanto bravo a scuola quanto poco abile nelle prove di forza, piccolo nerd dal volto alla Milhouse, povero bambino sfregiato dall’enorme montatura in osso dei suoi occhiali spessi. Dovrei chiedere scusa a quel bambino, ma - da bambino a bambino – lo detestavo. Perché era troppo buono, bravo e saggio e – cosa più importante – era il miglior amico di Roberta e studiava addirittura a casa con lei. Un giorno, mentre giocavamo, lo tirai dal braccio sulle mie spalle così forte da farlo precipitare violentemente di testa a terra. Pianse e si fece male, ma non protestò. La maestra vide tutto e mi tirò le orecchie. Ne fui profondamente offeso. Non lo avevo fatto intenzionalmente, ma lei non lo capì.
Adorai Roberta per cinque anni. Nel corso degli ultimi due feci di tutto per essere suo, perfino ballare, durante i piccoli party in casa, alcuni passi di break imparati malamente da un cugino. Dovetti contenderla per tutto questo periodo, in realtà, a Tonio, il biondo e Gianni, il bruno. Carlo era ormai fuori dal gioco, in quanto solo amico, o in fondo perché aveva già avuto il suo. Tonio era il più forte della classe, Gianni il più veloce. Ed io? Non lo so. Non lo so più e non lo so ancora. So solo che altre volte, nel corso della mia vita, sono stato attratto da ragazze con le lentiggini e che con alcune di loro ho trascorso bellissimi anni di amore. Forse, ho cercato Roberta per tutta la vita.
Ricordo che la baciai in un gioco tra bambini in cui tutti baciavano tutte. Raffinato escamotage infantile che riusciva ad aggirare tutte le gelosie. La amai fino all’ultima ora dell’ultimo giorno di scuola, quando le chiesi per l’ennesima volta chi preferisse tra me, Gianni e Tonio. Non ho mai capito, né mai saprò, se lo disse per togliersi dai piedi un piccolo stalker o perché lo sentiva veramente. Ma lei, finalmente, mi rispose sorridendo: “Tu”. Mi squagliai dalla gioia. E come Pinocchio alla fine della storia, il mio corpo di legno e di bimbo restò lì, in quell’aula baciata dall’amore e dalle lentiggini. E nacque quel ragazzo in carne ed ossa che, in fondo, sono ancora adesso.





