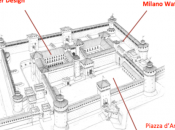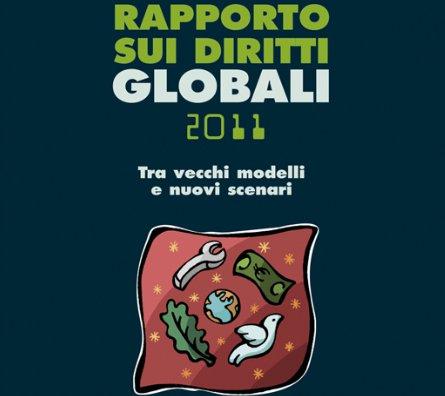 «Salvarsi dalla catastrofe è improbabile, perciò ci spero». Queste le parole del sociologo Edgar Morìn, su La Stampa dello scorso 27 marzo. Si potrebbe iniziare da questa frase per addentrarsi nel mondo sommerso che ogni tanto emerge, e presenta il conto. Venerdì 17 giugno i futuristici spazi della Triennale di Milano hanno ospitato la presentazione dell’edizione 2011 del Rapporto sui Diritti Globali, giunto alla sua nona edizione. Un progetto, prendendo le parole del curatore del volume e direttore di Associazione Società Informazione, Sergio Segio, «nato nel 2003 per iniziativa della Associazione Società Informazione Onlus, che da allora lo realizza attraverso la propria redazione. Un contributo di informazione, analisi, sintesi di dati, memoria e sguardo critico sul presente. Ma non solo: intende essere anche luogo, apporto a lavorare in rete, all’iniziativa comune attorno al tema della globalizzazione dei diritti. Nel corso degli anni, alla capofila CGIL, si sono così via via aggiunti: ActionAid, Antigone, ARCI, Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza (CNCA), Fondazione Basso-Sezione Internazionale, Forum Ambientalista, Gruppo Abele, Legambiente, Vita. Il nostro lavoro muove dalla considerazione che i diritti sono un sistema di vasi comunicanti, sono interdipendenti tra di loro. Diritti umani, diritti civili, diritti sociali, diritti politici, diritti ambientali sono intrecciati e complementari. Se compressi, violati e interrotti in un punto, è tutto l’insieme dei diritti a risultare compromesso». Un panorama profondamente segnato da questo periodo buio, che noi comunemente chiamiamo Crisi, con la maiuscola. Una maiuscola che serve a circoscrivere la gravità di una situazione che nei numeri appare disastrosa, molto più di quel che realmente ognuno di noi possa percepire raccogliendo informazioni dai canali comuni, come la televisione e la stampa. Una maiuscola che colora un quadro dai contorni estremamente preoccupanti. Nel gennaio 2009, al tramonto della disastrosa gestione Bush, il vice presidente Dick Cheney rispose così ad un giornalista che chiedeva il perché dell’inspiegabile noncuranza da parte dell’Amministrazione USA nel prevedere la maggior crisi finanziaria dal 1929: «Nessuno è stato così intelligente da capirlo, credo che nessuno se lo aspettasse». Si può facilmente dedurre quanto questa secca risposta riesca ad inquadrare i contorni del dramma più di un qualsiasi tedioso trattato politico ed economico. Una dichiarazione che fotografa alla perfezione quanto la miopia e l’irresponsabilità dei grandi centri mondiali siano stati i veri grandi “genitori” di questo disastro. Un disastro ampliamente annunciato sin dal 2006, quando l’economista Nouriel Roubini aveva già previsto il collasso di un’era, quella del liberismo sfrenato, giunta all’orlo del precipizio. Un dramma previsto ancor prima, da quel caldo 1999 nella piovosa Seattle, dove ebbe inizio il movimento che sfociò due anni dopo nelle tristi e note vicende del G8 genovese. Cassandre mai ascoltate con attenzione, e forse strumentalizzate a tal punto da farle passare addirittura dalla parte del torto. Già nel 2007 lo stesso Rapporto inquadrò lucidamente i prodromi del tristissimo biennio 2008-2009, che sta sfociando in uno strascico lungo e travagliato, un imbocco in un tunnel ove non si scorge neanche un bagliore di luce, nonostante gli iniziali scongiuri e sottovalutazioni (con assurdi picchi di “negazionismo”) dei governi mondiali. Gli stessi che ora si affannano, sudati ed impauriti, a tentare di tappare le falle del muro di cinta della diga. Una diga che rischia di travolgere tutto. Perché oggi, dopo tre anni dall’ufficiale inizio della crisi, capiamo che la Crisi è divenuta davvero maiuscola: non è più crisi finanziaria, non è più crisi economica. Ѐ Crisi politica, o ancor peggio, Crisi di sistema. Dunque, la corsa allo sviluppo ha fatto bancarotta fraudolenta. Già, ma chi la paga questa crisi? Quel che sconvolge, più delle parole, sono i numeri. Numeri che viaggiano a mo’ di matrioska russa, dimostrando quanto le scellerate decisioni attuate nel corso di questi ultimi anni dai “potentati” che dovrebbero essere garanzia di salvaguardia e salvezza per l’intera comunità globale, vadano invece ad incidere con effetti devastanti su qualsiasi contesto sociale, dalla piccola comunità a ciascuno Stato, fino ad arrivare a compromettere equilibri delicatissimi a livello planetario. Tra il 2007 e il 2009 le banche nel mondo hanno perso 851,6 miliardi di dollari (più della metà negli Stati Uniti), ma hanno ricevuto aiuti pubblici dai governi per ben 873 miliardi di dollari. Insomma, chi ha sbagliato non ha pagato. Anzi, paradossalmente ha accresciuto la sua posizione di egemonia. Il mercato finanziario è arrivato nel 2008 a un valore 14 volte superiore al Prodotto Interno Mondiale, mentre il volume delle transazioni finanziarie è addirittura superiore di 73 volte il PIL globale. Le istituzioni finanziarie però son riuscite, tramite una grande operazione di mistificazione delle responsabilità del tracollo, ad addebitare il tutto agli eccessi della spesa pubblica e ai sistemi di welfare. Oltretutto, con questa scelta nell’aiutare scelleratamente i responsabili anziché le vittime della crisi, l’effetto boomerang sugli Stati si è rivelato devastante: la speculazione ha quindi attaccato il delicatissimo mercato delle materie prime, e soprattutto i debiti sovrani, esponendo le nazioni più vulnerabili a tracolli senza precedenti. Falsa è però l’idea che questi (come la Grecia, o all’Irlanda) siano gli Stati con maggior debito pubblico. Se si pensa che da molti anni il triste primato di questa altrettanto triste graduatoria è tenuto dal Giappone e dagli USA, si evince con facilità che non è questione di debito pubblico, ma di importanza politica ed economica. Nessuno infatti si sognerebbe di attaccare gli USA come hanno fatto con Atene: gli Stati Uniti sono i maggiori alleati del mondo finanziario, sarebbe qualcosa di utopistico. Negli ultimi mesi abbiamo assistito alla cosiddetta primavera araba, coccolata dall’Occidente come simbolo di rivendicazione di libertà, mascherata però nei suoi lati più oscuri. Il malcontento nel Maghreb è infatti principalmente nato dalla “lotta per il pane” contro l’impoverimento crescente, dettata dal picco record raggiunto dai prezzi dei generi alimentari, nel gennaio 2011. Sono pochissimi i paesi che invece han deciso di sostenere la domanda interna e «promuovere la crescita partendo dal basso». Tra questi, Cina e Brasile che, guarda caso, rappresentano il modello di economia antagonista. Venendo al nostro orticello, quell’Italia che recentemente sta attraversando un periodo altamente sismico a livello politico ed economico, capiamo quanto sia stata dissennata la strategia interna per far fronte alla crisi: i dati ISTAT più recenti dicono che nel biennio 2009-2010 il numero di occupati è diminuito drasticamente: 532000 nuovi disoccupati, composti in larghissima parte (482.000, vale a dire il 90%) da giovani sotto i 30 anni. L’Italia è un paese che più di altri sta pagando il collasso planetario, pagando a caro prezzo un altissima disoccupazione giovanile, un ribasso drastico dei salari e una forte crescita della forbice sociale, tanto che l’ascensore sociale nel nostro paese ormai viaggia soltanto in discesa: basti pensare che dal 2008 al 2011 le voci di spesa sociale hanno avuto tagli complessivi del 78,7%, passando da 2.527 milioni di euro a 538 milioni. Tutto lascia presagire un aumento drastico della povertà, con dati che ci collocano tra gli ultimi posti in Europa. Questo può comportare la drastica conseguenza della guerra tra poveri, come dice Marco Revelli: «la riacquisizione dello status e autostima non può più passare attraverso la riduzione delle distanze dai primi, ma piuttosto per mezzo dell’ampliamento delle distanze dagli ultimi, spinti più giù, ai margini, se possibile “fuori”». Insomma, per salvare il sistema finanziario, voluto e imposto da direttive europee, si manda al macello lo stato sociale. E allora, ci si domanda se «il concetto di Europa sia davvero così indiscutibile, in un sistema che guarda solo allo specchio economico e non mostra di essere unito su tematiche sociali di vitale importanza, come quello dei migranti», come spiega Aldo Bonomi. «In un’ottica di cambiamento necessario, partendo dal basso, ci si deve interrogare se non sia il caso di preferire un ruolo di traino di un “secondo mondo” piuttosto che rincorrere affannosamente l’ultimo posto del mondo dei Grandi –continua Bonomi- imboccando una strada senza orizzonti e con moltissime difficoltà». Un cambiamento capace di emancipare il sociale, estraendolo dall’atavico contesto di soggezione dalla politica. Perché, in fondo, il sociale è la vita. Ed è a rischio estinzione.
«Salvarsi dalla catastrofe è improbabile, perciò ci spero». Queste le parole del sociologo Edgar Morìn, su La Stampa dello scorso 27 marzo. Si potrebbe iniziare da questa frase per addentrarsi nel mondo sommerso che ogni tanto emerge, e presenta il conto. Venerdì 17 giugno i futuristici spazi della Triennale di Milano hanno ospitato la presentazione dell’edizione 2011 del Rapporto sui Diritti Globali, giunto alla sua nona edizione. Un progetto, prendendo le parole del curatore del volume e direttore di Associazione Società Informazione, Sergio Segio, «nato nel 2003 per iniziativa della Associazione Società Informazione Onlus, che da allora lo realizza attraverso la propria redazione. Un contributo di informazione, analisi, sintesi di dati, memoria e sguardo critico sul presente. Ma non solo: intende essere anche luogo, apporto a lavorare in rete, all’iniziativa comune attorno al tema della globalizzazione dei diritti. Nel corso degli anni, alla capofila CGIL, si sono così via via aggiunti: ActionAid, Antigone, ARCI, Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza (CNCA), Fondazione Basso-Sezione Internazionale, Forum Ambientalista, Gruppo Abele, Legambiente, Vita. Il nostro lavoro muove dalla considerazione che i diritti sono un sistema di vasi comunicanti, sono interdipendenti tra di loro. Diritti umani, diritti civili, diritti sociali, diritti politici, diritti ambientali sono intrecciati e complementari. Se compressi, violati e interrotti in un punto, è tutto l’insieme dei diritti a risultare compromesso». Un panorama profondamente segnato da questo periodo buio, che noi comunemente chiamiamo Crisi, con la maiuscola. Una maiuscola che serve a circoscrivere la gravità di una situazione che nei numeri appare disastrosa, molto più di quel che realmente ognuno di noi possa percepire raccogliendo informazioni dai canali comuni, come la televisione e la stampa. Una maiuscola che colora un quadro dai contorni estremamente preoccupanti. Nel gennaio 2009, al tramonto della disastrosa gestione Bush, il vice presidente Dick Cheney rispose così ad un giornalista che chiedeva il perché dell’inspiegabile noncuranza da parte dell’Amministrazione USA nel prevedere la maggior crisi finanziaria dal 1929: «Nessuno è stato così intelligente da capirlo, credo che nessuno se lo aspettasse». Si può facilmente dedurre quanto questa secca risposta riesca ad inquadrare i contorni del dramma più di un qualsiasi tedioso trattato politico ed economico. Una dichiarazione che fotografa alla perfezione quanto la miopia e l’irresponsabilità dei grandi centri mondiali siano stati i veri grandi “genitori” di questo disastro. Un disastro ampliamente annunciato sin dal 2006, quando l’economista Nouriel Roubini aveva già previsto il collasso di un’era, quella del liberismo sfrenato, giunta all’orlo del precipizio. Un dramma previsto ancor prima, da quel caldo 1999 nella piovosa Seattle, dove ebbe inizio il movimento che sfociò due anni dopo nelle tristi e note vicende del G8 genovese. Cassandre mai ascoltate con attenzione, e forse strumentalizzate a tal punto da farle passare addirittura dalla parte del torto. Già nel 2007 lo stesso Rapporto inquadrò lucidamente i prodromi del tristissimo biennio 2008-2009, che sta sfociando in uno strascico lungo e travagliato, un imbocco in un tunnel ove non si scorge neanche un bagliore di luce, nonostante gli iniziali scongiuri e sottovalutazioni (con assurdi picchi di “negazionismo”) dei governi mondiali. Gli stessi che ora si affannano, sudati ed impauriti, a tentare di tappare le falle del muro di cinta della diga. Una diga che rischia di travolgere tutto. Perché oggi, dopo tre anni dall’ufficiale inizio della crisi, capiamo che la Crisi è divenuta davvero maiuscola: non è più crisi finanziaria, non è più crisi economica. Ѐ Crisi politica, o ancor peggio, Crisi di sistema. Dunque, la corsa allo sviluppo ha fatto bancarotta fraudolenta. Già, ma chi la paga questa crisi? Quel che sconvolge, più delle parole, sono i numeri. Numeri che viaggiano a mo’ di matrioska russa, dimostrando quanto le scellerate decisioni attuate nel corso di questi ultimi anni dai “potentati” che dovrebbero essere garanzia di salvaguardia e salvezza per l’intera comunità globale, vadano invece ad incidere con effetti devastanti su qualsiasi contesto sociale, dalla piccola comunità a ciascuno Stato, fino ad arrivare a compromettere equilibri delicatissimi a livello planetario. Tra il 2007 e il 2009 le banche nel mondo hanno perso 851,6 miliardi di dollari (più della metà negli Stati Uniti), ma hanno ricevuto aiuti pubblici dai governi per ben 873 miliardi di dollari. Insomma, chi ha sbagliato non ha pagato. Anzi, paradossalmente ha accresciuto la sua posizione di egemonia. Il mercato finanziario è arrivato nel 2008 a un valore 14 volte superiore al Prodotto Interno Mondiale, mentre il volume delle transazioni finanziarie è addirittura superiore di 73 volte il PIL globale. Le istituzioni finanziarie però son riuscite, tramite una grande operazione di mistificazione delle responsabilità del tracollo, ad addebitare il tutto agli eccessi della spesa pubblica e ai sistemi di welfare. Oltretutto, con questa scelta nell’aiutare scelleratamente i responsabili anziché le vittime della crisi, l’effetto boomerang sugli Stati si è rivelato devastante: la speculazione ha quindi attaccato il delicatissimo mercato delle materie prime, e soprattutto i debiti sovrani, esponendo le nazioni più vulnerabili a tracolli senza precedenti. Falsa è però l’idea che questi (come la Grecia, o all’Irlanda) siano gli Stati con maggior debito pubblico. Se si pensa che da molti anni il triste primato di questa altrettanto triste graduatoria è tenuto dal Giappone e dagli USA, si evince con facilità che non è questione di debito pubblico, ma di importanza politica ed economica. Nessuno infatti si sognerebbe di attaccare gli USA come hanno fatto con Atene: gli Stati Uniti sono i maggiori alleati del mondo finanziario, sarebbe qualcosa di utopistico. Negli ultimi mesi abbiamo assistito alla cosiddetta primavera araba, coccolata dall’Occidente come simbolo di rivendicazione di libertà, mascherata però nei suoi lati più oscuri. Il malcontento nel Maghreb è infatti principalmente nato dalla “lotta per il pane” contro l’impoverimento crescente, dettata dal picco record raggiunto dai prezzi dei generi alimentari, nel gennaio 2011. Sono pochissimi i paesi che invece han deciso di sostenere la domanda interna e «promuovere la crescita partendo dal basso». Tra questi, Cina e Brasile che, guarda caso, rappresentano il modello di economia antagonista. Venendo al nostro orticello, quell’Italia che recentemente sta attraversando un periodo altamente sismico a livello politico ed economico, capiamo quanto sia stata dissennata la strategia interna per far fronte alla crisi: i dati ISTAT più recenti dicono che nel biennio 2009-2010 il numero di occupati è diminuito drasticamente: 532000 nuovi disoccupati, composti in larghissima parte (482.000, vale a dire il 90%) da giovani sotto i 30 anni. L’Italia è un paese che più di altri sta pagando il collasso planetario, pagando a caro prezzo un altissima disoccupazione giovanile, un ribasso drastico dei salari e una forte crescita della forbice sociale, tanto che l’ascensore sociale nel nostro paese ormai viaggia soltanto in discesa: basti pensare che dal 2008 al 2011 le voci di spesa sociale hanno avuto tagli complessivi del 78,7%, passando da 2.527 milioni di euro a 538 milioni. Tutto lascia presagire un aumento drastico della povertà, con dati che ci collocano tra gli ultimi posti in Europa. Questo può comportare la drastica conseguenza della guerra tra poveri, come dice Marco Revelli: «la riacquisizione dello status e autostima non può più passare attraverso la riduzione delle distanze dai primi, ma piuttosto per mezzo dell’ampliamento delle distanze dagli ultimi, spinti più giù, ai margini, se possibile “fuori”». Insomma, per salvare il sistema finanziario, voluto e imposto da direttive europee, si manda al macello lo stato sociale. E allora, ci si domanda se «il concetto di Europa sia davvero così indiscutibile, in un sistema che guarda solo allo specchio economico e non mostra di essere unito su tematiche sociali di vitale importanza, come quello dei migranti», come spiega Aldo Bonomi. «In un’ottica di cambiamento necessario, partendo dal basso, ci si deve interrogare se non sia il caso di preferire un ruolo di traino di un “secondo mondo” piuttosto che rincorrere affannosamente l’ultimo posto del mondo dei Grandi –continua Bonomi- imboccando una strada senza orizzonti e con moltissime difficoltà». Un cambiamento capace di emancipare il sociale, estraendolo dall’atavico contesto di soggezione dalla politica. Perché, in fondo, il sociale è la vita. Ed è a rischio estinzione.
Magazine Attualità
Potrebbero interessarti anche :
Possono interessarti anche questi articoli :
-
Terrorismo, arrestate dieci persone a Milano, Bergamo e Grosseto
In corso dalle prime luci dell'alba di questa mattina una vasta operazione antiterrorismo della polizia di Stato nei confronti di 10 persone appartenenti a due... Leggere il seguito
Da Yellowflate
ATTUALITÀ -
Washington(USA)/Prorogata la legge sugli scambi commerciali
La legge che favorisce gli scambi commerciali tra gli Stati Uniti e i paesi africani, denominata African Growth and Opportunity Act (Agoa), è stata prorogata... Leggere il seguito
Da Marianna06
AFRICA, SOCIETÀ, SOLIDARIETÀ -
Sculture allo Zoom
Lo Zoom si riscopre, ancora una volta in modo innovativo. Contest di sculture nella stagione estiva al parco naturale di Cumiana Negli ultimi tempi il bio... Leggere il seguito
Da Retrò Online Magazine
ATTUALITÀ, SOCIETÀ -
Water design 2015
In occasione di Expo e del Festival dell'Acqua, l'appuntamento con il design dedicato all'acqua arriva a Milano dal 2 all'11 ottobre Il 25 giugno scorso, in... Leggere il seguito
Da Yellowflate
ATTUALITÀ -
ELASTICITA’ AMERICANA, di GLG
Nell’editoriale di Domenica de “Il Giornale” si parla dell’imperialismo tedesco (cui l’Europa attuale deve sottostare). Nell’editoriale di “Libero” (del... Leggere il seguito
Da Conflittiestrategie
POLITICA, SOCIETÀ, STORIA E FILOSOFIA -
Legambiente: “L’ecomafia vale 22mld di euro, nel 2014 80 reati al giorno”
Il giro di affari delle Ecomafie non si ferma: nel 2014 cresce ancora e raggiunge i 22 miliardi di euro, con un incremento di 7 miliardi rispetto all’anno... Leggere il seguito
Da Stivalepensante
SOCIETÀ