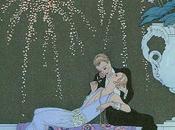Ne è stato già scritto e detto talmente in abbondanza che risulta quasi impossibile non perdere l’interesse della platea al solo pronunciarne il titolo. Eppure Mad Men resta per molti versi lo specchio più lucido e affidabile in cui andare a riconoscere e ricostruire il nostro essere contemporaneo.
Se da più parti è stato sottolineato quanto il cinema, e nello specifico la grande macchina hollywoodiana, sia divenuto incapace di raccontare la realtà (se non nei termini ‘kracaueriani’ di rappresentazione dell’inconscio di una società intendo dire: abbondano infatti i film horror e catastrofici, i remake, i thriller psicologici, gli schemi narrativi impostati sulla membrana diafana tra reale e immaginario) le serie televisive sembrano aver messo da tempo in moto un’opera di lenta e paziente ricucitura culturale, al termine della quale, forse, potremmo di nuovo avere un’idea più chiara e positiva di quello che siamo, di quello che ogni giorno rischiamo di diventare, e di quello che fino adesso siamo stati capaci d’essere.
Pare assurdo, ma ciò che rimane in un’epoca in cui né la scienza né le religioni né le ideologie né la filosofia né tantomeno la politica o la Storia propriamente detta sembrano essere in grado di dare una solida base d’appartenenza alla comunità umana, quel che rimane, dicevo, è il senso di comunione che ci deriva dalle storie singole.
Cosa è successo nel caso di Mad Men? Cosa ha portato molti a sostenere che siamo al cospetto di una della migliori serie televisive di sempre?
E’ risaputo, ma per quei pochi che ancora non ne fossero a conoscenza ecco qui di seguito i tre ingredienti principali.
In primo luogo l’ambientazione. Che non è più il classico anche se spesso ben definito background di comodo, nido soffice e confortevole in cui crescere le proprie storie e all’occorrenza fare riferimento. Il mix è esplosivo, il materiale incandescente. Siamo a cavallo tra i Cinquanta e i Sessanta, e al boom economico si affianca un’accelerazione/evoluzione dei consumi/costumi che porterà ad opporre razzismo e integrazione, conservatorismo ed emancipazione. Le vicende, e in particolare quella del protagonista principale Donald Draper, hanno costantemente a che vedere con l’epoca che le ha generate, ovvero con un periodo di grandi premesse e di decisivi cambiamenti nella società Americana e, in un quadro più allargato, occidentale. Sono gli anni dell’inizio della lotta per i diritti civili (dei neri soprattutto) ma insieme di fortissima e spesso arrogante predominanza del grande capitale bianco. C’è una società che sta diventando moderna, che comincia ad annusare i privilegi del benessere generalizzato e a portata di mano, – ovvero la nascente e tanto celebrata società del consumo – dove insieme alle sigarette, all’alcol, ai viaggi, al divertimento e al sogno televisivo, si unisce l’embrione di una futura quanto inevitabile insoddisfazione domestica, l’alternativa dell’adulterio, il desiderio d’emancipazione in particolare femminile ma anche omosessuale, e i primi e sempre più frequenti casi di divorzio. Nella società di Mad Men, tutti sembrano sapere quale direzione vogliono prendere, ma nessuno sembra essere davvero cosciente di quale sarà il proprio punto d’arrivo: noi, l’adesso.
In questo senso Mad Men è una di quelle poche opere di fiction che hanno saputo portare in evidenza e ottimizzare il principio secondo il quale l’ingrediente più importante di ogni narrazione non è quasi mai fisicamente presente nella narrazione stessa. Tale ingrediente è dato da chi sta leggendo, da chi sta guardando, da chi sta ascoltando.
Ecco allora che gli spettatori, qui, sanno qualcosa che i personaggi non sanno. Conoscono il macrocosmo della Storia: essi, in una certa misura, sono la Storia di cui i personaggi si trovano a far parte. Questo significa un’inusuale carica di empatia. Un’empatia che va al di là di quella che poteva essere sviluppata verso i protagonisti di Desperate Houswives, Sopranos, Dexter o Lost (per citare gli ultimi fenomeni mediatici) perché ha a che vedere non solo con la nostra esperienza di vita quotidiana (e i nostri eterni dilemmi esistenziali) ma anche col nostro senso di responsabilità verso gli eventi (avvenuti e futuri), ovvero nei confronti di quel qualcosa di più grande e costituzionale altrimenti detto “società”. Certo, nessuno dice che non siano mai state realizzate serie televisive ambientate nel passato, intendiamoci, ma non era mai successo che il passato apparisse così drammaticamente e simpateticamente connesso con le istanze, i nervi ancora scoperti e le tensioni della società attuale.
Al ruolo degli spettatori si affianca la cura dei personaggi; tutti umani, tutti unici e insieme tutti sacrificabili, a cominciare da quel Donald Draper che nel suo essere un Citezen Kane privato anche del ricordo/rifugio della sua Rosebud pare impersonificare e riassumere in sé la condizione di ogni protagonista in ogni storia.
Figlio illegittimo di una prostituta morta di parto, e uomo da un’identità quotidianamente in costruzione, individuo senza passato e al contempo dal passato opprimente, mistero semplice da leggere e insieme impossibile da definire, Donald Draper è il personaggio per eccellenza.
È il centro gravitazionale intorno al quale ogni cosa ruota, ma al tempo stesso è a sua volta un elemento instabile (solo enormemente e inevitabilmente più instabile degli altri) di un sistema sempre sul punto di ribaltarsi e collassare. Donald è preda del vortice di forze che pare aver lui stesso generato, cavalca e crea eventi da cui sarà a sua volta cavalcato e ricreato, e più d’una volta, d’un tratto, smette di essere centro e diviente meteora, pianeta fuori controllo che precipita ruotando come gli altri (più degli altri) verso il buco nero che fino a un attimo prima aveva impersonato.
Non starò qui a dire che Donald Draper è ognuno di noi, o che è un moderno Odisseo, o che incarna l’uomo senza più punti di riferimento stabili dei nostri tempi, certo si tratta di cose che possono essere sostenute, e a ragione, ma non è questo il punto. Quello che davvero colpisce in lui è altro. È la nostra incapacità a giudicarlo senza sentirci ingiusti o parziali nel giudizio che abbiamo appena espresso. Perché Don è un personaggio vulnerabile, in continua evoluzione eppure perennamente identico a se stesso e, in questo, prodigiosamente umano.
Siamo di fronte a una serie televisiva potenzialmente senza fine, nella quale le risorse paiono autorigenerarsi nel momento in cui vengono messe in scena ed esaurite, e in cui come spettatori siamo pronti ad andare avanti a oltranza (cosa che guarda caso fanno anche i personaggi) con smisurata e folle fiducia in una tragedia sempre incombente ma mai definitiva, costi quel che costi verso un finale che non ci aspettiamo arrivare, ma che quando arriverà saremo pronti ad accettare.
Voilà.
Ecco l’opera di ricucitura culturale di cui si parlava inizialmente. Quel tentativo di andare a riconoscere e ricostruire il nostro essere contemporaneo che le serie televisive sembrano aver preso dal cinema in un momento in cui il cinema stesso fatica a raccontare.
La società Americana si interroga, lo fa da sempre. La società Americana si celebra, lo ha sempre fatto ma ultimamente pare avere dimenticato come. La società Americana (è stato detto all’indomani dell’undici settembre, e mai come adesso tali parole paiono profetiche) ha perso la propria innocenza.
Eppure la società Americana sa da dove ripartire: dal racconto.
Nello specifico, dal racconto di se stessa.
Non dal ripetere sempre più vuoto e insignificante dei propri stereotipi umani e sociali (quello lo facciamo noi, e abbiamo continuato a farlo così tanto, e così bene, da esserci riscoperti d’improvviso VUOTI) ma dalla messa in scena dei propri traumi, dalla ricerca tra i propri nervi scoperti e tra i nodi irrisolti della propria storia, e dall’affrontare entrambe le cose a viso scoperto e con coraggio narrativo.
Certo, la società Americana si specchia e cerca di comprendersi in Mad Men. E fa bene. Noi tentiamo di specchiarci nella società Americana ma non possiamo, se non per grossolana approssimazione, riconoscerci. Abbiamo importato il consumismo senza averlo provocato, la nostra società e il nostro modo di vivere sono cambiati (e stanno continuando a cambiare) più per determinazioni esterne che per istanze di rinnovamento generate, cresciute, nutrite e finalizzate in maniera autonoma. Non ci riconosciamo, secondo alcuni, perché da troppo tempo abbiamo rinunciato a volerci conoscere, secondo altri, perché abbiamo paura di quello che potremmo vedere. E allora è più semplice risolvere ogni analisi nel gioco vacuo e qualunquista del riso e della battuta. Se l’America sembra interrogarsi e lottare con gli stereotipi di se stessa, noi sembriamo essere troppo impegnati a difenderli, coi denti e con le unghie, per accorgerci di quanto oramai non ci appartengano più.
Eppure qualcosa potrebbe, e sembrerebbe, essersi messo in moto anche da noi. Nel mare di ‘serie’ bidimensionali e inoffensive in cui la televisione italiana pare da tempo felicemente crogiolarsi, sono apparse rotte inedite e interessanti, che potrebbero aprire la strada a future navigazioni (mi riferisco in particolar modo a Romanzo Criminale ma non solo). Dove tali navigazioni condurranno nessuno ancora lo sa, ma è in questo brivido d’imprevedibili potenzialità che dovremmo anche noi ricominciare a credere, e tentare d’interrogarci, soprattutto adesso che l’approssimarsi del centocinquantesimo compleanno dell’unità d’Italia pare aver ancora una volta messo da parte le domande nel patrio nome delle celebrazioni.
Il finale della quarta serie di Mad Men, dopo che tutto pare essere irrimediabilmente (e definitivamente) accaduto, e nulla sembra più possibile, porta il titolo fin troppo esplicativo di “Tomorrowland”.
Il protagonista ha perso tutto, ma in questo perdere ogni cosa pare aver finalmente afferrato la certezza della propria identità. È un uomo che guarda al futuro, e che nella tabula rasa che ha di fronte cerca la speranza di un nuovo inizio, finalmente libero dagli errori commessi.
Tomorrowland. Terra del domani.
Don Draper, la societa americana (occidentale?) e il futuro della narrazione paiono aggrapparsi a questa speranza con tutta la forza che deriva da una rinnovata consapevolezza di sé.
Chissà che non sapremo anche noi fare altrettanto.