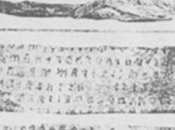[I due testi inediti che presentiamo sono come due “fiabe” del ponente ligure. Il titolo della prima è quasi lo stesso di Licia pesca a Ponente, testo teatrale scritto da Seborga nel 1947, rappresentato a Vallebona nel 1951 come “teatro della realtà”, e pubblicato su Europe nel gennaio 1952 con il titolo La pêche de Licia.]
______________________________
Licia pescava a ponente di Elio Lanteri
Licia pescava laggiù, al riparo dei venti, dietro il promontorio che proteggeva dalle correnti.
«Guarda, Teresì», mi diceva il nonno, «Licia ha in mano la lenza e chiede perdono ai pesci.»
Pescava sempre là, dove il mare fa ascella, dai campi alti sopra il cielo si vedeva un guscio di legno, nell’azzurro. Fermo.
«Ho sei figli piccoli da sfamare», diceva Licia ai pesci, «un riparo sulla riva ed un vecchio girasole piantato nella sabbia, non vengo con la rete, a me ne servono soltanto sette.»
Attorno alla piccola barca accorrevano i pesci, sporgevano la testa dall’acqua, l’ascoltavano a bocca aperta.
«Ora nella baracca siamo ancora in sette, ma i figli crescono rapidamente, chiedetelo al Dio del mare, gli ho fatto una promessa.»
Le lacrime dei pesci, come gocce d’olio vergine, galleggiavano gialle sulle onde, attorno al suo guscio di legno.
Poi lento rotolò il tempo, il maggiore dei figli emigrò per lavorare in Francia: da quel giorno Licia nel mare pescò solo sei pesci.
Un altro figlio si sposò e andò via. Licia disse ai pesci: «Ora cinque sono sufficienti.»
Alcuni anni dopo, altri due figli partirono, s’imbarcarono e andarono per mare.
«Ora siamo rimasti in tre», disse Licia ai pesci, «ditelo al Dio del mare, io manterrò la mia promessa.»
Anche il penultimo partì, per guadagnarsi la vita su un barco; Licia rimase con l’ultimo che era storpio e zoppo.
Usciva sempre a pescare, ma ormai era tanto vecchia, aveva le braccia stanche e non reggeva più il remo; si costruì con le sue mani una piccola vela per la sua barchetta di legno.
Il nonno, dai campi alti, guardava giù il mare, portava ad imbuto le mani alla bocca e le gridava:
«Fatti coraggio Licia, anch’io sono vecchio e stanco.»
«Ma Licia era lontano e non poteva sentire il nonno», dissi a mia nonna.
«I vecchi hanno un dono, il sesto senso, intendono con il cuore anche quando non ci sentono», mi rispose.
Una sera Licia, nella baracca, chiamò il figlio zoppo, si sedettero al tavolo e gli lesse una lettera del figlio maggiore.
«Tu andrai a vivere con lui», gli disse, «tuo fratello ti aspetta in Francia.»
La mattina dopo, non era ancora sorto il sole, Licia si alzò dal letto senza fare rumore.
L’aria era fresca, ma non indossò la maglia, diede uno sguardo alle sue povere cose e si avviò verso la barca.
Sonnecchiava il vecchio girasole, piantato nella sabbia, aveva la testa china, aspettando che spuntasse l’alba.
Con la coda dell’occhio vide il suo piede scalzo, sbirciò un poco attorno, e così parlò a Licia:
«Perché sei senza maglia Licia, e non hai a tracolla la borraccia?»
Licia si fermò e gli accarezzò la grossa testa gialla:
«Non torno più, girasole, sono passati gli anni, e io ho fatto una promessa che ora debbo rispettare.»
Puntò i piedi nella sabbia, a fatica ammarò la barca e con mano leggera alzò la vecchia vela.
Fissò il timone verso il cuore azzurro, profondo, del Golfo del Leone.
Quando a levante sorse dal mare il sole, il girasole rimase un attimo a pensare, scosse la testa e spruzzò via da sé le ultime gocce di rugiada: aveva un colore pastoso, pareva un tuorlo d’uovo.
Quel mattino, nella baracca, si svegliò di soprassalto il figlio zoppo, vide che sul tavolo era rimasta la borraccia vuota, si infilò i pantaloni e corse zoppicando sulla sabbia, fin dove si frange l’onda.
Ma il posto dove pescava Licia, nell’ansa di mare, per la prima volta era deserto: rientrò nella baracca e prese la stampella, corse tra i pini, sugli scogli, fino sulla punta del promontorio, di lì si vedeva tutta la costa ad oriente, e a destra, l’immensità azzurra del Golfo del Leone.
Il mare era calmo, in cielo poco vento, lontano passava una nave, ma non si vedevano vele.
Ritornò verso la baracca piangendo, era mezzogiorno, e vide il girasole immobile che fissava il suolo.
«Che fai girasole che non accompagni il sole nel suo percorso?, hai la testa china e sotto di te c’è una macchia gialla.»
Il girasole gli rispose singhiozzando:
«Licia non torna più, al Dio del mare ha fatto una promessa, il mare ha nutrito voi, ora dà il suo corpo ai pesci: io sono qui, disperato, piantato nella sabbia, mi dissanguo al sole e lentamente muoio.»
Sotto la testa del girasole c’era una grande macchia gialla che impastava la sabbia.
Al mattino il nonno salì ai campi alti sopra il cielo, guardò laggiù il mare, ma non vide più Licia pescare nell’ansa, discese tra le ginestre del poggio dell’Uvaira, portò le mani ad imbuto alla bocca e, in un grido disperato, invocò:
«Licia, ero ancora bambino e ti ho visto sempre pescare, Licia ritorna, senza di te non ha più senso il mare.»
Ma Licia non apparve più nell’ansa, sul suo guscio di barca.
Una sera il nonno disse a mia nonna:
«Domani non salgo ai campi alti, vado a chiedere notizie di Licia al carrettiere.»
La sera, in cucina, il nonno seduto vicino al fuoco spento, stava a capo chino.
Io andai subito a guardare se sul pavimento ci fosse invece una macchia gialla: c’era solo l’ombra della sua testa, una grande ombra nerastra.
«Licia non torna più e il girasole è seccato, me lo ha detto il carrettiere, Licia ha dato il suo vecchio corpo ai pesci.»
Alcuni giorni dopo il nonno rivide il carrettiere.
«L’altra notte», gli raccontò, «è successo un fatto strano: dove pescava Licia ha cantato il Dio del mare. Cantava la vita triste di Licia e delle sue sofferenze passate, di chi è nato povero e non ha un campo da coltivare. La gente dalla riva ha udito un dolce canto, era la voce del Dio del mare e tutti hanno pianto.»
In quella notte stellata, dal Golfo del Leone erano giunte tutte le varietà di pesci, versavano lacrime gialle nello specchio d’acqua, ascoltando a bocca aperta.
Le lacrime dei pesci erano gocce d’olio vergine, formavano una coltre gialla che ondeggiava lentamente.
______________________________
Gli Strusciai (Filastrocca del tempo) di Elio Lanteri
I gemelli Pirò e Rudò “Strusciai” di soprannome, erano scesi a vivere nel paese dalla frazione di Ciaxe: abitavano nel carruggio del “Risentimento”, in una casa cupa, senza persiane, che solo a guardarla dava smarrimento.
Occhi chiari, di statura corta, il basco nero calato sulla fronte, la gente del paese non li distingueva e parlando di loro diceva «Lun le lautru e lautru nu le nisciun.» (1)
Potavano che era una meraviglia, nei filari delle vigne procedevano affiancati, con i forbicioni assestavano un colpo secco, e tranciavano di netto il tralcio.
Sudava il taglio fresco rimasto attaccato alla pianta, dando l’addio alla parte recisa con una lacrima collosa di pianto, una necessità, ma i gemelli provavano un leggero struggimento, nel vedere il rametto reciso, verde, agonizzare sul terreno.
La domenica, all’osteria, i due appartati, giocavano a “belotte”; a chi assisteva sembrava facessero un eterno solitario, nessuno li ha mai chiamati per nome, ma erano due e li chiamavano “i strusciai”.
Attorno a loro lentamente si creò un alone di rispetto – in passato nel paese era già successo con Baté il rabdomante – loro erano “tecnici”, erano di un’altra razza, taciturna, che non si immischiava nei fatti degli altri.
Un pomeriggio caldo e nebbioso, quando sulla testa pesa “u stenturassu”, Pirò scivolò tra le viti e si abbatté sul ceppo aguzzo di un ramo tagliato. Sanguinante dall’occhio destro, corse, seguito dal gemello, dal barbiere Silvestru, che nel paese fungeva da infermiere.
Cautamente Silvestru gli tamponò con il cotone l’occhio ferito, poi gli bendò tutta la parte destra della testa.
Pirò nei giorni successivi continuò a potare, perché era il suo dovere di “tecnico”; si tolse solo il basco, coprì quel turbante bianco con la “casquette” e prese posto sul filare destro, così da poter vedere Rudò chino nel filare sinistro.
Passarono venti giorni, e un mattino, nella barberia, Silvestru gli tolse tampone e benda: Pirò si guardò allo specchio e si accorse che la pupilla dell’occhio gli era diventata bianca.
La gente del paese ne fu quasi contenta, ora lo distingueva dal suo gemello e lo chiamava “u strusciau cun l’ogiu giancu”.
Passò altro tempo e tra i gemelli si era creata una strana situazione; Pirò, nei filari di vite, chiamava Rudò senza ottenere alcuna risposta, si allarmò, ma quel silenzio, per fortuna, durò solo alcuni giorni.
Continuarono a potare, e con sollievo Pirò notò che il gemello alle sue domande rispondeva con rapidità e precisione, ma che stranamente non sentiva più suoni né rumori e incredibilmente non sentiva nemmeno suonare il campanone.
Una sera, stanchi, sulla via del ritorno, Pirò fissò la targa del carruggio del “Risentimento”, compitò tra sé e con stupore vi lesse “Risorgimento”; a bocca aperta si voltò verso il gemello in una muta interrogazione.
Rudò, senza guardarlo, gli domandò cos’era il Risorgimento.
Pirò stupito pensò: non sente manco il tuono, però legge il mio pensiero.
La mattina dopo, mentre si recavano al vigneto, Rudò non sentì arrivare sullo stradone ansimando il camion che trasportava la spazzatura: un colpo secco e rimase lungo disteso nella cunetta, non ebbe nemmeno il tempo di dire al gemello un’ultima parola.
Pirò lo rivestì da solo, nella casa del “Risentimento”, pagò quattro uomini che lo portassero a spalle nel piccolo cimitero di Ciaxe: seppellirono Rudò in un angolo, sotto un cipresso; Pirò guardò desolato, con il solo occhio sano, la fossa ancora aperta.
Continuò a potare, perché nel paese, lui era rimasto l’ultimo “tecnico”, ma dal filare di destra parlava, e dall’altro lato non riceveva più risposte, finché un giorno vide sbucare tra i filari un cane spinone, randagio e sporco; Pirò ne ebbe compassione e se lo portò nella sua abitazione.
Ora Pirò non era più solo nei vigneti, il cane lo seguiva passo passo nel filare di fianco, gli parlava ed il cane era attento, parve a Pirò che lo avesse mandato dal cielo il suo gemello.
Una domenica, mentre faceva il suo eterno solitario all’osteria con il cane sistemato al tavolo sulla sedia dirimpetto, entrò “u Palmà” e disse a Pirò che secondo lui tagliava troppi tralci di viti dal tronco.
Il cane ringhiò, mostrando agli avventori tutti i suoi vecchi denti gialli, saltò giù dalla sedia e addentò “u Palmà” alla coscia destra.
Pirò fu commosso da tanta devozione, e da quel giorno per onorare Rudò, lo chiamò Rudondo.
Con il passare degli anni, gli si affaticò l’occhio sano, dai vigneti non vide più, in inverno, brillare la neve sui monti, la sua visione era nebbiosa, ma non si confidò mai con nessuno, solo con Rudondo.
Pirò invecchiò, e con maggiore rapidità Rudondo; a Pirò si anchilosò la mano destra, Rudondo si pelò per la rogna, ed aveva macchie scure sulla schiena; erano sempre insieme e raramente uscivano dalla loro abitazione.
Pirò incominciò a dare segni di squilibrio, a volte in inverno usciva di casa senza il giaccone, Rudondo lo seguiva come un’ombra, afflitto nel vedere Pirò che pareva un altro uomo.
Un mattino freddo d’inverno, quando la terra è dura e ghiaccia, Pirò si alzò e sotto il letto non trovò più una delle sue scarpe, Rudondo capì e la rintracciò tra un mucchio di indumenti vecchi, l’afferrò con la bocca ansimando e la depose ai suoi piedi.
Poi si voltò e si sentì improvvisamente stanco, si avviò verso la cuccia traballando, diede un ultimo sguardo triste a Pirò e si accasciò sul pavimento, rimase immobile e fu per sempre morto.
Pirò, senza lacrime, gli comprò una cassetta di castagno scuro, color di Rudondo quando aveva ancora il pelo sano, pagò due uomini che lo portarono a spalle nel cimitero di Ciaxe e lo seppellirono sotto il cipresso, di fianco alla tomba del gemello.
Quando venne la sera, come un patriarca del vecchio testamento, Pirò sentì una musica, silenziosa e malinconica, rifletté e concluse che era giunta l’ora di abbandonare questo mondo.
Si affacciò alla finestra e chiamò il piccolo Damin che giocava a biglie nel carruggio, in poche parole gli dettò le sue ultime volontà su un foglio di quaderno.
Si sedette e bevve l’ultimo “gotto”, si rialzò a fatica e con la scopa ripulì la sua stanzetta, dall’armadio estrasse il vestito nero delle feste, si rivestì, si distese nel letto e disse buonanotte al mondo.
Al mattino Filumé, dalla finestra di fronte, notò che non si muoveva nulla nella stanzetta di Pirò, corse a vedere e trovò la porta aperta, lo vide composto che indossava il suo vestito buono delle feste, e osservò con stupore che gli sorrideva con l’occhio bianco aperto.
Filumé si affacciò urlando dalla finestra, e in un baleno nella stanza si radunò tutta la popolazione; fissava con sgomento Pirò, perché giaceva nel letto immobile l’ultimo “tecnico” e con angoscia si domandava cosa avrebbe bevuto in futuro il paese.
Il giorno dopo ci fu il funerale, la gente accorse e si avviò verso il cimitero di Ciaxe, dietro la bara c’era anche la banda musicale, che per la mesta cerimonia si rifiutò di essere pagata.
Tutti risalirono a piedi il sentiero che era cosparso di buchi e sassi; nel cimitero il sindaco tenne un discorso commovente, parlò con rispetto dei gemelli e anche di Rudondo, disse che in quel triste pomeriggio davano l’addio all’ultimo “tecnico” e che d’ora in avanti, nel paese, si sarebbe solo potato da incompetenti e buonanotte.
Poi estrasse dalla tasca un biglietto tutto stropicciato, chiamò Damin che lo leggesse al pubblico presente; faticò a capirlo il bambino, perché era scritto con un lapis ed aveva una grossa macchia di vino al centro.
Damin lesse piano le poche parole: «Questo è il volere di Pirò, Rudò e Rudondo; tutti i risparmi accumulati nella nostra vita sono destinati ad un lascito per i trovatelli dell’orfanotrofio.»
La vecchia maestra del collegio, una donna isterica e zitella, urlò al sindaco con voce stridula e penetrante che solo i gemelli e Rudondo che non erano del paese ma della frazione di Ciaxe, avevano pensato ai suoi trovatelli poveri e bisognosi.
Allora tutti i bambini dell’orfanotrofio, che erano quattordici, la testa rapata, i grembiulini neri e la coccarda bianca, si strinsero attorno alla maestra e inveirono contro il sindaco gridandogli merdoso.
Dal bordo della fossa aperta, il sindaco, sudando, protestò che i bambini contro di lui li aveva montati la maestra, poi si inceppò e rimase a bocca aperta.
L’anarchico Marcé che assisteva alla sepoltura, diede una gomitata al compagno Jeannot al suo fianco e senza voltarsi gli sibilò con l’angolo della bocca: «Mai avuto un sindaco nel paese, solo coglioni.»
Soffiava fredda la tramontana, un tordo zirlò da un ulivo dietro il muro del cimitero; il vecchio prete si avvolse il collo nella sciarpa di lana nera, alzò l’aspersorio e spruzzò la bara con l’acqua benedetta.
Seppellirono Pirò a fianco di Rudò e Rudondo, vangate di terra risuonarono sulla cassa, i bambini piangendo gettarono nella fossa rami di semprevivi e a altri fiori di roccia.
La popolazione mestamente lasciò il cimitero, ridiscese il sentiero e si rinchiuse triste in casa a riflettere amaramente sul vuoto lasciato nel paese dai gemelli “Strusciai” e da Rudondo.
A sera il cielo si incupì, e nella notte piovve, segno evidente che dal cielo il Padreterno inviava ai tre la sua benedizione.
Ora Pirò, Rudò e Rudondo sono lassù nelle vigne del Signore, potano le viti e danno del tu a San Pietro, i Santi li interpellano con rispetto e chinando la testa li chiamano maestri.
Pirò è nel filare a destra, in quello di mezzo c’è Rudondo, a sinistra Rudò e conversano contenti. Pirò ha l’occhio destro sano, e in Paradiso non transita il camion della spazzatura, Rudondo ha il pelo folto e parla e pota come loro.
______________________________
NOTA
(1) Uno è l’altro e l’altro non è nessuno [NdR].
______________________________
Elio Lanteri
Bio
Elio Lanteri è nato nel 1929 a Dolceacqua e scomparso nel 2010 a Oneglia. Nel corso della sua vita ha stretto amicizie con diverse generazioni di autori liguri, da Guido Seborga e Francesco Biamonti a Marino Magliani, studiando e amando le opere di Julio Caro Baroja, Juan Rulfo e Federico García Lorca. Nel 2009, grazie all’impegno dello stesso Magliani, ha pubblicato per Transeuropa il suo romanzo d’esordio, La ballata della piccola piazza, rimasto “in un cassetto” per più di quindici anni ed edito con in copertina un acrilico di Seborga, Eros (1973).
______________________________
Testo pubblicato sul terzo numero di Atti impuri