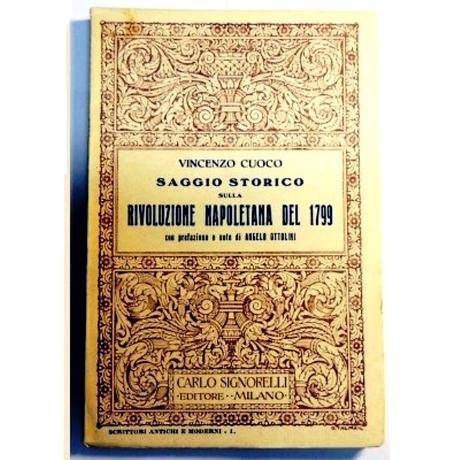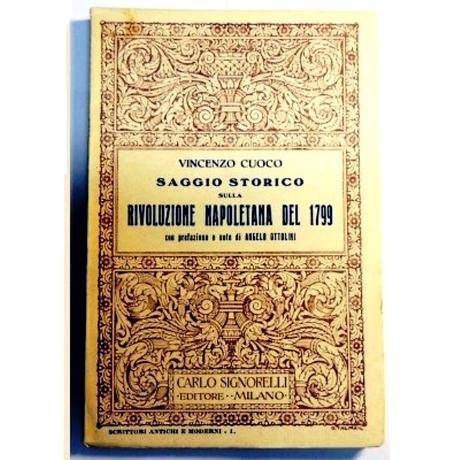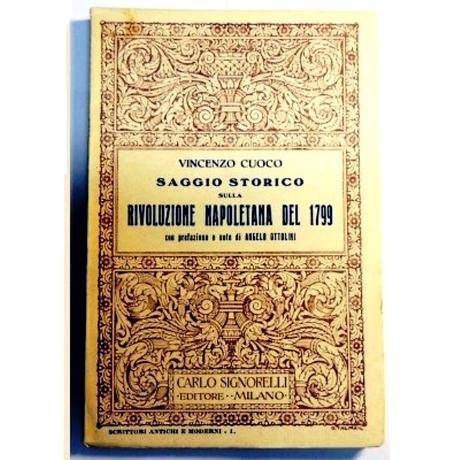
SAGGIO STORICO
SULLA
RIVOLUZIONE DI NAPOLI
SECONDA EDIZIONE
CON AGGIUNTE DELL’AUTORE
1806
Caedo cur vestram rempublicam tantam perdidistis tam cito?
POMPONIO ATTICO, presso CICERONE, De senectute.
PREFAZIONE
ALLA SECONDA EDIZIONE
Quando questo Saggio fu pubblicato per la prima volta, i giudizi pronunziati sul medesimo furon molti e diversi, siccome suole inevitabilmente avvenire ad ogni libro, del quale l’autore ha professata imparzialitá, ma non sono imparziali i lettori. Il tempo però ed il maggior numero han resa giustizia, non al mio ingegno né alla mia dottrina (ché né quello né questa abbondavano nel mio libro), ma alla imparzialitá ed alla sinceritá colla quale io avea in esso narrati avvenimenti che per me non eran stati al certo indifferenti.
Della prima edizione da lungo tempo non rimaneva piú un esemplare; e, ad onta delle molte richieste che ne avea, io avrei ancora differita per qualche altro tempo la seconda, se alcuni, che han tentato ristamparla senza il mio assentimento, non mi avessero costretto ad accelerarla.
Dopo la prima edizione, ho raccolti i giudizi che il pubblico ha pronunziati, ed ho cercato, per quanto era in me, di usarne per rendere il mio libro quanto piú si potesse migliore.
Alcuni avrebbero desiderato un numero maggiore di fatti. Ed in veritá io non nego che nella prima edizione alcuni fatti ho omessi, perché li ignorava; altri ho taciuti, perché ho creduto prudente il tacerli; altri ho trasandati, perché li reputava poco importanti; altri finalmente ho appena accennati. Ho composto il mio libro senza aver altra guida che la mia memoria: era impossibile saper tutti gl’infiniti accidenti di una rivoluzione, e tutti rammentarli. Molti de’ medesimi ho saputi posteriormente, e, di essi, i piú importanti ho aggiunti a quelli che giá avea narrati. Ad onta però di tutte le aggiunzioni fatte, io ben mi avveggo che coloro, i quali desideravano maggior numero di fatti nella prima edizione, ne desidereranno ancora in questa seconda. Ma il mio disegno non è stato mai quello di scriver la storia della rivoluzione di Napoli, molto meno una leggenda. Gli avvenimenti di una rivoluzione sono infiniti di numero; e come no, se in una rivoluzione agiscono contemporaneamente infiniti uomini? Ma, per questa stessa ragione, è impossibile che tra tanti avvenimenti non vi sieno molti poco importanti e molti altri che si rassomiglian tra loro. I primi li ho trascurati, i secondi li ho riuniti sotto le rispettive loro classi. Piú che delle persone, mi sono occupato delle cose e delle idee. Ciò è dispiaciuto a molti, che forse desideravano esser nominati; è piaciuto a moltissimi, che amavano di non esserlo. I nomi nella storia servon piú alla vanitá di chi è nominato che all’istruzione di chi legge. Quanti pochi sono gli uomini che han saputo vincere e dominare le cose? Il massimo numero è servo delle medesime; è tale, quale i tempi, le idee, i costumi, gli accidenti voglion che sia: quando avete ben descritti questi, a che giova nominar gli uomini? Io sono fermamente convinto che, se la maggior parte delle storie si scrivesse in modo di sostituire ai nomi propri delle lettere dell’alfabeto, l’istruzione, che se ne ritrarrebbe, sarebbe la medesima. Finalmente, nella considerazione e nella narrazione degli avvenimenti, mi sono piú occupato degli effetti e delle cagioni delle cose che di que’ piccioli accidenti che non sono né effetti né cagioni di nulla, e che piaccion tanto al lettore ozioso sol perché gli forniscono il modo di poter usare di quel tempo che non saprebbe impiegare a riflettere.
Dopo tali osservazioni, ognun vede che i fatti che mi rimanevano ad aggiugnere eran in minor numero di quello che si crede. Ragionando con molti di coloro i quali avrebbero desiderati piú fatti, spesso mi sono avveduto che ciò che essi desideravano nel mio libro giá vi era: ma essi desideravano nomi, dettagli, ripetizioni; e queste non vi dovean essere. Per qual ragione distrarrò io l’attenzione del lettore tra un numero infinito d’inezie e lo distoglierò da quello ch’io reputo vero scopo di ogni istoria, dalla osservazione del corso che hanno, non gli uomini, che brillano un momento solo, ma le idee e le cose, che sono eterne? Si dirá che il mio libro non merita il nome di «storia»; ed io risponderò che non mi sono giammai proposto di scriverne. Ma è forse indispensabile che un libro, perché sia utile, sia una storia?
Una censura mi fu fatta, appena uscí alla luce il primo volume. Siccome essa nasceva da un equivoco, credei mio dovere dileguarlo; e lo feci con quell’avvertimento che, nella prima edizione, leggesi al principio del secondo volume, e che ora inserisco qui:
Tutte le volte che in quest’opera si parla di «nome», di «opinione», di «grado», s’intende sempre di quel grado, di quella opinione, di quel nome che influiscono sul popolo, che è il grande, il solo agente delle rivoluzioni e delle controrivoluzioni.
Taluni, per non aver fatta questa riflessione, hanno creduto che, quando nel primo tomo, pagina 34, io parlo di coloro che furono perseguitati dall’inquisizione di Stato, e li chiamo «giovinetti senza nome, senza grado, senza fortuna», abbia voluto dichiararli persone di niun merito, quasi della feccia del popolo, che desideravano una rivoluzione per far una fortuna.
Questo era contrario a tutto il resto dell’opera, in cui mille volte si ripete che in Napoli eran repubblicani tutti coloro che avevano beni e fortuna; che niuna nazione conta tanti che bramassero una riforma per solo amor della patria; che in Napoli la repubblica è caduta quasi per soverchia virtú de’ repubblicani… Nell’istesso luogo si dice che i lumi della filosofia erano sparsi in Napoli piú che altrove, e che i saggi travagliavano a diffonderli, sperando che un giorno non rimarrebbero inutili.
I primi repubblicani furono tutti delle migliori famiglie della capitale e delle province: molti nobili, tutti gentiluomini, ricchi e pieni di lumi; cosicché l’eccesso istesso de’ lumi, che superava l’esperienza dell’etá, faceva lor credere facile ciò che realmente era impossibile per lo stato in cui il popolaccio si ritrovava. Essi desideravano il bene, ma non potevano produrre senza il popolo una rivoluzione; e questo appunto è quello che rende inescusabile la tirannica persecuzione destata contro di loro.
Chi legge con attenzione vede chiaramente che questo appunto ivi si vuol dire. Io altro non ho fatto che riferire quello che allora disse in difesa de’ repubblicani il rispettabile presidente del Consiglio, Cito; e Cito era molto lontano dall’ignorare le persone o dal volerle offendere.
Sarebbe stoltezza dire che le famiglie Carafa, Riari, Serra, Colonna, Pignatelli… fossero povere; ma, per produrre una rivoluzione nello stato in cui allora era il popolo napoletano, si richiedevano almeno trenta milioni di ducati, e questa somma si può dir, senza far loro alcun torto, che essi non l’aveano. La ricchezza è relativa all’oggetto a cui taluno tende: un uomo che abbia trecentomila scudi di rendita è un ricchissimo privato, ma sarebbe un miserabile sovrano.
Si può occupare nella societá un grado eminentissimo, e non essere intanto atto a produrre una rivoluzione. Il presidente del Consiglio occupava la prima magistratura del Regno, e non potea farlo: ad un reggente di Vicaria, molto inferiore ad un presidente, ad un eletto del popolo, moltissimo inferiore al reggente, era molto piú facile sommovere il popolo.
Lo stesso si dice del nome. Chi può dire che le famiglie Serra, Colonna, Pignatelli… fossero famiglie oscure? Che Pagano, Cirillo, Conforti fossero uomini senza nome?… Ma essi aveano un nome tra i saggi, i quali a produr la rivoluzione sono inutili, e non ne aveano tra il popolo, che era necessario, ed a cui intanto erano ignoti per esser troppo superiori. Paggio, capo de’ lazzaroni del Mercato, è un uomo dispregevole per tutti i versi; ma intanto Paggio, e non Pagano, era l’uomo del popolo, il quale bestemmia sempre tutto ciò che ignora.
Credo superfluo poi avvertire che i giudizi del popolo non sono i miei; ma è necessario ricordare che, in un’opera destinata alla veritá ed all’istruzione, è necessario riferire tanto i giudizi miei quanto quelli del popolo. Ciascuno sará al suo luogo: è necessario saperli distinguere e riconoscere; e perciò è necessario aver la pazienza di leggere l’opera intera, e non giudicarne da tratti separati.
Questo Saggio è stato tradotto in tedesco. Son molto grato al signor Kellert, il quale, senza che ne conoscesse l’autore credette il libro degno degli studi suoi: piú grato gli sono, perché lo ha tradotto in modo da farlo apparir degno dell’approvazione de’ letterati di Germania; de’ favorevoli giudizi de’ quali io andrei superbo, se non sapessi che si debbono in grandissima parte ai nuovi pregi che al mio libro ha saputo dare l’elegante traduttore. Pure, tra gli elogi che il libro ha ottenuti, non è mancata qualche censura, ed una, tra le altre, scritta collo stile di un cavalier errante che unisce la ragione alla spada, leggesi nel giornale del signor Archenholz, intitolato: La Minerva. L’articolo è sottoscritto dal signor Dietrikstein, che io non conosco, ma che ho ragion di credere essere al tempo istesso valentissimo scrittore e guerriero, poiché si mostra pronto egualmente a sostener contro di me colla penna e colla spada che il signor barone di Mack sia un eccellente condottiero di armata, ad onta che nel mio libro io avessi tentato di far credere il contrario. In veritá, io dichiaro che valuto pochissimo i talenti militari del generale Mack. Quando io scriveva il mio Saggio, avea presenti al mio pensiero la campagna di Napoli e la seconda campagna delle Fiandre, ambedue dirette da Mack: vedeva nell’una e nell’altra gli stessi rovesci e le stesse cagioni di rovesci; e credei poter ragionevolmente conchiudere che la colpa fosse del generale. Ciò che è effetto di sola fortuna non si ripete con tanta simiglianza due volte. Quando poi pervenne in Milano l’articolo del signor Dietrikstein, era giá aperta l’ultima campagna. L’amico, che mi comunicò l’articolo, avrebbe desiderato che io avessi fatta qualche risposta. Ma, due giorni appresso, il cannone della piazza annunziò la vittoria di Ulma, ed io rimandai all’amico l’articolo, e vi scrissi a’ piè della pagina: «La risposta è fatta».
Questo mio libro non deve esser considerato come una storia, ma bensí come una raccolta di osservazioni sulla storia. Gli avvenimenti posteriori han dimostrato che io ho osservato con imparzialitá e non senza qualche acume. Gran parte delle cose che io avea previste si sono avverate; l’esperimento delle cose posteriori ha confermati i giudizi che avea pronunziati sulle antecedenti. Mentre quasi tutta l’Europa teneva Mack in conto di gran generale, io solo, io il primo, ho vendicato l’onor della mia nazione, ed ho asserito che le disgrazie da lui sofferte nelle sue campagne non eran tanto effetto di fortuna quanto d’ignoranza. Fin dal 1800 io ho indicato il vizio fondamentale che vi era in tutte le leghe che si concertavano contro la Francia, e pel quale tutt’i tentativi de’ collegati dovean sempre avere un esito infelice, ad onta di tutte le vittorie che avessero potuto ottenere; e tutto ciò perché le vittorie consumano le forze al pari o poco meno delle disfatte, e le forze si perdono inutilmente se son prive di consiglio, né vi è consiglio ove o non vi è scopo o lo scopo è tale che non possa ottenersi.
Desidero che chiunque legge questo libro paragoni gli avvenimenti de’ quali nel medesimo si parla a quelli che sono succeduti alla sua pubblicazione. Troverá che spesso il giudizio da me pronunziato sopra quelli è stata una predizione di questi, e che l’esperienza posteriore ha confermate le antecedenti mie osservazioni. Il gabinetto di Napoli ha continuato negli stessi errori: sempre lo stesso incerto oscillar nella condotta, la stessa alternativa di speranze e di timore, e quella sempre temeraria, questo sempre precipitoso; moltissima fiducia negli aiuti stranieri, nessuna fiducia e perciò nessuna cura delle forze proprie; non mai un’operazione ben concertata; nella prima lega, il trattato di Tolentino e la spedizione di Tolone conchiuso e fatta fuori di ogni ragione e di ogni opportunitá; nella seconda, l’invasione dello Stato pontificio fatta prima che l’Austria pensasse a mover le sue armate, le operazioni del picciolo corpo che Damas comandava in Arezzo incominciate quando le forze austriache non esistevano piú; nella terza finalmente, un trattato segnato colla Francia, mentre forse non era necessario poiché si pensava di infrangerlo; i russi e gl’inglesi chiamati quando giá la somma delle cose era stata decisa in Austerlitz; l’inutile macchia di traditore, e l’inopportunitá del tradimento, e l’obbrobrio di vedere un re che comanda a sette milioni di uomini divenire, per colpa de’ suoi ministri, quasi il fattore degl’inglesi e cedere il comando delle sue proprie truppe entro il suo proprio regno ad un generale russo. Ricercate le cagioni di tutti questi avvenimenti, e trovate esser sempre le stesse: un ministro che traeva gran parte del suo potere dall’Inghilterra, ove avea messe in serbo le sue ricchezze; l’ignoranza delle forze della propria nazione, la nessuna cura di migliorare la di lei sorte, di ridestare negli animi degli abitanti l’amor della patria, della milizia e della gloria; lo stato di violenza che naturalmente dovea sorgere da quella specie di lotta, che era inevitabile tra un popolo naturalmente pieno di energia ed un ministro straniero che volea tenerlo nella miseria e nell’oppressione; la diffidenza che questo stesso ministro avea ispirata nell’animo de’ sovrani contro la sua nazione; tutto insomma quello che io avea predetto, dicendo che la condotta di quel gabinetto avrebbe finalmente perduto un’altra volta, ed irreparabilmente, il Regno.
Avrei potuto aggiugnere alla storia della rivoluzione anche quella degli avvenimenti posteriori fino ai nostri giorni. Riserbo questa occupazione a’ tempi ne’ quali avrò piú ozio e maggior facilitá di istruirmene io stesso, ritornato che sarò nella mia patria. Ne formerò un altro volume dello stesso sesto, carta e caratteri del presente. Intanto nulla ho voluto cangiare al libro che avea pubblicato nel 1800. Quando io componeva quel libro, il gran Napoleone era appena ritornato dall’Egitto; quando si stampava, egli avea appena prese le redini delle cose, appena avea incominciata la magnanima impresa di ricomporre le idee e gli ordini della Francia e dell’Europa. Ma io ho il vanto di aver desiderate non poche di quelle grandi cose che egli posteriormente ha fatte; ed, in tempi ne’ quali tutt’i princípi erano esagerati, ho il vanto di aver raccomandata, per quanto era in me, quella moderazione che è compagna inseparabile della sapienza e della giustizia, e che si può dire la massima direttrice di tutte le operazioni che ha fatte l’uomo grandissimo. Egli ha verificato l’adagio greco per cui si dice che gl’iddii han data una forza infinita alle mezze proporzionali, cioè alle idee di moderazione, di ordine, di giustizia. Le stesse lettere, che io avea scritte al mio amico Russo sul progetto di costituzione composto dall’illustre e sventurato Pagano, sebbene oggi superflue, pure le ho conservate e come un monumento di storia e come una dimostrazione che tutti quegli ordini che allora credevansi costituzionali non eran che anarchici. La Francia non ha incominciato ad aver ordine, l’Italia non ha incominciato ad aver vita, se non dopo Napoleone; e, tra li tanti benefíci che egli all’Italia ha fatti, non è l’ultimo certamente quello di aver donato a Milano Eugenio ed alla mia patria Giuseppe.
Lettera dell’autore a N.Q.
Quando io incominciai ad occuparmi della storia della rivoluzione di Napoli, non ebbi altro scopo che quello di raddolcire l’ozio e la noia dell’emigrazione. È dolce cosa rammentar nel porto le tempeste passate. Io avea ottenuto il mio intento; né avrei pensato ad altro, se tu e gli altri amici, ai quali io lessi il manoscritto, non aveste creduto che esso potesse esser utile a qualche altro oggetto.
Come va il mondo! Il re di Napoli dichiara la guerra ai francesi ed è vinto; i francesi conquistano il di lui regno e poi l’abbandonano; il re ritorna e dichiara delitto capitale l’aver amata la patria mentre non apparteneva piú a lui. Tutto ciò è avvenuto senza che io vi avessi avuto la minima parte, senza che neanche lo avessi potuto prevedere: ma tutto ciò ha fatto sí che io sia stato esiliato, che sia venuto in Milano, dove, per certo, seguendo il corso ordinario della mia vita, non era destinato a venire, e che quivi, per non aver altro che fare, sia diventato autore. «Tutto è concatenato nel mondo», diceva Panglos: possa tutto esserlo per lo meglio!
In altri tempi non avrei permesso certamente che l’opera mia vedesse la luce. Fino a ier l’altro, invece di princípi, non abbiamo avuto che l’esaltazione de’ princípi; cercavamo la libertá e non avevamo che sètte. Uomini, non tanto amici della libertá quanto nemici dell’ordine inventavano una parola per fondare una setta, e si proclamavan capi di una setta per aver diritto di distruggere chiunque seguisse una setta diversa. Quegli uomini, ai quali l’Europa rimprovererá eternamente la morte di Vergniaud, di Condorcet, di Lavoisier e di Bailly; quegli uomini, che riunirono entro lo stesso tempio alle ceneri di Rousseau e di Voltaire quelle di Marat e ricusarono di raccogliervi quelle di Montesquieu, non erano certamente gli uomini da’ quali l’Europa sperar poteva la sua felicitá.
Un nuovo ordine di cose ci promette maggiori e piú durevoli beni. Ma credi tu che l’oscuro autore di un libro possa mai produrre la felicitá umana? In qualunque ordine di cose, le idee del vero rimangono sempre sterili o generan solo qualche inutile desiderio negli animi degli uomini dabbene, se accolte e protette non vengano da coloro ai quali è affidato il freno delle cose mortali.
Se io potessi parlare a colui a cui questo nuovo ordine si deve, gli direi che l’obblio ed il disprezzo appunto di tali idee fece sí che la nuova sorte, che la sua mano e la sua mente avean data all’Italia, quasi divenisse per costei, nella di lui lontananza, sorte di desolazione, di ruina e di morte, se egli stesso non ritornava a salvarla.
- Un uomo – gli direi, – che ha liberata due volte l’Italia, che ha fatto conoscere all’Egitto il nome francese e che, ritornando, quasi sulle ali de’ venti, simile alla folgore, ha dissipati, dispersi, atterriti coloro che eransi uniti a perdere quello Stato che egli avea creato ed illustrato colle sue vittorie, molto ha fatto per la sua gloria; ma molto altro ancora può e deve fare per il bene dell’umanitá. Dopo aver infrante le catene all’Italia, ti rimane ancora a renderle la libertá cara e sicura, onde né per negligenza perda né per forza le sia rapito il tuo dono. Che se la mia patria, come piccolissima parte di quel grande insieme di cui si occupano i tuoi pensieri, è destino che debba pur servire all’ordine generale delle cose, e se è scritto ne’ fati di non poter avere tutti quei beni che essa spera, abbia almeno per te alleviamento a quei tanti mali onde ora è oppressa! Tu vedi, sotto il piú dolce cielo e nel piú fertile suolo dell’Europa, la giustizia divenuta istrumento dell’ambizione di un ministro scellerato, il dritto delle genti conculcato, il nome francese vilipeso, un’orribile carneficina d’innocenti ch’espiano colla morte e tra tormenti le colpe non loro; e, nel momento istesso in cui ti parlo, diecimila gemono ancora ed invocano, se non un liberatore, almeno un intercessore potente.
Un grande uomo dell’antichitá che tu eguagli per cuore e vinci per mente, uno che, come te, prima vinse i nemici della patria e poscia riordinò quella patria per la quale avea vinto, Gerone di Siracusa, per prezzo della vittoria riportata sopra i cartaginesi, impose loro l’obbligo di non ammazzare piú i propri figli. Egli allora stipulò per lo genere umano.
Se tu ti contenti della sola gloria di conquistatore, mille altri troverai, i quali han fatto, al pari di te, tacere la terra al loro cospetto; ma, se a questa gloria vorrai aggiungere anche quella di fondatore di saggi governi e di ordinatore di popoli, allora l’umanitá riconoscente ti assegnerá, nella memoria de’ posteri, un luogo nel quale avrai pochissimi rivali o nessuno.
L’adulazione rammenta ai potenti quelle virtú de’ loro maggiori, che essi non sanno piú imitare; la filosofia rammenta ai grandi uomini le virtú proprie, perché proseguano sempre piú costanti nella magnanima loro impresa…
NB. Ogni volta che si parlerá di moneta di Napoli, il conto s’intenda sempre in ducati: ogni ducato corrisponde a quattro lire di Francia.
I
INTRODUZIONE
Io imprendo a scriver la storia di una rivoluzione che dovea formare la felicitá di una nazione, e che intanto ha prodotta la sua ruina(1). Si vedrá in meno di un anno un gran regno rovesciato, mentre minacciava conquistar tutta l’Italia; un’armata di ottantamila uomini battuta, dissipata, distrutta da un pugno di soldati; un re debole, consigliato da ministri vili, abbandonare i suoi Stati senza verun pericolo; la libertá nascere e stabilirsi quando meno si sperava; il fato istesso combattere per la buona causa, e gli errori degli uomini distruggere l’opera del fato e far risorgere dal seno della libertá un nuovo dispotismo e piú feroce.
Le grandi rivoluzioni politiche occupano nella storia dell’uomo quel luogo istesso che tengono i fenomeni straordinari nella storia della natura. Per molti secoli le generazioni si succedono tranquillamente come i giorni dell’anno: esse non hanno che i nomi diversi, e chi ne conosce una le conosce tutte. Un avvenimento straordinario sembra dar loro una nuova vita; nuovi oggetti si presentano ai nostri sguardi; ed in mezzo a quel disordine generale, che sembra voler distruggere una nazione, si scoprono il suo carattere, i suoi costumi e le leggi di quell’ordine, del quale prima si
vedevano solamente gli effetti.
Ma una catastrofe fisica è, per l’ordinario, piú esattamente osservata e piú veracemente descritta di una catastrofe politica. La mente, in osservar questa, segue sempre i moti irresistibili del cuore; e degli avvenimenti che piú interessano il genere umano, invece di aversene la storia, non se ne ha per lo piú che l’elogio o la satira. Troppo vicini ai fatti de’ quali vogliam fare il racconto, noi siamo oppressi dal loro numero istesso; non ne vediamo l’insieme; ne ignoriamo le cagioni e gli effetti; non possiamo distinguere gli utili dagl’inutili, i frivoli dagl’importanti, finché il tempo non li abbia separati l’uno dall’altro, e, facendo cader nell’obblio ciò che non merita di esser conservato, trasmetta alla posteritá solo ciò che è degno della memoria ed utile all’istruzione di tutt’i secoli.
La posteritá, che ci deve giudicare, scriverá la nostra storia. Ma, siccome a noi spetta di prepararle il materiale de’ fatti, cosí sia permesso di prevenirne il giudizio. Senza pretendere di scriver la storia della rivoluzione di Napoli, mi sia permesso trattenermi un momento sopra alcuni avvenimenti che in essa mi sembrano piú importanti, ed indicare ciò che ne’ medesimi vi sia da lodare, ciò che vi sia da biasimare. La posteritá, esente da passioni, non è sempre libera da pregiudizi in favor di colui che rimane ultimo vincitore; e le nostre azioni potrebbero esser calunniate sol perché sono state infelici.
Dichiaro che non sono addetto ad alcun partito, a meno che la ragione e l’umanitá non ne abbiano uno. Narro le vicende della mia patria; racconto avvenimenti che io stesso ho veduto e de’ quali sono stato io stesso un giorno non ultima parte; scrivo pei miei concittadini, che non debbo, che non posso, che non voglio ingannare. Coloro i quali, colle piú pure intenzioni e col piú ardente zelo per la buona causa, per mancanza di lumi o di coraggio l’han fatta rovinare; coloro i quali o son morti gloriosamente o gemono tuttavia vittime del buon partito oppresso, mi debbono perdonare se nemmen per amicizia offendo quella veritá che deve esser sempre cara a chiunque ama la patria, e debbono esser lieti se, non avendo potuto giovare ai posteri colle loro operazioni, possano almeno esser utili cogli esempi de’ loro errori e delle sventure loro.
Di qualunque partito io mi sia, di qualunque partito sia il lettore, sempre gioverá osservare come i falsi consigli, i capricci del momento, l’ambizione de’ privati, la debolezza de’ magistrati, l’ignoranza de’ propri doveri e della propria nazione, sieno egualmente funesti alle repubbliche ed ai regni; ed i nostri posteri dagli esempi nostri vedranno che qualunque forza senza saviezza non fa che distrugger se stessa, e che non vi è vera saviezza senza quella virtú che tutto consacra al bene universale.
(1) Questo libro fu scritto nell’anno 1800, e quindi si comprende facilmente di quale ruina si vuol parlare.
II
STATO DELL’EUROPA DOPO IL 1793
Ma, prima di trattar della nostra rivoluzione, convien risalire un poco piú alto e trattenersi un momento sugli avvenimenti che la precedettero; veder qual era lo stato della nazione, quali cagioni la involsero nella guerra, quali mali soffriva, quali beni sperava: cosí il lettore sará in istato di meglio conoscere le sue cause e giudicar piú sanamente de’ suoi effetti.
La Francia, fin dal 1789, avea fatta la piú gran rivoluzione di cui ci parli la storia. Non vi era esempio di rivoluzione, che, volendo tutto riformare, avea tutto distrutto. Le altre aveano combattuto e vinto un pregiudizio con un altro pregiudizio, un’opinione con un’altra opinione, un costume con un altro costume: questa avea nel tempo istesso attaccato e rovesciato l’altare, il trono, i diritti e le proprietá delle famiglie, e finanche i nomi che nove secoli avean resi rispettabili agli occhi de’ popoli.
La rivoluzione francese, sebbene prevista da alcuni pochi saggi, ai quali il volgo non suole prestar fede, scoppiò improvvisa e sbalordí tutta l’Europa. Tutti gli altri sovrani, parte per parentela che li univa a Luigi decimosesto, parte per proprio interesse, temettero un esempio che potea divenir contagioso.
Si credette facile impresa estinguere un incendio nascente. Si sperò molto sui torbidi interni che agitavano la Francia, non tornando in mente ad alcuno che all’avvicinar dell’inimico esterno l’orgoglio nazionale avrebbe riuniti tutt’i partiti divisi. Si sperò molto nella decadenza delle arti e del commercio, nella mancanza assoluta di tutto, in cui era caduta la Francia; si sperò a buon conto vincerla per miseria e per fame, senza ricordarsi che il periglio rende gli entusiasti guerrieri, e la fame rende i guerrieri eroi. Una guerra esterna, mossa con eguale ingiustizia ed imprudenza, assodò una rivoluzione, che, senza di essa, sarebbe degenerata in guerra civile.
L’Inghilterra meditava conquiste immense e vantaggi infiniti nel suo commercio sulla ruina di una nazione che sola allora era la sua rivale. La corte di Londra, piú che ogni altra corte di Europa, temer dovea il contagio delle nuove opinioni, che si potean dire quasi nate nel seno dell’Inghilterra; e, per renderle odiose al popolo inglese, mezzo migliore non ritrovò che risvegliare l’antica rivalitá nazionale, onde farle odiare, se non come irragionevoli, almen come francesi. Pitt vedeva che gli abitanti della Gran Brettagna, e specialmente gl’irlandesi e scozzesi, eran disposti a fare altrettanto: la rivoluzione sarebbe scoppiata in Inghilterra, se gl’inglesi quasi non avessero sdegnato d’imitare i francesi(2).
L’Inghilterra, sebbene non fosse stata la prima a dichiarar la guerra, fu però la prima a soffiare il fuoco della discordia. L’Austria seguí l’invito della sua antica e naturale alleata. Le corti di Europa non conoscevano le repubbliche. Dalla perdita inevitabile della Francia speravano un guadagno sicuro. La Prussia l’avea giá ottenuto nel congresso di Pilnitz colla divisione della Polonia. L’Inghilterra e la Prussia mossero lo statolder, il quale volea distrarre con una guerra esterna gli animi non troppo tranquilli de’ batavi, resi da poco suoi sudditi, ed amava veder distrutti coloro che potevan essere un giorno non deboli protettori de’ medesimi.
La Prussia e l’Austria strascinarono i piccoli principi dell’impero, i quali, piú che dalla perdita di pochi, incerti, inutili dritti, che la rivoluzione di Francia avea lor tolti in Alsazia ed in Lorena, erano mossi dall’oro degl’inglesi, ai quali da lungo tempo erano avvezzi a vendere il sangue de’ propri sudditi. Il re di Sardegna seguí le vie di sua antica politica, ed avvezzo ad ingrandirsi tra le dissensioni della Francia e dell’Austria, alle quali vendeva alternativamente i suoi soccorsi, tenne sulle prime il partito della lega, che gli parve il piú forte. Finalmente anche la Spagna seguí l’impulso generale; e la guerra fu risoluta.
Si aprí la campagna con grandissime vittorie degli alleati; ma ben presto furono seguite dai piú terribili rovesci. I francesi seppero distaccar la Prussia dalla lega; la quale, ottenuta la sua porzione di Polonia, comprese che, tra due potenze di prim’ordine che si laceravano e distruggevano a vicenda, suo meglio era quello di rimaner neutrale.
La corte di Spagna s’ingelosí ben presto dell’Inghilterra, che sola voleva ritrar profitto dalla guerra comune. La condotta degl’inglesi in Tolone fece scoppiare il malumore che da lungo tempo covava nel suo seno, e Carlo quarto non volle piú impiegar le sue forze ad accrescere una nazione che egli dovea temere piú della francese. Mentre i suoi eserciti erano battuti per terra, le sue flotte rimanevano inoperose per mare; mentre i francesi guadagnavano in Europa, egli avrebbe potuto aver un compenso in America e dar fine cosí alla guerra con una vicendevole restituzione, senza quelle perdite che fu costretto a soffrire per ottenere la pace. Il desiderio de’ francesi era appunto quello che molti lor dichiarassero la guerra e niuno la facesse con tutte le sue forze; cosí ogni nuovo nemico dava ai francesi una nuova vittoria, e quella lega, che dovea abbassarli, serviva ad ingrandirli.
La guerra era ormai divenuta, come nell’antica Roma, indispensabile alla Francia, tra perché teneva luogo di tutte le arti e di tutto il commercio, che prima formavano la sussistenza del popolo, tra perché un governo quasi sempre fazioso la considerava come un mezzo di occupare e distrarre gli animi troppo attivi degli abitanti ed allontanare i torbidi che soglion fermentar nella pace. Quindi si sviluppò quel sistema di democratizzazione universale, di cui i politici si servivan per interesse, a cui i filosofi applaudivano per soverchia buona fede; sistema che alla forza delle armi riunisce quella dell’opinione, che suol produrre, e talora ha prodotti, quegl’imperi che tanto somigliano ad una monarchia universale.
(2) Tutto ciò era stato previsto da Burke. Egli solo tra gl’inglesi avea predetto che la guerra dovea per necessitá riuscir funesta, che l’interesse dell’Inghilterra era quello di far cessare la rivoluzione colla mediazione, ecc. ecc. ecc.
III
STATO D’ITALIA FINO ALLA PACE DI CAMPOFORMIO
In breve tempo li francesi si videro vincitori e padroni delle Fiandre, dell’Olanda, della Savoia e di tutto l’immenso tratto ch’è lungo la sinistra sponda del Reno. Non ebbero però in Italia sí rapidi successi; e le loro armate stettero tre anni a’ piedi delle Alpi, che non potettero superare, e che forse non avrebbero superate giammai, se il genio di Bonaparte non avesse chiamata anche in questi luoghi la vittoria.
Quando l’impresa d’Italia fu affidata a Bonaparte, era quasi che disperata. Egli si trovò alla testa di un’armata alla quale mancava tutto, ma che era uscita dalla Francia nel momento del suo maggiore entusiasmo e che era da tre anni avvezza ai disagi ed alle fatiche; si trovò alla testa di coraggiosi avventurieri, risoluti di vincere o morire. Egli avea tutti i talenti, e quello specialmente di farsi amare dai soldati, senza del quale ogni altro talento non val nulla.
Se le campagne di Bonaparte in Italia si vogliono paragonare a quelle che i romani fecero in paesi stranieri, si potranno dir simili solo a quelle colle quali conquistarono la Macedonia. Scipione ebbe a combattere un grandissimo capitano che non avea nazione; molti altri non ebbero a fronte né generali né nazioni guerriere: solo nella Macedonia i romani trovarono potenza bene ordinata, nazione agguerrita ed audace per freschi trionfi, e generali i quali, se non aveano il genio, sapevano almeno la pratica dell’arte. Bonaparte cangiò la tattica, cangiò la pratica dell’arte; e le pesanti evoluzioni de’ tedeschi divennero inutili come le falangi de’ macedoni in faccia ai romani. Supera le Alpi e piomba nel Piemonte. Costringe il re di Sardegna, stanco forsi da una guerra di cinque anni, privato di buona porzione de’ suoi domini, abbandonato dagli austriaci, ridotti a difendere il loro paese, a sottoscrivere un armistizio, forse necessario, ma al certo non onorevole, ed a cedere a titolo di deposito fino alla pace quelle piazze che ancora potea e che difender dovea fino alla morte. Dopo ciò, la campagna non fu che una serie continua di vittorie.
L’Italia era divisa in tanti piccoli Stati, i quali però, riuniti, pur potevano opporre qualche resistenza. Bonaparte fu sí destro da dividere i loro interessi. Questa è la sorte, dice Machiavelli, di quelle nazioni le quali han giá guadagnata la riputazione delle armi: ciascuno brama la loro amicizia, ciascuno procura distornare una guerra che teme. Cosí i romani han combattuto sempre i loro nemici ad uno ad uno e li han vinti tutti. Il papa tentò di stringere una lega italica.
Concorrevano volentieri a questa alleanza le corti di Napoli e di Sardegna, la prima delle quali s’incaricò d’invitarvi anche la repubblica veneta. Ma i «savi» di questa repubblica alle proposizioni del residente napolitano risposero che nel senato veneto era giá quasi un secolo che non parlavasi di alleanza, che si sarebbe proposta inutilmente; ma che, se mai la lega fosse stata stretta tra gli altri principi, non era difficile che la repubblica vi accedesse. Ma, quando il gabinetto di Vienna ebbe cognizione di tali trattative, vi si oppose acremente e mostrò con parole e con fatti che piú della rivoluzione francese temeva l’unione italiana!
Allora si vide quanto lo stato politico degl’italiani fosse infelice, non solo perché divisi in tanti piccoli Stati (ché pure la divisione non sarebbe stata il piú grave de’ mali), ma perché da duecento anni o conquistati o, quel che è peggio, protetti dagli stranieri, all’ombra del sistema generale di Europa, senza aver guerra tra loro, senza temerne dagli esteri, tra la servitú e la protezione, avean perduto ogni amor di patria ed ogni virtú militare. Noi, in questi ultimi tempi, non solo non abbiam potuto rinnovar gli esempi antichi de’ nostri avi antichissimi, i quali, riuniti, conquistarono tanta parte dell’universo, ma neanche quei meno illustri dei tempi a noi piú vicini, quando, divisi tra noi, ma indipendenti da tutto il rimanente dell’Europa, eravamo italiani, liberi ed armati.
Gli austriaci, rimasti soli, non poterono sostener l’impeto nemico: tutta la Lombardia fu invasa, Mantova cadde, ed essi furono respinti fino al Tirolo. Bonaparte era giá poco lontano da Vienna, l’Europa aspettava da momento a momento azioni piú strepitose; quando si vide la Francia condiscendere ad una pace, colla quale essa acquistava il possesso della sinistra sponda del Reno e dell’importante piazza di Magonza, e l’Austria riconosceva l’indipendenza della repubblica cisalpina, in compenso della quale le si davano i domíni della repubblica veneta. Questa, col risolversi troppo tardi alla guerra, altro non avea fatto che dare ai piú potenti un plausibile motivo di accelerare la sua ruina.
Per qual forza di destino avrebbe potuto sussistere un governo, il quale da due secoli avea distrutta ogni virtú ed ogni valor militare, che avea ristretto tutto lo Stato nella sola capitale, e poscia avea concentrata la capitale in poche famiglie, le quali, sentendosi deboli a tanto impero, non altra massima aveano che la gelosia, non altra sicurezza che la debolezza de’ sudditi e, piú che ogni nemico esterno, temer doveano la virtú de’ propri sudditi? Non so che avverrá dell’Italia; ma il compimento della profezia del segretario fiorentino, la distruzione di quella vecchia imbecille oligarchia veneta, sará sempre per l’Italia un gran bene. Ed io che, tra i beni che posson ricevere i popoli, il primo luogo do a quelli della mente, cioè al giudicar retto, onde vien poi l’oprar virtuoso e nobile; io credo esser giá sommo vantaggio il veder tolto l’antico errore per cui i gentiluomini veneziani godevan nelle menti del volgo fama di sapienti reggitori di Stato.
Il trattato di Campoformio era vantaggioso a tutt’e due le potenze contraenti. L’Austria, sopra tutto, vi avea guadagnato massimo; e, se rimaneva ancora qualche altro oggetto a determinarsi, era facile prevedere che a spese de’ piú piccoli principi di Germania essa avrebbe guadagnato anche dippiú. Ma era facile egualmente prevedere che l’Inghilterra, avendo sola tra gli alleati colla guerra guadagnato e dovendo sola restituire, esser dovea lontana dai pensieri di pace.
Il governo che allora avea la Francia, checché molti credessero, avea, almen per poco, rinunciato al progetto di democratizzazione universale, il quale, al modo come l’aveano i francesi immaginato, era solo eseguibile in un momento di entusiasmo. I romani mostravan di rendere ai popoli gli ordini che essi bramavano, ma non avevan la smania di portar dappertutto gli ordini di Roma. Quindi i romani conservarono meglio e piú lungamente l’apparenza di liberatori de’ popoli.
Ma il governo francese riteneva tuttavia il primiero linguaggio per vendere a piú caro prezzo le sue promesse e le sue minacce: eravi sempre una contraddizione tra i proclami de’ generali e le negoziazioni de’ ministri, tra le parole date ai popoli e quelle date ai re; e, tra queste continue contraddizioni, si faceva, ora coi popoli ora coi re, un traffico continuo di speranze e di timori.
Giá da questo ognuno prevedeva che il trattato di Campoformio avea sol per poco sospesa la democratizzazione di tutta l’Italia. Il re di Sardegna non era che il ministro della repubblica francese in Torino; il duca di Toscana ed il papa non erano nulla. Berthier finalmente occupò Roma; la distruzione di un vecchio governo teocratico non costò che il volerla; tale è lo stato dell’Italia, che chiunque vuole o salvarla o occuparla deve riunirla, e non si può riunire senza cangiare il governo di Roma. L’indifferenza colla quale l’Italia riguardò tale avvenimento mostrò bene qual progresso le nuove opinioni avean fatto negli animi degl’italiani.
IV
NAPOLI – REGINA
Rimaneva il regno di Napoli; e forse, almen per quel tempo, i francesi non aveano né interesse né forza né volontá di attaccarlo. Ma la parentela coi sovrani di Francia, l’influenza preponderante del gabinetto inglese, il carattere della regina, tutto contribuiva a fomentare nella corte di Napoli l’odio che fin da principio, piú caldo che ogni altra corte di Europa, avea spiegato contro la rivoluzione francese. La regina, nel viaggio che avea fatto per la Germania e per l’Italia in occasione del matrimonio delle sue figlie, era stata la prima motrice di quella lega che poi si vide scoppiare
contro la Francia. La forza costrinse la corte di Napoli a sottoscrivere una neutralitá, quando Latouche venne con una squadra in faccia alla stessa capitale. Forse allora temette piú di quel che dovea: se avesse prolungate per due altri giorni le trattative, la stagione ed i venti avrebbero fatta vendetta di una flotta che troppo imprudentemente si era avventurata entro un golfo pericoloso in una stagione pericolosissima.
La presa di Tolone fece rompere di nuovo la neutralitá. Al pari delle altre corti, quella di Napoli inviò delle truppe a sostenere una sciagurata impresa piú mercantile che guerriera, la quale, nel modo in cui fu immaginata e diretta, potea esser utile solo agl’inglesi. Nella primavera seguente inviò due brigate di cavalleria nella Cisalpina in soccorso dell’imperatore: esse si condussero molto bene. Ma le vittorie di Bonaparte in Italia fecero ricadere la corte ne’ suoi timori, e si affrettò a conchiudere una pace nel tempo appunto in cui l’imperatore avea maggior bisogno de’ suoi aiuti; nel tempo in cui, non presa ancora Mantova, non distrutte ancora tutte le forze imperiali in Italia, poteva, facendo avanzar le sue truppe, produrre un potente e forse pericoloso diversivo. Il governo francese ad una corte che non sapeva far la guerra seppe vendere quella pace, che esso avrebbe dovuto e che forse era pronto a comprare.
Perché si ebbe tanta paura della flotta di Latouche? Perché si credeva che in Napoli vi fossero cinquantamila pronti a prender l’armi in di lui favore. Non vi era nessuno, nessuno… Qual fu nella trattativa di questa pace il grande oggetto del quale si occupò la corte di Napoli? La liberazione di circa duecento scolaretti, che teneva arrestati nelle sue fortezze. Che non si fece, che non si pagò per far sí che il Direttorio non insistesse, come allora era di moda, per la liberazione de’ «rei di opinione»? La regina non approvava quella pace, e forse avea ragione; ma credette aver ottenuto molto, avendo ottenuto il diritto di poter incrudelire inutilmente contro pochi giovinetti che conveniva disprezzare… Non si perdano mai di vista questi fatti. La corte di Napoli non sapeva né che temere né che sperare: come si poteva pretendere che agisse saviamente?
La corte di Napoli era la corte delle irresoluzioni, della viltá ed, in conseguenza, delle perfidie. La regina ed il re eran concordi solo nell’odiare i francesi; ma l’odio del re era indolente, quello della regina attivissimo: il primo si sarebbe contentato di tenerli lontani, la seconda volea vederli distrutti. Ne’ momenti di pericolo, il re ascoltava i suoi timori e, piú de’ timori, la sua indolenza; al primo favore di fortuna, al primo raggio di nuove e liete speranze, per cagione della stessa indolenza, abbandonava di nuovo gli affari alla regina.
Acton fomentava nel re un’indolenza che accresceva l’imperio suo e della regina; e questa, per desiderio di comandare, non si avvedeva che Acton turbava tutte le cose e spingeva ad inevitabile rovina il re, il Regno e lei stessa. La regina era ambiziosa; ma l’ambizione è un vizio o una virtú, secondo le vie che sceglie, secondo il bene o il male che produce. Ella venne la prima volta da Germania col disegno d’invadere il trono, né si ristette finché, per mezzo degl’intrighi e dell’ascendente che una colta educazione le dava sull’animo del marito, non giunse a cangiar tutt’i rapporti interni ed esterni dello Stato.
Il marchese Tanucci previde le funeste conseguenze del genio novatore della giovine regina, e volle opporvisi fin da quel momento in cui pretese di aver entrata e voto nel Consiglio di Stato. Era questa una novitá inudita nel regno di Napoli, e molto piú nella famiglia di Borbone, ma la regina vinse e giurò vendicarsi di Tanucci: né la sua etá, né il suo merito, né li suoi lunghi e fedeli servizi poterono salvar questo vecchio amico di Carlo terzo ed aio, per cosí dire, di suo figlio dalla umiliazione e dalla disgrazia.
Sotto un re, debole inimico ed infedele amico, tutti compresero non esservi da temere, non da sperare, se non dalla regina; e tutti furono a lei venduti. Ella creò anche al di fuori nuovi sostegni all’impero.
Tutti gl’interessi politici univano il regno di Napoli a quello di Francia e di Spagna, e questi legami potevano formar la felicitá della nazione coi vantaggi del commercio e della pace. Ma gl’interessi della nazione poteano bene essere quelli del re, non mai però quelli della regina: ella volea nuovi rapporti politici, che la sostenessero, se bisognasse, contro il re e, se fosse possibile, anche contro la nazione. Noi diventammo ligi dell’Austria, potenza lontana, dalla quale la nazione nostra nulla potea sperare e tutto dovea temere; potenza, la quale, involta in continue guerre, ci strascinava ogni momento a prender parte negl’interessi altrui, senza poter mai sperare di veder difesi li nostri. La preponderanza che l’Austria andava acquistando sulle nostre coste offese la Spagna; ma la regina, lungi dal temere il suo sdegno, lo fomentò, lo spinse agli estremi, onde togliere al re ogni via di ravvedimento.
I ministri del re doveano esser i favoriti della regina; ma questa sacrificava sempre i suoi favoriti ai disegni suoi. L’ultimo è stato il piú fortunato di tutti, non perché avesse piú merito, ma perché avea piú audacia degli altri, li quali non combattevano con lui ad armi eguali, perché non si permettevano tutto ciò ch’egli ardiva fare. Conservavano ancora costoro qualche vecchio sentimento di giustizia, di amicizia, di pubblico bene: come contrastare con uno che tutto sacrificava alla distruzione de’ suoi nemici ed al favore della sua sovrana?(3).
Giovanni Acton venne dalla Toscana, cioè da uno Stato che non avea marina, a crearne una in Napoli. Avea due titoli, oltre un terzo che gli attribuisce la fama, a meritare il favore della regina: era, tra’ ministri del re, il solo straniero e seppe prima degli altri comprendere che in Napoli la regina era tutto ed il re era un nulla. Giunse nel tempo in cui ardevano piú che mai i disgusti colla corte di Spagna. Sambuca, che allora era primo ministro, prese il partito spagnuolo: fu male accorto e vile; perdette la grazia della regina e poco dipoi, come era inevitabile, anche quella del re. Si vide per poco suo successore Caracciolo: ma costui, rotto dagli anni e per natura portato all’indolenza, in una corte ove non si voleva il bene né si soffriva il vero, non fu che l’ombra di un gran nome e serví, senza saperlo o almeno senza curarlo, a far risplendere Acton, che la regina voleva esaltare, ma che ancora non poteva vincere la riputazione de’ piú vecchi. La morte di Caracciolo diede luogo finalmente ai suoi disegni: Acton fu posto alla testa degli affari, il vecchio De Marco confinato ai minuti dettagli di casa reale, tutti gli altri ministri non furono che creature di Acton. La sola parte d’ingegno, che Acton veramente possedeva, era quella di conoscer gli uomini. Non vi era alcuno che meglio di lui sapesse definire il carattere morale de’ suoi favoriti. Riputava Castelcicala vile e crudele nella sua viltá; Vanni entusiasta, ambizioso e crudele per furore quanto lo era Castelcicala
per riflessione; Simonetti e Corradini ambedue uomini dabbene, ma il primo indolente, il secondo pedante, ed incapaci ambedue di opporsi a lui. Si serví di Castelcicala fin da che era ministro in Londra.
(3) Il lungo favore, che costui ha goduto, potrebbe forse far credere a taluno ch’egli avesse qualche talento, almeno di corte… Non ne ha nessuno… non ha altro che la scelleraggine. Sarebbe mille volte caduto, se avesse avuto a fronte un altro scellerato.
V
STATO DEL REGNO – AVVILIMENTO DELLA NAZIONE
Acton e la regina quasi congiurarono insieme per perdere il Regno. La regina spiegò il piú alto disprezzo per tutto ciò ch’era nazionale. Si voleva un genio? Dovea darcisi dall’Arno. Si voleva un uomo dabbene? Dovea venirci dall’Istro. Ci vedemmo inondati da una folla di stranieri, i quali occuparono tutte le cariche, assorbirono tutte le rendite senz’avere verun talento e verun costume, insultarono coloro ai quali rapivano la sussistenza. Il merito nazionale fu obbliato, fu depresso e poté credersi felice quando non fu perseguitato (4).
Quel nobile sentimento di orgoglio, che solo ispira le grandi azioni, facendocene credere capaci; quel sentimento, che solo ispira lo spirito pubblico e l’amor della patria; quel sentimento, che in altri tempi ci fece esser grandi e che oggi fa grandi tante altre nazioni di Europa, delle quali fummo un tempo e maestri e signori, era interamente estinto presso di noi. Noi diventammo a vicenda or francesi or tedeschi ora inglesi; noi non eravamo piú nulla. Tante volte e sí altamente per venti anni ci era ripetuto che noi non valevamo nulla, che quasi si era giunto a farcelo credere.
La nazione napoletana sviluppò prima una frivola mania per le mode degli esteri. Questo produceva un male al nostro commercio ed alle nostre manifatture: in Napoli un sartore non sapeva cucire un abito, se il disegno non fosse venuto da Londra o da Parigi. Dall’imitazione delle vesti si passò a quella del costume e delle maniere, indi all’imitazione delle lingue: si apprendeva il francese e l’inglese, mentre era piú vergognoso il non sapere l’italiano (5). L’imitazione delle lingue portò seco finalmente quella delle opinioni. La mania per le nazioni estere prima avvilisce, indi ammiserisce, finalmente ruina una nazione, spegnendo in lei ogni amore per le cose sue. La regina fu la prima ad aprir la porta a quelle novitá, che ella stessa poi con tanto furore ha perseguitate. Una nazione, che troppo ammira le cose straniere, alle cagioni di rivoluzione che porta seco il corso politico di ogni popolo aggiunge anche quelle degli altri popoli. Quanti tra noi erano democratici solo perché lo erano i francesi? Sopra cento teste voi dovete contare, in ogni nazione, cinquanta donne e quarantotto uomini piú frivoli delle donne: essi non ragionano in altro modo che in questo: – In… si pettina meglio, si veste meglio, si cucina meglio, si parla meglio: la prova n’è che noi ci pettiniamo, mangiamo, ci vestiamo com’essi fanno. Come è possibile che quella nazione non pensi e non operi meglio di noi? (6).
(4) Un esempio. Il re una volta nominò Michele Arditi segretario del magistrato del commercio; lo nominò di moto proprio e senza la precedente proposta di Acton…
(5) …Omnia graecae,
cum sit nobis turpe magis nescire latine.
È un gran carattere di ogni nazione corrotta, dal tempo di Giovenale fin oggi.
(6) Nella stessa Francia la rivoluzione è stata preceduta da cinquant’anni di anglomania. Coloro che hanno pratica della letteratura francese lo potranno facilmente avvertire. Da cinquant’anni in qua i frances’istessi troppo disprezzavano le cose loro.