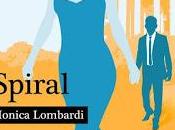Febbraio è il mese del revival natalizio: dopo il ritorno dei panettoni (l’avete mangiato, a san Biagio?), noi riproponiamo la cosiddetta “rosa di Natale”.
Sapete cos’è?
Lo so che avete letto il titolo, ma magari eravate distratti.
Siete stanchi delle solite brutture?
Odiate il grigio in tutte le sue sfumature?
Avete sfidato gli psicologi delle Forze Armate ammettendo, al questionario dei tre giorni, che sì, vi piacciono i fiori?
La primavera è la vostra stagione preferita?
Se avete risposto sì ad almeno una di queste domande, questa pagina è per voi.
Altrimenti, giratela.
L’elleboro, genere Helleborus, appartiene alla famiglia delle Ranunculaceae ed è originario di Europa (in particolare Caucaso) ed Asia Minore. Comprende circa 30 specie perenni, a fioritura invernale o primaverile precoce.
E’ una pianta fiorita ornamentale, che può essere sistemata sia nei giardini che in vaso.
I suoi fiori sono composti da cinque sepali di aspetto petaloide (ma non sono petali!), di vari colori e di lunga durata: i fiori rimangono inalterati per alcune settimane, anche da gennaio a marzo.
I colori dei fiori delle specie botaniche sono generalmente verdi tranne l’elleboro niger dal fiore candido e l’elleboro purpurascens, atrorubens e torquatus che presentano varie tonalità di porpora. Gli ibridi di elleboro orientalis hanno fiori bianchi, crema, giallo, rosa, porpora, viola e nero ed alcuni hanno puntini o venature sulla faccia interna dei sepali. Esistono anche ibridi a fiore doppio.
Considerando la loro epoca di fioritura, ovviamente non temono il gelo, nonostante questo screanzato provi ad abbatterle: basta che la temperatura torni sopra lo zero, per vederle risorgere con tutta la loro bellezza, come se nulla fosse.
H. foetidus: diffuso in luoghi sassosi e cespugliosi, dal fusto ramoso alto oltre i 50 cm, i suoi fiori sono campanulati e pendenti, di colore verde marginati di rosso-brunastro. Come possiamo dedurre dal nome, questa pianta emana un odore nauseabondo. Nonostante ciò, è il più utilizzato per la coltivazione in vaso e nei luoghi molto ombrosi, in particolare, mi viene da pensare, da chi soffre di rinite cronica
H. lividus Aiton o “elleboro di Corsica”: potete trovarlo anche in Sardegna
H. viridis o “elleboro verde o elleboro falso”: emana anch’esso un odore fetido, ha grandi fiori di colore verde o rossiccio. Ci dev’essere qualche differenza con il foetidus, ma mi sfugge.
H. odorus W.& K. : elleboro profumato (meno male)
H. bocconei (di Boccone) : diffuso in Centro e Sud Italia
H. niger: è quello “vero”, nero, noto anche con il nome di “rosa di Natale”. Vive nei luoghi erbosi e boscosi delle Alpi (dalla Val d’Aosta al Friuli). Raccolto indiscriminatamente in natura, soprattutto in Brianza, dove pare sia costume farne mazzi per i cimiteri. I brianzoli confermano?
Coltivare l’elleboro non è difficile, prendete nota per il prossimo anno: il luogo prescelto non dovrà essere molto soleggiato, però si richiedono un buon drenaggio e fertilità (vai di concime!).
Anche se mal sopportano i trapianti, la messa a dimora (generalmente di divisioni di cespi già “formati”) avviene in settembre-ottobre: abbiate la premura di lasciare 30-40 cm di distanza tra un cespo e l’altro e di non interrare la sommità degli apparati radicali a più di 2-3 cm di profondità. In vaso, che deve essere profondo perché le radici si sviluppano parecchio, mescolate in uguale misura terra leggera e terriccio.
In condizioni favorevoli, si possono addirittura riprodurre spontaneamente. Anche nel loro caso, se volete proprio seminarli, non aspettatevi risultati prima di aver dedicato loro tre anni di amorevoli cure.
I fiori sbocciano generalmente entro il primo anno di piantagione, se si è meno fortunati il secondo.
Se volete raccogliere qualche fiore reciso per metterlo in un vaso in casa vostra, sappiate che si conservano per circa una-due settimane.
E ora qualche curiosità.
L’elleboro è una pianta molto velenosa: ad esempio, se vengono ingerite radici o rizomi, questi possono provocare alterazioni del ritmo cardiaco, narcosi, vomito ed irritazione intestinale con diarrea profusa. Inoltre, è un allucinogeno noto sin dai tempi di Plinio il Vecchio (a cavallo dell’anno 0).
Perfino Petronio Arbitro lo cita, nel suo Satyricon [88,4]:”Chrysippus, ut ad inventionem sufficeret, ter elleboro animum detersit” , che sarebbe “Crisippo” (di Soli, filosofo stoico del III sec. a.C.)”per affinare la sua capacità percettiva, per tre volte si schiarì la mente con [una pozione di] elleboro”. Ah però!
Ma perché è comunemente chiamato Rosa di Natale? Secondo una leggenda, sarebbe stato portato in omaggio a Gesù Bambino da una povera pastorella che non poteva procurarsi doni più preziosi, e ne aveva trovato qualche piantina nei pressi della grotta natale.