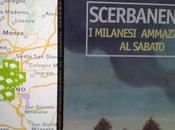Alfonso Berardinelli, Non incoraggiate il romanzo, Sulla narrativa italiana, Venezia, Marsilio, 2011.
Alfonso Berardinelli, Non incoraggiate il romanzo, Sulla narrativa italiana, Venezia, Marsilio, 2011.
_____________________________
di Eleonora Ruzza
Questa raccolta di articoli e brevi saggi, scritti a partire dagli anni novanta, appare come un’indagine sulla «veloce» e spesso «distratta» gestazione del genere romanzo nella narrativa italiana contemporanea. Mentre i tre capitoli centrali raccolgono recensioni sulla produzione di trentadue autori, da Carlo Emilio Gadda a Nicola Lagioia; la cornice rappresentata dal primo e dall’ultimo capitolo si preoccupa invece di raccogliere riflessioni teoriche sulla centralità del personaggio, sull’obbligatorietà della concatenazione, sul rapporto con il racconto, e la relazione tra la fictio romanzesca e la realtà.
Poiché oggi «i personaggi memorabili sono spesso gli scrittori stessi», Berardinelli sente la necessità di un ritorno ai presupposti del novel enunciati da Forster – e alle inferenze che Giacomo Debenedetti ne trasse nella sua teoria del personaggio romanzesco -, quando spiega come l’interesse per la storia sia subordinato alla possibilità per il lettore di indossare «un travestimento di bambini», con il quale «mettere alla prova» un «bisogno di avventura» (1). I readers hanno infatti la possibilità di assumere il duplice statuto di «povere cavie», a cui capita ogni sorta di peripezia, e di «staccati scienziati del destino umano». Il postulato forsteriano di una tale simulazione, si ricorda in un articolo datato 1992, consiste nel costruire characters disposti a non tenere nulla per sé, e ad abdicare così a un diritto di riservatezza reciproca, inviolabile nella vita reale (2).
Facendo proprio il punto di vista diacronico degli studi di Giacomo Debenedetti, Berardinelli riflette sui problematici personaggi novecenteschi, reduci dell’avvento della psicanalisi, le cui angosce e disagi emergono non da una narrazione onnisciente in terza persona, che fa coincidere «creatore» e «biografo», ma dalla discontinuità e intermittenza della prima persona. La visione di matrice hegeliana del romanzo quale epopea borghese si ritrova invece, nella ricostruzione del modo in cui si sviluppa il rapporto tra ambiente sociale e homo sapiens, e dell’effetto che tale mutamento ha nella finzione: dalla nascita del genere come corrispettivo letterario del dinamismo caratterizzante la lotta del bourgeois contro il potere aristocratico e clericale; al naturalismo che punisce gli atti individuali in favore dell’ambiente; fino all’inasprimento novecentesco del conflitto e la trasformazione del personaggio in una «emanazione dell’ambiente sociale», ovvero di una «ridicola marionetta», «spesso incapace di uscire dalla propria fantasticheria» (3).
A questa evoluzione partecipa anche il romanzo italiano? Nella sua «immobilità, disperata, grottesca, comica» risponde Berardinelli, la borghesia italiana non è moderna, e preserva nella sua proiezione letteraria: da un lato una costante macchiettistica, a discapito del personaggio a tutto tondo (come sostenuto da Enzo Siciliano) [4]; dall’altro lato una fuga nell’«intensificazione poetica» a discapito di una trama quale rete di cause ed effetti, in grado di estendersi in una visione d’insieme. La peculiarità italiana non è data tanto dall’impossibilità delle connessioni, ma dal loro “esubero”, giacché i molteplici nessi esistenti, mai chiariti, provocano una paralisi «da un eccesso di storia (che non diventa coscienza), e da un’immaturità perpetua»(5).
Incerto sembra essere allora l’uso delle due leve su cui agire per pervenire a quello che il teorico russo Boris Tomaševskji considerava l’obiettivo di ogni romanziere, ovvero «incantare l’attenzione del lettore», tramite a) la concatenazione delle vicende, e b) l’effetto di realtà, concepito come drammatizzazione del rapporto tra l’io e il mondo. Se il presupposto di una dialettica tra «l’esistenza individuale e l’essere collettivo» è la presenza di una società, dove vi sia una vera possibilità di azione, si comprende la ragione per cui la società italiana moderna, con la sua scarsa dinamicità e ridotta fiducia negli individui, abbia prodotto degli «anti-personaggi», «pigri e contemplativi», sempre a rischio di annegamento nell’irrealtà. È come se l’etica dell’azione si affievolisse in presenza di una natura «spontaneamente classicista», che dipinge un mondo sensibile «eternamente uguale a se stesso» (6).
Non sorprende allora che la critica letteraria sviluppi nel nostro Paese, una contrapposizione tra lo «scrivere bene» della prosa d’arte, teorizzata da Contini, e lo «scrivere male» della narrativa vera e propria, sulla cui responsabilità conoscitiva indaga Giacomo Debenedetti, nella sua strenua ricerca del vero e soddisfacente romanzo italiano.
Berardinelli vede «in tale fragilità della tradizione romanzesca italiana» le ragioni di un «destino infelice» che si manifesta nell’irresoluzione del Pasticciaccio (1957) di Gadda con la sua assenza di personaggi «se non fittizi o pretestuosi, o simili a groppi di materia», dove non esiste una vera trama «perché niente avrà esito, non ci sarà una conclusione, […] nessuno verrà giudicato o punito» (7). Incarnazione dell’immobilità italiana che sottende la trasformazione rapida imposta dagli eventi storici è anche Il Gattopardo, « sia dal punto di vista dello stile e della tecnica narrativa (manieristica, neo-tradizionale o postmoderna)», sia dal punto di vista tematico e culturale.
Dopo che l’arte classica del romanzo, era stata «demolita o radicalmente modificata», sembra dire Berardinelli, il trasformismo garantisce una mera sopravvivenza del romanzo ma non la sua rinascita. Così, se è vero che Moravia descrive «l’insufficienza del reale» e il vuoto della borghesia, al di là di quel mondo l’autore riesce a vedere solamente «evasioni momentanee»: fughe nell’esotico, nell’irrazionale». Della stessa difficoltà nella rappresentazione del reale risentono i filtri simbolici e mitologici di Conversazione in Sicilia, dove Vittorini, «autore di intuizioni primarie e senza sviluppo» dipinge per sua stessa ammissione un luogo allegorico «non localizzato» in cui l’esperienza può essere declinata solo in termini universali (8).
Portatore della patologia italiana del romanzo è anche Raffaele La Capria, la cui «vocazione a rispondere alle domande elementari e cruciali» del vero novelist – «chi sono e in che mondo (in che modo) si è svolta la mia vita» -, non placa la tendenza al «racconto di riflessioni e divagazioni», sotto le quali soccombe il plot. Mentre il Beradinelli ventenne aveva visto ne L’urlo e il furore il romanzo moderno come lo «sognava» per il suo tessuto di percezioni dense e forti, ora La Capria viene definito in maniera ossimorica come «più antico del romanzo» e al contempo «più giovane», perché
«il romanzo è un genere civile, ma anche barbarico. Richiede una fede morale, una religiosità analitica, una smania di verità, una sete di destino, di giudizio, di chiarificazione che noi italiani non abbiamo». […] Hanno scritto romanzi su romanzi quei popoli che erano in vena di conquistare il mondo, che volevano esplorare la natura, costruire la società, conoscere e dominare se stessi. Per noi, fra Cinquecento e Ottocento, era già tardi. E ora siamo in una specie di “aldilà” della cultura» (9).
La struttura parattatica e asindetica usata dal critico per costruire il proprio discorso crea spesso un corrispettivo sintattico del fenomeno contro cui diversi articoli della raccolta polemizzano, ovvero la sovrapproduzione di parallelepipedi cartacei, registrata negli ultimi due o tre decenni, durante i quali l’essenza romanzesca è divenuta inversamente proporzionale al numero delle pubblicazioni. Sebbene il romanzo abbia infatti goduto di una rifioritura a partire dall’uscita di Cent’anni di solitudine nel 1967, grazie ad un favorevole stato di democrazia anche letteraria, si tratterebbe di una «seconda giovinezza» minacciata dalla moltiplicazione dei romanzieri. Forse è proprio la società democratica a mettere a repentaglio la vita del romanzo, ipotizza Berardinelli, facendo propria la tesi di Abraham Yehoshua (nel suo saggio La democrazia uccide il romanzo), secondo cui l’incisività e l’autorità artistica del novel si perdono, quanto più si rafforzano e diffondono le pari opportunità culturali, che offrono «a tutti la possibilità di essere tutto: anche romanzieri», al fine di dare poter dare un senso ai fatti della loro vita. Diverso era invece in origine lo scopo dei creatori di personaggi, che perdevano la propria identità e libertà, o almeno se ne dimenticavano, per assolvere al compito di «incontrare altro e altri», lasciando al poeta l’incontro di «se stesso nei propri versi (10).
Infine, se dissuadere dalla scrittura del romanzo sembra essere per Berardinelli una inevitabile forma di salvaguardia dello stesso, è forse utile a chi nel 2011 volesse azzardare delle considerazioni sulle questioni teoriche sollevate, osservare come la Grande Democrazia dei social network abbia modificato la visibilità della vita privata, fino a causare il declino della clausola di segretezza, in cui Forster vedeva in primo luogo una condizione necessaria di esistenza in questo pianeta, e in secondo luogo l’origine di quel bisogno di conoscenza che lega il lettore all’homo fictus romanzesco. Allora è lecito chiedersi se nella sua nuova giovinezza il character non abbia piuttosto assunto le sembianze di un «profilo» in un face-book.
_____________________________
NOTE
(1) A. Beradinelli, Non incoraggiate il romanzo, Sulla narrativa italiana, Venezia, Marsilio, 2011, pp.16-17.
(2) Cfr. E. M. Forster, Aspetti del Romanzo, Milano, Mondadori, 1968.
(3) A. Beradinelli, Non incoraggiate il romanzo, Sulla narrativa italiana, Venezia, Marsilio, 2011, p.23.
(4) Cfr.E. Siciliano, Racconti Italiani del Novecento, Milano, Mondadori, 2001.
(5) Ibid., p.172.
(6) Ibid., p.168.
(7) Ibid., p.42.
(8) Ibid., pp. 72-73.
(9) Ibid., pp. 86-87.
(10) A. Beradinelli, Non incoraggiate il romanzo, Sulla narrativa italiana, Venezia, Marsilio, 2011, p.120.
_____________________________
[Leggi tutti gli articoli di Eleonora Ruzza pubblicati su Retroguardia 2.0]