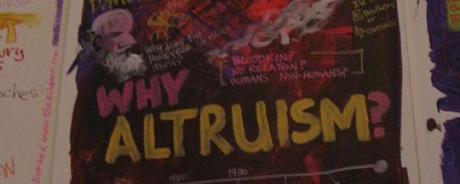
Provocazione tratta da Il disagio della civiltà, di Sigmund Freud.
“Ama il prossimo tuo come te stesso”, è una frase nota in tutto il mondo, è certo più antica del cristianesimo, che la considera la sua più straordinaria rivendicazione, ma altrettanto certamente non è antichissima; in epoca storica era ancora ignota al genere umano.
Nei suoi confronti vogliamo assumere un atteggiamento ingenuo, come se la sentissimo per la prima volta. Non potremmo allora reprimere una sensazione di sorpresa e turbamento. Perché dovremmo farlo? Che vantaggio ne ricaveremmo? E soprattutto, come ci arriviamo? In che modo possiamo farlo?
Il mio amore è una cosa preziosa che non ho il diritto di sprecare sconsideratamente. Mi impone doveri ai quale devo adempiere facendo sacrifici. Se amo una persona, questa se lo deve in qualche modo meritare. Lo merita se per aspetti importanti mi assomiglia al punto che in lei posso amare me stesso; se lo merita se è tanto più perfetta di me che in lei posso amare l’ideale di me stesso; devo amarla se è il figlio del mio amico, perché se le accadesse qualcosa, il dolore del mio amico sarebbe anche il mio dolore, lo dovrei condividere.
Ma se mi è estranea e non riesce ad attrarmi per nessun valore proprio, per nessun significato già acquisito nella mia vita emotiva, allora amarla mi risulterà difficile. Facendolo, compirei addirittura un’ingiustizia, perché tutti i miei cari considerano il mio amore un segno di privilegio; se equiparo l’estraneo a loro, compio un’ingiustizia.
E se invece lo devo amare con quell’amore universale solo perché anche lui è un essere di questa terra, come l’insetto, il verme, la biscia, allora temo che gli toccherà una porzione d’amore piccola, certo inferiore a quella che, secondo il ragionevole giudizio, sono autorizzato a trattenere per me stesso. A che serve un precetto enunciato con tanta enfasi, se il suo adempimento non appare sensato?
Foto | Flickr
