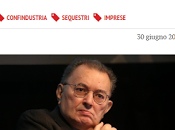Antonio Bux, “Sistemi di disordine quotidiano”, Achille e la Tartaruga, Torino 2015
[…] Bux afferma che il dolore è la semplicità arresa al pensiero dominante. E che il logos è il non luogo per eccellenza, la morte di Dio. Il pensiero resta quindi la prima e unica sofferenza. Questa scrittura tende a farsi perfettamente, ed in modo inevitabile, perciò referto clinico. Bux denuncia se stesso alla poesia, e lo fa testimoniando un’energia mancata, solo accennata, costruendo e demolendo, nell’esattezza della propria opera, l’esercizio della parola mediante il paradigma dell’esistenza. […] (Dal risvolto di copertina a cura di Cristina Annino)
Dalla prima sezione “Scotomi”
MACCHIE DELL’ORIGINE
I
“La memoria
si genera
per ombre,
e solo conserva
il suo lato
retrostante”
Per osservare, l’occhio ha bisogno di chiudersi. Quando nel buio della palpebra ritira il suo arco, l’orizzonte si allarga così tanto, che diventa impossibile mancare il bersaglio. Ed è allora che la sua percezione — la freccia che colpisce ogni oggetto — affina la propria punta, marcando sempre il centro. Ma quando si riapre, lo sguardo, distorce proprio sul traguardo, rientra presto nel suo difetto. Perché nella visione vi è come un mancamento, un riflesso di luce che non rispecchia la forma, ma ne lascia intravedere un alone sottile, una polvere che compone l’errore. Perché le cose esistono solo se le si guarda. Dunque la vista è un effetto collaterale del senso, l’emancipazione di qualcosa già marcio, che ristagna prima di maturare. Per questo il pensiero è una spora ammuffita, nel passaggio tra il messaggio della visione e lo stimolo che pulsa nella mente. Sa di doversi sviluppare attraverso il negativo del vedente, nell’ombra dell’equivoco tra ciò che si pensa e quel che si guarda, e perciò si inventa una traiettoria, un disegno nel quale sopravvivere, aprendo ai suoi lati le macchie del tempo, un fotogramma diverso, il linguaggio inesprimibile: ciò che esiste solo dietro le sue spalle.
*
“Gli echi di sempre
alle spalle di un’eco
più grande; di dietro
si sente che ti fa eco
da sempre negli echi
un indietro più grande
più avanti del sempre”
Lo spavento misero, insaziabile della parola:
vuoto che non sa dell’aria il misticismo lento,
ché il detto cova in sé per sua natura il male
come un’ombra che taglia l’aria di un’innaturale
mancanza; e che son resti le spoglie del comune
disapprendere il perdono, nella clemenza della vista
che protrae a derivare quel che non si può tenere;
e più di questo dentro il cielo come un dire niente
ancora a misurare scherno o voto o nera assenza
di terra che non squarcia, ma che cresce in superficie
da ogni lato la sventura tutta amata, tutta in fuori
di silenzio aperto in bocca, e mantiene tutto a galla
ma poi calma rientra dentro, si sottrae agli avvoltoi
fino all’osso della forma, si tradisce, si fa gabbia.
*
“Se l’occhio anche vuole la sua parte
allora lo sguardo è la metà dell’intero,
ché l’altra parte non è solo la metà
ma l’opposto emisfero, di quel che si vede
solamente stando a metà: sfinge che doppia
del suo doppio la parte migliore, il mezzo perfetto
che sdoppiando la perfezione, si scopre dall’altra parte”
La visione tocca il già visto mentre l’occhio
scruta di dentro l’immagine interiore,
quella che infine vede. Questo è l’anti-morire:
si continua a prevedere la mossa
anche quando un chiarore brucia la vista
e il mondo riappare solo per scomparire.
[…] Questo è l’anti-morire: / si continua a prevedere la mossa / anche quando un chiarore brucia la vista / e il mondo riappare solo per scomparire”. In questo senso, il futuro, la possibilità di una vita, è all’interno, come afferma in epigrafe Bux, ed è conservazione. Cioè anche tradizione. Perché se noi non sappiamo ancora quale oscura catastrofe storica incombe di nuovo sull’Occidente, qual che è certo è che nella poesia italiana più lungimirante i segni ci sono tutti. […] (breve estratto dalla nota a cura di Giovanna Frene)
Dalla seconda sezione “L’inversa voce del respiro (L’orale nastro di Mobius)”
ESSERCI È SOLO UN NOME
“Sapere l’umiliazione provando a dire
cosa, se non l’abisso del proprio sapere
niente. Di più umiliante non c’è altro
che voler provare ciò che mai si proverà
se non stando zitti, nell’attesa di un aldilà”
Credo che l’appartenenza ad un nome significhi poco. È quel suono nella denuncia, quella modifica della lingua, che poco a poco connota e significa il corpo. Ci si modella in base alla melodia, all’essere in cerca di sintonia. Per questo, quando sento chiamarmi “Antonio!” prorompo, divento uno strumento. Forse mi arrotondo, cerco una protezione curvando sulla O, prima ancora dell’attacco mi difendo, tornando all’ultima mia vocale. Dunque capisco che esserci è un difetto di pronuncia, un’allitterazione nominale. Ci si chiama per darsi forma, una sorta di pietà del sistema letterale. Per questo, quando mi sento dentro, muto in clonazione verbale, e mi cancello, chiamandomi all’indietro. Divento parte del respiro, un sincrono spezzato, nell’inversione musicale:
io cosa innominata, mia perfetta stonatura.
*
“Poiché voce e respiro
mai davvero coincidono,
vaga il pensiero invertito
per la nemesi dell’aria”
Come dire la parola. Praticamente
un cerchio annodato alla gola.
Nel suono dell’immagine cancellando
il suo ritmo, il senso musicale,
non il vortice, piuttosto il pergolato
dove l’aria ripara gli oggetti più inutili
— le ariose stanze della comunicazione —
quando il sole non rivolge che l’ombra
nell’angolo del respiro — il limitare oscuro —
sull’uscio nella casa del verbo. L’uscita
è dunque zittirsi, confondere la densità
del cervello mentre si apre nel dettaglio
del discorso, al movimento dell’intesa:
così quindi censurare le labbra pettegoli,
perché il muro della lingua è la protezione
dall’infezione del mondo che si parla solo.
*
“Nella corona aperta della lingua
un cono senza punta la voce
che buca il piano del respiro,
l’orale nastro del pensiero”
La mano riscritta a memoria dalla pagina
nella pagina della mano riscritta a memoria
dalla mano che è memoria, riscritta al contrario
il contrario che è la pagina, riscrivendosi a memoria
nella memoria del contrario, che è il riscrivere la pagina
dalla mano della storia inciampando contro il verso
dove il verso è l’inciampo della memoria, nella pagina
che è storia, riscrivendosi al contrario, ma il contrario
non è la memoria del verso, nella storia della pagina?
Forse la pagina è solo il contrario della memoria
nella storia della mano riscrivendosi a pagina
la memoria della pagina, nel verso della storia
o la mano della memoria, nella pagina del verso
o la storia della pagina che è memoria della mano
nella pagina della storia che è un verso a memoria
nel riscrivere della mano, la storia del contrario.
*
“Una linea traccia il segno opposto
al margine del passo volto al bianco
nella pagina scomposta in frammenti:
allora è una protesi di intese la mano
che dilata lo spazio nel buco della voce”
Esordiremo al di là. Non importa
se sarà la vanga o il piccone
del verso, ciò che inciderà
la traccia dell’abisso. Lì troverà
l’universo la sua precipitazione.
E del resto, ben poco si alzerà
dal fuoco incavo del mezzogiorno,
e niente muoverà l’ombra del masso,
neanche l’aria dal ventre mutando
il solco del prossimo sotto la terra;
ma più denso il cammino, guardando indietro:
un feretro di vetro per ogni sguardo rifletterà
la scritta fragile, l’indicibile interno, l’incudine
senza peso, dove galleggiando sprofonderà l’ago
del nostro vincolo. Ma noi non verremo a bucare
l’angolo più sicuro del giorno; piuttosto cuciremo
la morte ai suoi strappi, portandone la ferita sorridente
nella condivisione del graffio, la solitudine della difesa.
[…] La fragilità dell’Io è dunque ancora una volta dovuta allo sdoppiamento dell’uomo che si considera un sopravvissuto, un assoluto outsider. Proprio questa scorza che è divenuta ormai la sua vera sostanza, e che la realizzazione di sé non potrà annullare mai, pur riconoscendo la propria condanna, non rinuncia ad una speranza seppur velata di tristezza consapevole, per la quale è disposto a stringere un patto con il destino: scontare la salvezza della poesia con il proprio fallimento. Un uomo d’altri tempi dunque, Bux, dal quale imparare la grazia ed il coraggio non solo del vivere ma anche del poetare, soprattutto nella disarmonia. […] (breve estratto dalla nota a cura di Antonella Pierangeli)
Dalla terza sezione “Muri palindromi”
COME SBAGLIO UNA CASA
“C’è un uomo in un quadrato
chiamato stanza che scrive
su una tastiera e osserva
in un altro quadrato tanti
piccoli uomini che stanno
in altri esterni quadrati chiamati
stanze che scrivono su delle tastiere
mentre osservano dei quadrati
stanze dove altri uomini stanno
facendo ognuno il proprio quadrato
mentre svuotano le stanze degli altri”
Ascolto, in contro tempo, il fruscio della casa: ed è un silenzio che viene prima delle pareti, questo stringersi a coda tra le cose, questo imprimere presenza dietro le tende, il nascondersi degli ori nelle polveri, pianeti sorti troppo presto tra le tapparelle, dove molteplici universi filtrano in un pulsare di bagliori. E così, presto la stanza si riduce di striscio: drasticamente le ante degli armadi riflettono in se stesse la magia dell’ombra, dentro le pieghe delle stoffe a proseguire, l’incognita della forma, fino all’abbaglio della plafoniera, dove decine di moscerini costruiscono un paradiso al neon. Quaggiù invece, si dispongono le mattonelle a mosaico, mentre io, per paura di sbagliare casella, resto fermo su di un battente sicuro, verticale alla porta, aspettando di diventare una nuova pedina, un quadratino da stringere alla superficie. Vivo in uno spazio esile, pochi centimetri a torto, con un perimetro nella testa, che non smetto mai di attraversare. Ho timore della polvere, delle finestre troppo aperte. Costruisco porte senza manici, con soli spioncini al centro, fessure da restringere. E fisso punti precisi nel muro, ma non ho muri. Prediligo i cuscini ai divani. Le foto di spazi bianchi. Nel lato del salone vivo il silenzio, mentre il bagno non esiste, il rubinetto lo tengo al collo. Questa casa è un cubo di Rubik: alla rinfusa si propone nella vista, nell’occhio che muove le visioni per un ordine privato, ruotandole fino a risolverne la perfetta geometria, di un quadrato che proietta in un quadrante, ad incastro ogni singolo tassello intermittente, dietro questa polveriera di un istante. Ad oggi, però, non vi è modo di trovare la soluzione, nella disfatta della percezione. Rimane, questa casa, una speranza di scatti. Come ieri, che per colpa di una
sedia girata per sbaglio, il quadro finale non ha potuto chiudersi, ed è rimasto là dentro, così storto da non farmi dormire. E, così, ogni giorno un oggetto si muove apposta, per
fallire il meccanismo. Mentre oggi, l’indiziato ingombrante sono io, attaccato alla moquette per paura di procedere, non sapendo la proporzione tra ciò che, perfetto, prolifera nel caos. I moscerini, intanto, abitano la sfera di vetro nel soffitto. Sembrano
non curarsi dell’ammanco matematico che li mantiene in vita, dell’incongruenza materiale che sostenta il loro volo, e paiono soddisfatti del proprio planare impreciso nell’orbita di un soffio di vita. Mentre io, che fatico a respirare, immagino il mio respiro interferire con l’aria, e mi fermo a pensare che potrebbe, un mio alito, spostare un filo di polvere e appesantire quel ritratto sul davanzale. Potrei rovinare tutto, smontare il piano sequenziale di settimane! Perciò protendo nel respiro, un cumulo nel ventre, mentre con le mani trattengo il resto, la bocca, il naso e tappo tutto, mi conservo in quel cesello, neanche mangio, né mi vesto, piuttosto sogno quel che manca, tutto il resto; e vivo lì fermo, come prestato e dritto, conforme al pavimento, nell’attesa di finire, sto lì zitto, nel mio vuoto stare algebrico, spento dentro, in quell’essere distante e marginale, un gesto alchemico, molecola artificiale; e così mi lascio andare, morendo in un doppiofondo, lasciando solo il ricordo aperto di una casa tenuta male, di quel male taciuto bene: di questo piccolo, astuto gioco — così profondo — al quale non ho saputo partecipare.
*
“Perché se ipocondria è un nome
difficile, anche la malattia del dovere
rientrando comunque nella cappa verbale,
è il chiamarsi con l’ombra delle domande:
ché i nomi sono solo la polvere rimasta
in superficie, non la pista percorribile,
piuttosto il giro incompleto della lingua,
dove il fondo non è mai il fondo che resta
zitto al bordo tra i risvolti senza pronuncia”
Una volta il mio nome era diverso.
Si girava dopo un richiamo al mio posto.
Procedeva sicuro tra le carte, si proclamava solo
perfino, come a dire, mi basto da me per sapere.
Ma oggi il mio nome non si chiama. Si lascia citare
da altri nomi, e finanche i soprannomi lo scalzano:
Tonino, Tony, Anto. Poi pure gli pseudonimi
si aggiungono alla messinscena: nome nel nome
mentre Antonio Bux scrive, quell’altro cancella.
Ma chi mi nomina, lo sa che non sono io colui
che risponde, bensì l’altro nome, la lettera mancante?
E, proprio per questo, il mio nome si è depennato.
Tolto a prescindere dalla lista delle domande.
Ora a chiamarmi resta un corpo vuoto, in disparte
impaziente, come in attesa di essere registrato.
*
“Cresceva zitto lo zero parziale
mentre noi diventammo numeri
imprecisi calcoli, tavole spaccate,
e per una questione di centimetri
ci trovammo fuori dagli ultimi
come vocaboli identici, prosimetri
di codici neutrali, dividendi nostalgici
nell’imperfezione degli addendi,
e quando il cerchio si formò, sottraendo
la parabola dei topici, così sparimmo:
restammo unici, un po’ troppo molteplici”
Verità è se la nascondi
la tua piccola finestra
un po’ più in dentro dove
la luce acceca solo se riflessa
in altra luce che si spegne
per inerzia su di un lungo orizzonte.
Perché quella verità è se si mantiene
stretta al cardine della porta principale
— e non lasciarla scorrere — ti diranno
dall’altra parte percorrendo nella voce
oltre il muro, il suono verticale
che rende pari passo nel silenzio
schiavo il tempo mentre si tende
al suo contrario, passando per ritornare.
Ché di questa verità è cieco il mondo:
della menzogna primordiale
che mantiene accesso un fuoco
pur sapendolo spegnersi domani
quando celebrando la cenere
non dal legno o dalla breccia
della fiamma più insicura o dal ritaglio
di una sera andata storta, trasversale
si dirà che l’essere compare sempre
come vero se per fame o per bisogno
se ne rimane oltre il vuoto a cancellare
quel disegno che non sa di prolungare.
[…] Il poeta outsider risulta vivere, in definitiva, sul “discrimine invisibile che separa senso e non – senso” (è ancora Garroni che ce lo suggerisce), e la propria malleabile difformità gli plasma una maschera da hypokritès, nel senso in cui lo diceva il grande Alberto Savinio: lo hypokritès è colui che esamina la realtà da sotto la maschera, e che attraverso il filtro di questa fibrillante membrana ermeneutica attribuisce un senso perpetuamente provvisorio all’esperienza. È questo e nessun altro, in definitiva, il compito dell’arte e, specialmente, per Antonio Bux, della poesia. […] (breve estratto dalla nota a cura di Sonia Caporossi)