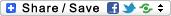Io non sono nato figo (e modesto, soprattutto), ci ho studiato per diventarlo. E Nicolas Winding Refn, il regista davanti al quale tutti sbrodolano in questo momento, me l’ha fatto conoscere la Zietta, che continuo a linkare nell’inconfessata speranza che torni, perché la Rete, da quando è andata via, non è più respirabile. Per di più, l’ho conosciuto in tempi non sospetti, per cui la mia ammirazione è genuina. Non “pilotata”, diciamo.
Prima Valhalla Rising, poi Bronson. Sempre la Zia a consigliare e a recensire in quel modo barocco, che appartiene solo a lei. E io a imparare la lezione, a guardare Refn sotto la luce dell’autore, di quello che se ne fotte del marketing, e fa il cinema che vuole lui, lontanissimo dalle languide carezze agli spettatori ingenui che intasano le sale (quando capita).
Da qualche giorno, spiando le statistiche degli accessi al mio blog, ho notato un ritorno di fiamma per il film vichingo, e mi sono messo a ridere.
Rido per tutti coloro, e sono moltissimi, schiere, che recupereranno i due precedenti lavori di Refn convinti di vedere due cloni di Drive, duri, fighissimi e disincantati, e che invece si ritroveranno fra le mani due film che, al più, li lasceranno sgomenti e annoiati.
Ecco la realtà: Valhalla Rising non parla di vichinghi, ma di cristianesimo, in un modo violento e metafisico;
Bronson non è il dramma carcerario “che piace a tutti”, quei tutti, me compreso, che non sognano di andare in galera, ma che adorano vedere galeotti che alla galera sopravvivono, ma metacinema, o metateatro, o una roba a metà tra il cinema e il teatro, tentativo colmo di superbia e incoscienza, di rappresentare la follia di un uomo, al secolo Michael Gordon Peterson, detto Charles Bronson, il detenuto più pericoloso d’Inghilterra.
Non è Ryan Gosling che troverete. Non attori bellocci e silenzi rarefatti, ma un tizio, Tom Hardy, che, partito dall’essere belloccio, è arrivato a fare 2500, tra flessioni e piegamenti, ogni giorno, pur di mettere su la massa muscolare necessaria per arrivare ad assomigliare al “vero” Bronson. Lo vedete in questa foto, sempre rubata alla Zia. E vi scappa il LOL.

***
Chi è Charles Bronson? È nato nel 1952 ad Aberystwyth, nel Galles, “dove anche le prostitute indossano il cilindro” (e, se avete letto la mia Ragazza, è una località che vi suonerà familiare). Incarcerato nel 1974 e condannato a sette anni, per una serie di episodi di violenza estrema, dei quali si rese protagonista coinvolgendo altri detenuti e secondini dei vari istituti di pena dove veniva puntualmente trasferito (si parla di 120 traferimenti da un carcere all’altro), vide la sua pena raddoppiarsi a quattordici anni, in virtù delle condanne aggiuntive. Uscito nel 1988, trascorse in libertà solo 69 giorni, prima di essere arrestato per rapina. Di nuovo fuori nel 1992, dopo 53 giorni venne imprigionato, stavolta per associazione a delinquere con finalità di rapina.
Nel 1999 fu addirittura istituita una speciale unità carceraria che si occupasse di lui e di altri due prigionieri violenti.
Nel 2000, la sua sentenza s’è trasformata in una condanna a vita, a discrezione dei giudici, dopo aver preso un uomo in ostaggio e aver posto condizioni deliranti per la sua liberazione.
L’anno scorso, si dice (anche se lui nega che il fatto sia mai accaduto) che, dopo essersi cosparso il corpo di burro (per rendere la presa delle guardie scivolosa), abbia picchiato sei secondini. Questo è Charles Bronson. Un tipo che Refn, non essendo cittadino britannico, non ha mai potuto incontrare in carcere, ma che ha sentito solo due volte per telefono.

***
Tom Hardy, l’attore, invece l’ha incontrato faccia a faccia. E Bronson ha rivisto sé stesso in lui. Roba pericolosa. Si parla di un individuo che ha negato la sua identità, fino a identificarsi col suo alter-ego, Charles Bronson, per l’appunto. È come se io mi convincessi di essere Hell. E manca poco.
Scherzi a parte, l’opera di Refn indaga sull’individuo, più che sul dramma carcerario che egli vive. O meglio, il carcere, lo squallore degli istituti di pena, fatti di colori sporchi, freddi, di luoghi piccoli e infami e sbreccati dove essere rinchiusi, di abusi psicologici, vengono filtrati attraverso gli occhi del protagonista. E non solo la galera, il mondo interno, ma le strade, i negozi, la famiglia, le donne, nei rari momenti di libertà, il pensiero intimo, tutto visto attraverso la lente speciale del detenuto Bronson, al limite della follia. Inquadrature strette, o distanti, focalizzate su di lui. Camera fissa, dialoghi ai limiti del surreale. Pubblico fittizio che applaude e ride come si trattasse di una sit-com.
Un uomo, Bronson, che sa fare a botte. Gli piace. E a cui non piace obbedire. Così, per principio. Non è neppure un anti-eroe. Direi, piuttosto, che Bronson è la variabile incognita di ogni società. Un uomo sul quale schematismi, norma e disciplina non possono attecchire, lasciando al contrasto, sempre cruento, il primo piano. Quasi che fosse, la lotta, l’unica condizione di vita accettabile.
Quindi, è attraverso i deliri di Bronson che noi veniamo catapultati in questa storia. Difficili, a tratti pesanti e noiosi, ma unici.
Si nota qui la predilezione di Refn per quel sound così caratteristico in Drive. Anche se alternato a Richard Wagner. In realtà è roba vecchia. Non è stato il bel faccino di Gosling a ispirarlo, ma i baffi a manubrio di Hardy, e di Bronson, quello “vero”, dietro le sbarre.

***
[qualche spoiler]
Metateatro. Bronson arriva a parlare con sé stesso, la sua coscienza, diviso in due, come Victor Victoria, per spiegare le ragioni delle sue scelte. Disillusione costante, l’incontro con una donna cinica e stronza, con personaggi che, a questo punto, è lecito domandarsi se fossero così pittoreschi dal vivo, nel mondo reale, o se non fossero gli occhi di Bronson a vederli così.
Nudità in primo piano. Niente di ché. Serve soltanto a rammentare l’episodio del burro citato sopra. La verità è che Bronson è un artista della violenza. Bravo a dipingere, perché no, ma anche bravo a spaccare teste in due.
Refn, che ormai ci ha viziato, dipinge quest’affresco complesso e disarmante per noi. E lo fa serbando un’imparzialità che spaventa, tanto è netta. Si pensa a un uomo chiuso in galera da quarant’anni circa, salvo brevi intervalli; si dirà che è il sistema a sbagliare, tanto quanto lui che non riesce a calmarsi? Il direttore di uno dei carceri è un perfido figlio di puttana, è vero. Eppure, eppure non si parteggia per nessuno, alla fine. Una storia pura, che si fa vedere e che, almeno a me, ha lasciato indifferente, persino quando, dopo l’ultimo exploit a base di nasi rotti, Bronson viene ingabbiato, in modo che sia costretto a stare in piedi, senza potersi sedere, e frigna la sua sofferenza. Ma si sa che quello è un bastardo violento come pochi. Si sa. E, da spettatore, lo vedi e basta. E non ti commuove affatto.

***
Ecco, Bronson è questo: un non-dramma carcerario. Sette anni di condanna che diventano una condanna a vita, perché lui continua a uccidere, come un ossesso. Viene picchiato, ma è sempre lì e non bastano dieci guardie a fermarlo.
Il paradosso è che su di lui, così com’è, in cella, si sono scritti libri, è stato girato un film. Fuori, sarebbe stato un impiegato qualunque, brutto e infelice.
E Refn è così che ce lo mostra, come una strana creatura, paradossale, che sogna la libertà, ma che per essere qualcuno deve essere prigioniero. Parabola unica, che pochi riescono a sostenere.
Altre recensioni QUI
La recensione su Valhalla Rising
La recensione su Drive
La recensione su Bronson di AgonyAunt