
Edvard Munch, La voce, 1893, olio su tela, Oslo, Munch-Museet
Di ANTONELLA PIERANGELI
Sembra una scena di teatro. Una giovane attrice sul palco. E’ vestita di bianco, in piedi e in primo piano. Alle spalle, un paesaggio serale illuminato dal crepuscolo. Sullo sfondo il verde dei boschi e il blu di uno specchio d’acqua. L’universo è fermo, chiuso in un segno deciso che incastona uomini e cose facendone un tutt’uno con lo sfondo. E’ una di quelle incarnazioni dello “Spirito del Nord”: dilatazione infinita, solitudine e attesa che prende alla gola come una stretta asmatica.
La voce di Munch, olio su tela del 1893 ora al Munch-Museet di Oslo, è un quadro che afferra lo sguardo e irretisce i sensi, sintesi e icona di tutti i temi della pittura scandinava che con la loro sospensione metafisica entrano nel grande movimento simbolista internazionale della fine del XIX secolo, dai francesi Nabis ai Secessionisti d’Austria e Germania, fino al profondo Nord. Tutti contagiati da identica malinconia, mancanza di prospettiva (anche pittorica) e un forte segno nero intorno alle figure perse in un’atmosfera di silenzio e mistero.
Nulla è vero, né verosimile in quest’opera, il titolo infatti rimanda ad una sorta di voce interiore o forse alla voce fuori campo di un narratore lontano dal palcoscenico.
Una donna quasi senza volto, schiacciata contro il fondale e muta guarda gli spettatori che guardano il quadro. La scena è una proiezione affettiva: la donna, il volto, il corpo con le braccia in unico blocco impenetrabile inchiodano lo spettatore in una stretta morsa di gelo tanto che quasi non le vediamo il volto, non le vediamo il corpo; non possiamo capire né intuire nulla della sua desolata compostezza dall’espressione del suo sguardo; noi siamo esclusi.
I solchi implacabili del nero sul tronco degli alberi formano una sequenza di segni urlanti, quasi panica partecipazione delle cose, per affondare poi in tratti violenti e materici, lunghi fino a scandire in sequenze la superficie della tela, diventando corpo essi stessi, diventando nell’impatto visivo solo una quinta nello scenario della natura, nella quale tutto ritorna nel suo biancore tragicamente illuminante. La drammaticità sembra però ad un tratto placarsi e il segno quasi distendersi in una calma più severa, nel chiarore innaturale del crepuscolo che avanza, in quello spazio metafisico dove donna e paesaggio sono ancora un tutto unico senza contrasti: la bianca figura femminile e il suo sguardo fisso in avanti, quasi funerea, tragica figura ectoplasmatica, decisa verso la sua vita, con la sola luminosità della veste inspiegabilmente accesa dalla sera, irradia infatti un soffuso chiarore che sbiadisce la scena fino a renderla evanescente, mentre un enigma in forma di pulviscolo si concentra sul viso della donna, dandole la forza, l’incisività, la personalità del trionfo totale, anche sulla natura.
L’impenetrabilità, la sensazione di un recinto chiuso e invalicabile, la geniale invenzione di quello sfondo blu oltre le betulle fantastiche e irreali, contraggono e raffigurano l’isolamento, l’impossibilità assoluta di continuare, perché non c’è una via, la sospensione del giorno è infatti sosta esistenziale.
Quella figura non ha scelta, dovrà – trovata la consapevolezza del suo esistere nella concentrazione della solitudine – volgersi per ritornare e naufragare in un’assenza di realtà senza soluzione di continuità tra figura e natura.
Serrato, cupo, scarnificante, Munch porta con sé l’essenzialità e la sintesi di un mondo, di una sensualità e di un pensiero assolutamente in linea con lo Jugendstil e che ha lo spesso valore espressivo dei cieli feriti con violenza dal cromatismo livido dei volti stravolti dal gelo del cuore, delle terre tormentate dallo scavare crudele del tratto, dalla corrosione implacabile degli acidi di morsura.
La sua voce ha dato così corpo e colore alle anime del Nord. Un secolo dopo un altro uomo del Nord scriverà: ”Giro negli appartamenti nella penombra, passeggio per le vie silenziose di Uppsala, mi fermo davanti alla Sommarrhuset ad ascoltare l’enorme betulla a due tronchi e abito sempre nel mio sogno: di tanto in tanto faccio una piccola visita alla realtà”.
Quell’uomo si chiamava Ingmar Bergman.
41.954767 12.777958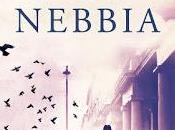



![[Recensione] Inferno Brown](https://m22.paperblog.com/i/289/2893555/recensione-inferno-di-dan-brown-L-tQ138t-175x130.png)
