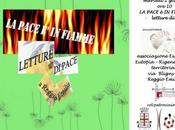Chandra Livia Candiani, La bambina pugile, ovvero, La precisione dell’amore, Einaudi 2014

Una direttiva per cogliere le molteplici direzioni di questo libro, può essere data da un testo della prima sezione, che qui riporto:
Mappa per l’ascolto
Dunque, per ascoltare
avvicina all’orecchio
la conchiglia della mano
che ti trasmetta le linee sonore
del passato, le morbide voci
e quelle ghiacciate,
e la colonna audace del futuro,
fino alla sabbia lenta
del presente, allora prediligi
il silenzio che segue la nota
e la rende sconosciuta
e lesta nello sfuggire
ogni via domestica del senso.
Accosta all’orecchio il vuoto
fecondo della mano,
vuoto con vuoto.
Ripiega i pensieri
fino a riceverle in pieno
petto risonante
le parole in boccio.
Per ascoltare bisogna aver fame
e anche sete,
sete che sia tutt’uno col deserto,
fame che è pezzetto di pane in tasca
e briciole per chiamare i voli,
perchè è in volo che arriva il senso
e non rifacendo il cammino a ritroso,
visto che il sentiero,
anche quando è il medesimo,
non è mai lo stesso
dell’andata.
Dunque, abbraccia le parole
come fanno le rondini col cielo,
tuffandosi, aperte all’infinito,
abisso del senso.
p. 14
Abbraccia le parole, dunque, che vuol dire due cose: liberarle, assolverle. Assolvere noi stessi dal peccato della gola stretta, della bocca nera.
Mappe, dunque, per ricominciare a scrivere e a pregare. Perchè “Non serve schiodare il cielo / a caccia di segreti, / sei tu / che di notte scegli, / non guardi la luce minuscola / ma il buio tutto / che le preme attorno”, p. 19.
Perchè questa apertura pericolosa, questo desiderio di sporcare il vestito buono della poesia, di immergerlo interamente nel fiume dove tutto passa, e prima di passare è trattenuto? Perchè c’è una profonda vocazione naturale nei testi di Livia, la capacità di accogliere la complessità del mondo e di restituirla “alle amiche e agli amici, al mio Maestro che ha 2557 anni, a chi amo, a chi mi ama, ai monaci della foresta, agli indifferenti e agli spaventati dell’amore e dell’amicizia, ai vivi, ai morti, e ai mai nati, ai sopravvissuti, a tutti gli oggetti del lavoro umano, tavoli, sedie e letti, e pane e vino, e orti, e a tutti i cari, furiosi o delicati, animali…”. Parole sagge, e furiose, per mandare a gambe all’aria i pensieri e le poetiche che dividono a pezzi la poesia, la smembrano, come il corpo offeso di Orfeo.
Dunque, siamo in un clima di pieno francescanesimo, o di quella pietas, tout court, che abita le anime più belle della specie, quelle che, per selezione naturale o per volere divino, che è la stessa cosa, dovrebbero rifondare la razza.
E che parola sarebbe, questa di una specie rifondata? Più umile, più compassionevole, più sensibile, più vera? O più debole? Una parola non più interessata a raccontare il dolore di Orfeo, uscito dal grembo e spezzato nella perdita? Sarebbe una parola pacificata, limitata a cantare i fruscii del bosco sacro? No, certo: sarebbe parola che ingrassa parole sommesse, elencate in fondo a un vocabolario in estinzione:
“Parlami con segni con cenni”, p. 80.
“Rispondimi, / rispondimi con l’asino / che cammina quieto / nella vigna…”, p. 82.
“Io vedo il mondo / attraverso la tua trasparenza, / vedo il suo atroce incanto / il suo fingersi ora opaco / ora risvegliato, / vedo il male che ci fa / il leggero del mondo…”, p. 84.
Ecco: sarebbe una poesia con gli occhi spalancati, sofferente per troppa luce e dolore, sensibilissima, capace di cogliere la limitatezza delle parole e quindi tornare al mondo, per fare di poesia un gesto. Poesia come vita, grande bestemmia solo a pronunciarla! – la bellezza della parola corrisponde alla bellezza di un’anima, a tutto il suo dolore ingenuamente mostrato, icona in una piazza di tutti, santificata perchè di tutti -.
Una parola santa, santificata: cosa vuol dire? in questo momento, nei nostri anni, DELIRIO. Delirante io stesso che la pronuncio. E questo perchè identifichiamo la santità con la materia eterea degli angeli, inesistente e inconsistente. Pensiamo agli angeli come a un fuori di noi, pacificato, che non può esistere, che non ci riguarda.
Ma, chi ritorna alla vita, alla durezza della vita, è perchè non ha imparato niente, ha bisogno di immergersi ancora una volta nel grande fiume, di farsi male attraverso la bellezza feroce dello sguardo. Ecco cos’è la santità della parola: soccombere per troppo carico, e splendere.
Non c’è pericolo a dire nuovamente: ancora qui, ancora i fiori, e le cose, e i poveri, e i feroci che sempre ritornano. Ecco allora che, se la parola non ha scampo, bisogna scegliere. Bisogna dire: “Che ne ho fatto di me? / La poesia sanguinaria / dell’infanzia / il puma tatuato nel sangue?”, p. 62.
E la risposta poi viene:
Poi
sono sgusciata fuori
in scorza dura
pelle di mondo,
faccio un silenzio,
addosso al male,
un mantello
d’insolente bellezza
terrestre.
Non posso comandare
questo flusso
è opera grande
di nitida resa
a corrente maestosa,
sono parola alla luce
sono nata.
p. 63
Nel grande mare, dunque, delle sensazioni, della vita, la parola è il filo conduttore dell’esperienza, della sua complessità chiaroscurale di luce e ombra. La parola accoglie tutto, l’immagine del filo d’erba come del più terrificante dei pensieri. Ogni parola per ogni cosa, fino allo spavento dell’innominabile, perchè non conosciamo tutte le parole per tutto nominare.
Ecco le differenze nella poesia: ogni poeta nomina con poche parole, con il poco spazio, il poco tempo che gli è concesso. Scrive per ciò che sente, per ciò che gli suggerisce il suo cuore spaventato, la sua incontrollabile sete di descrivere solo le cose che conosce bene. È dunque necessaria, allora, ogni poesia; fa duramente i compiti guardandosi allo specchio, verificata e giudicata dallo scopo arduo di corrispondere, di essere fedele al suo pensiero e alle sue parole. Sa di dovere indossare esattamente un vestito che non può avere smagliature; per non apparire fragile, ridicola.
Ma questa corrispondenza è l’aspetto della poesia quando non rischia, quando non si fa toccare dall’imprevisto della tempesta, della polvere che si attacca ai vestiti, del pianto, dell’urlo, da ciò che non riconosciamo e non ci appartiene. Quando procede dritta dritta verso il suo unico scopo. Allora non rischia la poesia, è meccanismo che risponde a se stesso, alla sua specchiata perfezione.
Leggiamo questo libro, invece, e vediamo quanto questa poesia rischi: centocinquanta pagine di apertura, di case mostrate, di parole lasciate a maturare sul tavolo come frutta, ortaggi, illuminate dal sole, restituite alla pagina dopo che sono state calpestate dall’esperienza. Non conoscono l’ossatura dell’esoscheletro, sono bambine vestite col vestito della comunione e della cresima, che si pongono davanti al lettore per essere battezzate, e cresimate con gli elementi che ci danno vita, e senso: il sale, l’ olio, l’acqua, il fuoco. E infine la cenere, perchè siano restituite alla polvere una volta che sono state mangiate.
Cosa fa la poesia, se non alimentare, nutrire? Certo, si possono nutrire anche le forze oscure, dare in pasto parole e assolvere così a un compito muto, un oscuro omaggio al Nulla, senza che ce ne venga nulla in cambio. Ma non è questo, forse, esso stesso, il compito dell’abitare un mondo senza risposte? Forse è anche un po’ questo il senso di queste poesie bambine, stupite di ciò che descrivono, senza risposte di fronte allo stupore d’essere, anche in presenza della morte:
Una cinciallegra
ha portato la tua firma
in casa: sai cosa non muore?
L’accenno,
solo unico
l’accenno
d’essere
p. 97
Ed esiste la presenza di una grazia naturale, strangolata dal velo delle apparenze, disegnata col dito sul vetro appannato della macchina e subito cancellata, restituita al suo mondo di nulla.
Esiste la fragilità della grazia, che è la mano del bambino quando vive e, senza risposte, traccia nella polvere una semplice domanda di niente: neanche una parola, ancora, solo un segno di niente. Chi può dire che la grazia esiste se non i poeti? Chi può cogliere i segni di una trasfigurazione del viso, della figura tutta illuminata nella sua interiorità, se non i poeti?
Ora sei trasfigurata
tutta
ora sei mondo
non mi accompagni
cammino in te
mi hai pienamente
abbandonato
riconsegnato all’intero
che sei che siamo
che mi bisbiglia notturni
e disorientando orienta
al senza meta
al silenzio.
Tu l’hai aperto
il sacco opaco il velo
l’hai divelto tu splendi.
Seduta in riva alle lacrime
pesa un quintale
la necessità di grazia.
p. 98
Come posso spiegare il senso di questi versi se non testimoniandoli con la lettura, se non ricopiandoli sul mio quaderno di preghiere, prima per me, solo per me, più che per gli altri?
Perchè non c’è pericolo
nel tuo amore
che ci espone alla nuda
luce,
perchè la conoscenza è radicale vigilia
dell’altro
e chiede: “Dove sei?”
“Dove vivi?”
“Cosa tocchi?”
Perchè ogni opera non è
che gratitudine.
p. 107
Ecco perchè parlavo di santità: perchè queste parole sono in pericolo, sono proclami per il martirio, troppo “violente” per essere accolte dai cultori delle parole alchemiche, quelle che possono esistere solo nelle boccette dei laboratori, pronunciabili sdegnosamente, o con la massima ignoranza, solo da chi le ha create.
Qui si dice :
Le parole seminano
scavano nel cielo:
non vivono le cose
solo dentro di noi,
devono
venire al mondo,
riflesse
pronunciate.
p. 114
Ecco, quando dicevo che intendo sempre di più una recensione come un gesto di testimonianza, di presenza, intendevo appunto dire che la poesia, quando essa stessa è un atto di testimonianza, una presenza, non può che cambiare le nostre stesse parole. In fondo non dobbiamo nulla alla poesia, all’arte, nè essa deve qualcosa a noi. Ci incontriamo quando ci siamo riconosciuti, e allora le domande sono rivolte a noi stessi, perchè nello specchio del Narciso mondo noi non vediamo solo noi stessi, ma noi nel mondo, altrimenti, se non ci vediamo, passiamo oltre, solitari e muti, oppure dolorosi e febbricitanti in una ricerca incessante.
La poesia di questo libro della maturità, è un gesto d’amore, l’amore cavilloso, non generico, attento alle minime vibrazioni dell’altro: la precisione dell’amore. Qui altro è il mondo, riflesso nello specchio del nostro desiderio di riconoscerci, di non sentirci soli, di offrire il pane della nostra parola, perfino del nostro volto mascherato, dei nostri sensi ridotti, in sordina. Siamo condannati ad offrire persino il nostro desiderio di non offrire perchè a qualcuno lo dobbiamo dire, a qualcuno, o a qualcosa, dobbiamo buttare in faccia il nostro diniego. E dall’altra parte, anche se non lo desideriamo, anche se lo detestiamo, ci sarà sempre qualcuno che dovrà dare parole al nostro ostinato silenzio.
Io è tanti
e c’è chi crolla
e chi veglia
chi innaffia i fiori
e chi beve troppo
chi dà sepoltura
e chi ruggisce.
p. 143
Sebastiano Aglieco