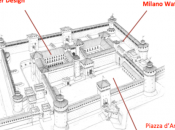In Francia l’Internet Provider Free rimprovera al sito di video di YouTube, di proprietà di Google, di consumare troppa banda larga. Il suo blocco per rappresaglia delle pubblicità di Google ha fato scalpore. Free ha cosi messo a rischio la “neutralità di internet”, uno degli argomenti discussi in dicembre alla conferenza di Dubai. Tuttavia, la grande questione di questo incontro è stata la tutela degli Stati uniti sulla rete mondiale.
In Francia l’Internet Provider Free rimprovera al sito di video di YouTube, di proprietà di Google, di consumare troppa banda larga. Il suo blocco per rappresaglia delle pubblicità di Google ha fato scalpore. Free ha cosi messo a rischio la “neutralità di internet”, uno degli argomenti discussi in dicembre alla conferenza di Dubai. Tuttavia, la grande questione di questo incontro è stata la tutela degli Stati uniti sulla rete mondiale.
Abitualmente circoscritta ai contratti commerciali fra operatori, la geopolitica di Internet si è mostrata recentemente alla luce del sole. Dal 3 al 14 dicembre 2012, i 193 Stati membri dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (Itu, un’agenzia affiliata all’Organizzazione delle Nazioni Unite) si erano dati appuntamento a Dubai, negli Emirati arabi uniti, per la dodicesima conferenza mondiale sulle telecomunicazioni internazionali. Un incontro nel quale i diplomatici, sommersi di consigli da parte degli industriali del settore, stabiliscono accordi che dovrebbero facilitare le comunicazioni via cavo e via satellite. Lunghe e noiose, queste riunioni sono tuttavia cruciali a causa del ruolo determinante delle reti nel funzionamento quotidiano dell’economia mondiale.
La controversia principale durante questo vertice riguardava internet: l’Itu doveva arrogarsi delle responsabilità nella supervisione delle rete informatica mondiale, sul modello del potere che essa esercita da decenni sulle altre forme di comunicazione internazionale?
Gli Stati Uniti hanno risposto con un “no” fermo e compatto, in virtù del quale il nuovo trattato ha rinunciato a rinunciato a conferire il minino ruolo all’Itu in quella che viene definita la “governance mondiale di internet”. Tuttavia una maggioranza di Paesi ha approvato una risoluzione allegata che invita gli Stati membri “a esporre nei dettagli le loro rispettive posizioni sulle questioni internazionali tecniche, di sviluppo, e di politiche pubbliche relative a Internet”. Benché “simbolico” come dice il New York Times (1), questo accenno di sorveglianza globale si è scontrato con la posizione inflessibile della delegazione americana, che ha rifiutato di firmare il trattato e ha sbattuto la porta della conferenza, seguita fra gli altri dalla Francia,dalla Germania, dal Giappone, dall’India, dal Kenya, dalla Colombia, dal Canada, e dal Regno Unito. Ma ottantanove dei centocinquantuno partecipanti hanno deciso di approvare il documento. Altri potrebbero firmarlo in seguito.
In che cosa queste peripezie apparentemente oscure rivestono un’importanza considerevole? Per chiarirne la posta in gioco, bisogna prima di tutto dissipare la spessa coltre di nebbia retorica che circonda questa vicenda. Da parecchi mesi, i media occidentali presentavano la conferenza di Dubai come il luogo di uno scontro storico fra i sostenitori di un Internet aperto, rispettoso delle libertà, e gli adepti della censura, incarnati da stati autoritari come la Russia, l’Iran, o la Cina. La cornice del dibattito veniva posta in termini così manichei che Franco Bernabè, direttore di Telecom Italia e presidente dell’associazione degli operatori di telefonia mobile Gsma, ha denunciato una “propaganda di guerra”, alla quale imputato il fallimento de trattato (2).
Le macchine di sorveglianza americane
Ovunque si viva, la libertà di espressione non è una questione secondaria. Ovunque si viva, non mancano le ragioni di temere che l’apertura relativa di internet venga corrotta, manipolata, o non subisca interferenze. Ma la minaccia non viene solo dagli eserciti di censori o dalla “grande muraglia elettronica” eretta in Iran o in Cina. Negli Stati uniti, ad esempio, i centri d’ascolto dell’Agenzia di sicurezza nazionale (National Security Agency, Nsa) sorvegliano l’insieme delle comunicazioni elettroniche che transitano attraverso i caci e i satelliti americani. Il più grande centro di cyber sorveglianza al mondo è attualmente in costruzione a Bluffdale, del deserto dello Utah (3). Washington dà la caccia a WikiLeaks con accanita determinazione. Sono peraltro società americane, come Facebook e Google, ad avere trasformato il web in una “macchina di sorveglianza” che assorbe tutti i dati commercialmente sfruttabili sul comportamento degli internauti.
Dagli anni ’70, la libera circolazione dell’informazione (free flow of information) costituisce uno dei fondamenti ufficiali della politica estera degli Stati Uniti (4), presentata, in un contesto di guerra e di fine della decolonizzazione, come un faro che illumina la via dell’emancipazione democratica. Essa permette oggi di riformulare interessi strategici ed economici pressanti nel linguaggio seducente dei diritti umani universali.
“Libertà di interne”, “libertà di connettersi”: queste espressioni, ripetute con insistenza dal Segretario Hillary Clinton e dai dirigenti di Google alla vigilia dei negoziati, costituiscono la versione modernizzata dell’ode alla “libera circolazione”.
A Dubai, i dibattiti coprivano una miriade di ambiti trasversali. All’ordine del giorno, in particolare, la questione dei rapporti commerciali tra i diversi servizi Internet, come Google e le grandi reti di telecomunicazioni, quali Verizon, Deutsche Telekom, o Orange, che trasportano questo flusso voluminoso di dati. L’argomento, cruciale per le sue poste in gioco commerciali, lo è anche per le minacce che fa pesare sulla neutralità della Rete, vale a dire sul principio di uguaglianza di trattamento di tutti gli scambi sul Web, indipendentemente dalle fonti, dai destinatari, e dai contenuti. Il gesto di Xavier Niel, il titolare di Free, che ha deciso agli inizi di gennaio 2013 di dichiarare guerra alle entrate pubblicitarie di Google bloccandone la pubblicità, illustra queste poste in gioco. Una dichiarazione generale che imporrebbe ai fornitori di contenuti di pagare gli operatori delle reti avrebbe gravi conseguenze sulla neutralità di internet, che è una garanzia, vitale per la libertà dell’internauta.
Ma lo scontro che ha segnato la conferenza riguardava una questione totalmente diversa: a chi spetta il potere di controllare l’integrazione continua di Internet nell’economia capitalista transnazionale? (5)
Fino ad oggi questo potere spetta essenzialmente a Washington. Dagli anni ’90, l’epoca dell’esplosione su scala planetaria della Rete, gli Stati Uniti hanno impiegato sforzi intensi per istituzionalizzare la loro posizione dominante. E’ necessario infatti che i nomi di dominio (del tipo “.com”), gli indirizzi numerici, e gli identificativi di rete vengano attribuiti in modo distintivo e coerente –il che permette l’esistenza di un potere istituzionale in grado di assicurare queste attribuzioni, e le cui prerogative di conseguenza si stendono all’insieme di un sistema tuttavia per sua natura extraterritoriale.
Approfittando di questa ambiguità originaria, gli Stati uniti hanno affidato la gestione dei domini a un’agenzia da essi creata, l’Internet assigned numbers authority (Iana). Legata per contratto al Ministero del commercio, l’Iana opera in qualità di membro di un’associazione californiana di diritto privato, l’Internet corporation for assigned names ad numebers (Icann), la cui missione consiste nel <<preservare la stabilità operativa di Internet>>. Quanto agli standard tecnici, essi vengono stabiliti, da altre due agenzie americane, l’Internet engeenering task force (Ietf) e l’Internet architecture board (Iab), integrate a loro volta in un’altra associazione senza fini di lucro, l’Internet society. Data la loro composizione e il loro finanziamento, non ci si meraviglierà del fatto che queste organizzazioni siano più attente gli interessi degli Stati uniti che alle richieste degli utilizzatori (6).
I siti commerciali più prosperi del pianeta non appartengono a capitali kenioti o messicani, e neppure russi o cinesi. L’attuale transizione verso l’<<informatica della nuvola>> (cloud computing), i cui principali attori sono americani, dovrebbe accrescere ancora la dipendenza della rete ne confronti degli Stati Uniti. Il disequilibrio strutturale del controllo di internet garantisce la supremazia americana del cyberspazio, contemporaneamente sul piano commerciale e militare, lasciando poco margine agli altri paesi per regolare, bloccare o rendere più flessibile il sistema in funzione dei propri interessi. Mediante diverse misure tecniche e legislative, ogni Stato è certo in grado di esercitare un parte di sovranità sul ramo “nazionale” della rete, ma sotto la sorveglianza ravvicinata del gendarme planetario. Da questo punto di vista, come fa notare il docente universitario Milton Mueller, Internet è uno strumento al servizio della “politica americana di globalismo unilaterale (7)”.
La loro funzione di gestori ha permesso agli Stati uniti di programmare il dogma della proprietà privata proprio nel cuore dello sviluppo di internet. Anche se dotata, teoricamente, di autonomia relativa, l’Icann si è distinta per i favori extraterritoriali accordati ai detentori di marchi commerciali depositati. Nonostante le loro proteste, diverse organizzazioni non commerciali, benché rappresentate all’interno dell’istituzione, non sono state all’altezza di fronte a società come Coca-Cola o Procter&Gamble. L’Icann invoca il Diritto degli affari per imporre le sue regole agli organismi che amministrano i domini di primo livello (come “.org”, “.info”). Se dei fornitori nazionali di applicazioni controllano il mercato interno in diversi Paesi, in particolare in Russia, in Cina, o in Corea del sud, i servizi transazionali – al tempo stesso i più proficui e i più strategici in questo sistema extraterritoriale – restano, da Amazona PayPal passando per Apple, cittadelle americane, costruite su capitale americano e appoggiate dall’Amministrazione americana.
Dagli esordi di internet, diversi paesi, si sono rivoltati contro il proprio status di subordinati. La moltiplicazione degli indici che segnalavano che gli Stati uniti non avevano alcuna intenzione di allentare la loro stretta ha allargato progressivamente il fronte del malcontento. Queste questioni hanno finito per provocare una serie di incontri al più altro livello, in particolare nel quadro del Vertice mondiale sulla società dell’informazione (Wsis), organizzato dall’Itu a Ginevra e a Tunisi fra il 2003 e il 2005.
Offrendo una tribuna agli stati frustrati di non poter dire la loro, queste riunioni prefiguravano lo scontro di Dubai. Riuniti in un comitato consultivo (Governmental advisory aomitee, Gac), una trentina di paesi speravano di convincere l’Icann a condividere una parte delle sue prerogative. Una speranza rapidamente delusa, dato che il loro status all’interno del Gac li metteva allo stesso livello delle società commerciali e delle organizzazioni della società civile. Alcuni stati avrebbero potuto adattarsi a questa bizzarria se, malgrado i bei discorsi sulla diversità e il pluralismo, l’evidenza non si fosse importa a tutti: la governance mondiale di internet è tutto salvo che egualitaria e pluralista, e il potere esecutivo americano non intende cedere nulla del suo monopolio.
Voltafaccia dell’India e del Kenya
La fine dell’era unipolare e la crisi finanziaria hanno nuovamente attizzato il conflitto fra stati riguardo all’economia politica del cyberspazio. I governi cercano ancora dei punti su cui far leva per introdurre un inizio di coordinamento nella gestione della rete. Nel 2010 e nel 2011, in occasione del rinnovo del passato contratto con fra l’Iana e il ministero del Commercio americano, diversi stati si sono rivolti direttamente a Washington. Il governo del Kenya ha argomentato a favore di una “transizione” della tutela americana verso un regime di cooperazione multilaterale, mediante una “globalizzazione” dei contratti che regolano la sovrastruttura istituzionale che ha al suo interno i nomi di dominio e gli indirizzi IP (Internet Protocol). L’India, il Messico, l’Egitto, e la Cina hanno fatto proposte nello stesso senso.
Gli Stati uniti hanno reagito a questa fronda rilanciando nella retorica della “libertà di Internet”. Non ci sono dubbi che abbiano anche intensificato la loro lobbying bilaterale per ricondurre all’ovile alcuni paesi che non si erano allineati. A riprova, il colpo di scena della conferenza di Dubai: l’India e il Kenya hanno prudentemente aderito al colpo di mano di Washington.
Quale sarà la prossima tappa? Le agenzie governative americane e i grossi sponsor del cyber capitalismo come Google continueranno verosimilmente a usare tutto il loro potere per rafforzare la posizione centrale degli Stati uniti e screditare i loro detrattori. Ma l’opposizione politica al “globalismo unilaterale” degli Stati Uniti è e resterà aperta. Al punto che un editorialista del Wall Street Journal non ha esitato, dopo Dubai, a evocare la prima “la prima grande disfatta digitale dell’America (8)”.
(1)Eric Pfanner, “Message, if murky, from US to the world”, The New York Times, 15 dicembre 2012
(2) Rachel Sanderson e Daniel Thomas, “US under fire after telecoms treaty talks fail”, Financial Times, Londra, 17 dicembre 2012
(3)James Bamford, “The NSA is building the country’s biggest spy center”, Wired, San Francisco, aprile 2012
(4) Herbert I. Schiller, “Libre circulation de l’informationet domination mondiale”, Le Monde Diplomatique, settembre 1975
(5) Dwayne Winseck, “Big new global threat to the Internet or paper tiger: The ITU and global Internet regulation”, 10 giugno 2012, http://dwmw.wordpress.com
(6) Harold Kwalwasser, “Internet governance”, in Franklin D. Kramer, Stuart H. Starr e Larry Wentz (a cura di), Cyberpower and National Security; National Defense University Press – Potomac Press, Washington-Dulles (Virginia), 2009
(7) Milton L. Mueller, Networks and States: The Global Politics of Internet Governance, The MIT Press, Cambridge (Massachussets), 2010
(8) L. Gordon Crovitz, “America’s first big digital defeat”, The Wall Street Journal, New York, 17 dicembre 2012
di Dan Schiller*
* Professore di Scienze dell’Informazione e delle biblioteche dell’Università dell’Illinois a Urbana-Champaign
Da Le Monde Diplomatique
febbraio 2013