
Jean-Paul Sartre
Di FABIO CIRIACHI
Sarà vero che scrivendo giriamo e rigiriamo sempre attorno allo stesso tema, sorta di idea fissa, di chiodo a cui siamo rimasti impigliati, di porta chiusa davanti alla quale tentare inesauste varianti di un qualche “apriti sesamo”? E sarà vero che nel nostro passato di scrittori esiste un libro letto che, per ragioni imperscrutabili, è arrivato a diventare il solo modello alla cui implicita imitazione lavoriamo di continuo, senza soste, senza sentire la fatica, senza fermarci davanti agli insuccessi? E quale ne sarebbe la causa? È possibile supporre che attraverso quella lettura ci sia accaduto qualcosa di fondamentale? Che magari quelle pagine ci abbiano messo in contatto con una misura aurea, una formula magica, un mantra, sì, un mantra il cui ascolto, o la cui dizione interiore, abbia coinciso con qualche segreto salvifico? O meglio, che sia (stato) esso stesso l’esercizio di quel segreto?
Le risposte affermative sono così scontate da rendere retoriche le domande. Una condizione del genere, però, somiglia molto a una condanna per quanto è consistente il rischio che l’incontro possa essere avvenuto con un’opera mediocre (gli entusiasmi giovanili, si sa) che ora non ci farebbe alcun effetto, o peggio, troveremmo irrilevante (aggettivo vagamente sartriano), tanto che ci piacerebbe decidere adesso, in piena consapevolezza, da cosa farci bruciare sulla via di Damasco.
E invece no, in certi campi non c’è libero arbitrio. Abbiamo tutti avuto il nostro libro e ce lo teniamo. Al massimo, dopo, leggeremo e leggeremo per seppellire con altre parole quelle che, imperiose, costringono a uno stato di così spudorata dipendenza. Anche se non c’è verso di metterle a tacere, quelle parole che ci hanno infisso al chiodo, le amiamo ancora, non sappiamo perché ma le amiamo, e sono quelle e solo quelle che, scrivendo, cerchiamo in tutti i modi di imitare; senza darlo a vedere, senza ammetterlo neanche a noi stessi. E continueremo a insistere, è certo, finché la vera opera, ovvero la perfetta imitazione (su chissà quale arcana scala) del nostro incomparabile modello non sarà compiuta, e solo allora potremo uscire dalla soggezione e magari dedicarci al riposo, a scrivere lettere, a non far niente.
Riflettevo su questo ieri mattina quando, con una nostalgia inattesa ho ripensato a mio padre, Antoine Roquentin. Ma tuo padre, obietterebbe chi mi conosce bene, non si chiamava Fernando? Non c’era forse il suo nome su quei certificati di un tempo quando era d’obbligo scrivere le generalità e ci si rallegrava per la fortuna di non dover riempire con n.n. lo spazio riservato al nome del padre?
Certo, risponderei all’obiezione, il mio padre anagrafico, quello di carne e sangue, e di buone, fin troppo buone maniere, si chiamava Fernando, come no, ma quello a cui ho ripensato con nostalgia, ieri, è il protagonista (vero e proprio padre letterario) del libro alla cui lezione guardo, anche quando non mi rendo conto di farlo, durante le ore e ore che dedico alla scrittura. Mi verrebbe da dire che è il padre scelto se non fossi più che consapevole di quanto, in realtà, mi sia piuttosto toccato in sorte.
Ho letto La nausea, di Jean Paul Sartre, a diciotto anni, e da allora, che lo riconosca o no, vado cercando l’equivalente della scura provincia francese nella cui biblioteca compiere le mie ricerche, il ritrovo dei ferrovieri in cui fermarmi a bere, il diario dove registrare con fredda remissività la perdita di senso delle cose, o delle parole che le qualificano; da allora cerco l’equivalente di una donna che potrei anche amare se non fossi sposato con le mie inquietudini, e poi cerco una voce nera e dolente, una voce d’oltreoceano che emerga dai fruscii di un vecchio 78 giri e aggiunga un vero motivo musicale alla dolce arrendevolezza di parole senza note: “Some of these days you’ll miss me, honey” (nella mia mente ho sempre pronunciato questo inglese con la stessa strascicata cadenza con cui lo pronuncerebbe un francese).
Probabilmente essere nati nel ’44, e non avere avuto la famiglia come stella polare per orientarsi nella cultura espone, nei primi anni Sessanta, ai rischi del folklore esistenzialista. Ci sono i maglioni neri e le caves fumose, c’è una decisa rottura con le insopportabili tinte tenui del posto fisso e delle brave ragazze, del provincialismo povero ma bello e delle storie edificanti ambientate magari all’oratorio tra preti solerti e amiconi che, gratta gratta, però, stanno agli antipodi della scuola di Barbiana.
Vuoi mettere il pessimismo virtuoso di quei solitari che misurano, senza piagnistei, i gradi di invivibilità di tutto quanto li circonda? Vuoi mettere un Meursault che – invece di raccontare, all’inizio del primo di molti volumi, come sovente si coricasse presto la sera, e del profumo di sua madre durante il bacio della buonanotte – ti dice subito “Oggi la mamma è morta” e poi, a coronamento di un incipit geniale aggiunge: “O forse ieri, non so”. O vuoi mettere un Antoine Roquentin che dopo aver deciso di: “Tenere un diario per vederci chiaro” a un certo punto è costretto a scrivere: “La parola Assurdità nasce ora sotto la mia penna”.
Il fatto è che se ti sei appena diplomato ragioniere, nel ’62, vuol dire che a scuola ti hanno insegnato a odiare Manzoni e a dormire sulle Ultime lettere di Jacopo Ortis, e quanto alla letteratura francese (che non hai studiato perché stavi nella sezione di inglese e tedesco), ne sai ancora meno dell’autodidatta che Antoine Roquentin incontra in biblioteca, e di certo ti sfuggono, semmai ti sei posto il problema, le cause della rottura tra Sartre e Camus e…
Ma tutto questo conta poco di fronte all’evidenza che ho letto La nausea proprio allora e adesso, dopo più di mezzo secolo, con Sartre completamente rimosso dalla scena filosofica, letteraria e teatrale, approfitto di uno stimolo esterno e provo a interrogarmi senza remore sul legame con quel suo primo romanzo. L’età rende inclini al vero; eliminato molto superfluo e consolidati gli equilibri interni, coperture prima necessarie ora non servono più, e non è detto che in questo clima da nuovo corso, alleggerita la zavorra, non riesca a buttare un occhio in archivi di solito abbastanza secretati. Intanto lo so, a qualunque risposta io possa pervenire, anche alla più dirompente, non una sola fibra di quell’antico legame rischierà di essere scalzata. Verificata l’indistruttibilità del giocattolo, provo a smontarlo, e non è detto che ci riesca.
Dal ’62, data dell’incontro con Antoine Roquentin, mi sposto per un attimo all’autunno del ’65 quando frequento, senza alcun entusiasmo e in uno stato di rancorosa resistenza passiva, la facoltà di Economia e Commercio che a Roma, allora, annovera, fra l’altro, l’alterigia professorale di un Amintore Fanfani. Sul finire di quell’anno – ottenuta la riforma dal servizio militare e, di conseguenza, il rilascio del passaporto – decido di andare a vivere a Parigi per ragioni che oggi definirei, in senso lato, artistiche. Non parto solo; con me, la compagna che nel ‘70 sarà la madre di mia figlia (che a distanza di qualche anno diventeremo genitori nessuno dei due può immaginarlo, ma nel condividere così d’impulso una scelta tanto radicale – io, in fondo, lascio Roma “per sempre” e noi non ci si conosce da molto – sono leggibili i prodromi di certe future avventatezze).
Benché non conosca una parola di francese (non ne faccio un problema, sono sicuro di sbrogliarmela in una lingua che reputo così simile alla mia), infine, nella Cinquecento grigio topo acquistata coi proventi di una munifica borsa di studio (erano anni semplici, allora, la Cinquecento costava cinquecentomila lire, la Seicento, seicentomila, la Millecento un milione e centomila e così via al ritmo di mille lire a centimetro cubo), io alla guida e la mia compagna a fare da navigatore, una fredda mattina di gennaio del ’66, dopo due giorni di viaggio, nebbie e ghiacci, entriamo a Parigi in piena ora di punta, e seguendo una specie di orientamento elettivo, parcheggiamo davanti a un alberghetto abbordabile della rue Saint Jacques, in pieno Quartiere Latino, con la netta sensazione di essere arrivati.
Durante i sei mesi di quella “netta sensazione”, soprattutto all’inizio, per imparare una lingua meno scontata di quanto non pensassi alla partenza, decido di leggere libri in francese (petit Larousse a portata di mano) e naturalmente, da “nauseato”, la mia scelta cade sulla trilogia Les chemins de la liberté, divorata forse non nell’ordine di uscita, e in parte ancora presente nella mia libreria sotto forma di uno spiegazzato e voluminoso livre de poche, La mort dans l’âme, essendosi L’âge de raison e Le sursis persi chissà dove.
Vuoi per la difficoltà di penetrare testi in edizione originale, vuoi per la minore dose di “filosofia della crisi” presente in quelle macchinose pagine, la fascinazione, stavolta, è pressoché impercettibile, e comunque lontana dal potere insinuante de La nausea. Per trovare qualcosa che vi si avvicini devo aspettare il ’67 quando leggo, tradotto, Le parole, un invito in casa Sartre, o meglio, nel poco, ma di notevole eloquenza, che un autore solitamente schivo riguardo al personale, come lui, arriva a confessare di sé, e che si chiude in quel modo fulminante e indimenticabile che merita citare per intero: “Ciò che mi piace nella mia follia è che essa mi ha protetto, fin dal primo giorno, contro le seduzioni dell’«élite»: mai mi sono creduto il felice proprietario di un «talento»: il mio unico problema era di salvarmi – a mani vuote e a tasche vuote – per mezzo del lavoro e della fede. Di colpo, la mia pura opzione non mi sollevava sopra a nessuno: senza equipaggiamento, senza attrezzatura, mi sono messo tutto per intero all’opera per salvarmi tutto per intero. Se ripongo l’impossibile Salvezza nel ripostiglio degli attrezzi, cosa resta? Tutto un uomo, fatto di tutti gli uomini: li vale tutti, chiunque lo vale”.
Di Salvezza si tratta, dunque, con tanto di S maiuscola, e se consideriamo sotto quale “nero” influsso s’era affacciata La nausea in ambito editoriale (il titolo con cui il manoscritto arriva da Gallimard è Melancholia), capiamo meglio quanta ragione avesse, Sartre, a concludere Le parole, trent’anni dopo, con quel deciso tono in levare che sfiora, senza darlo troppo a vedere, qualcosa che attiene abbastanza da vicino al senso di trionfo.
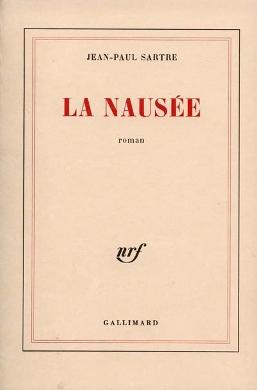
Jean-Paul Sartre, La nausée
A ripercorrere brevemente la genesi de La nausea – soprattutto per quanto riguarda la scelta di un titolo che a posteriori pare indiscutibile e predestinato, per quanto sembra l’intima proiezione del cuore stesso dell’opera – e considerando che Sartre, in effetti, aveva battezzato Melancholia il manoscritto dato a Gallimard, si osserva come – nei sei mesi di revisioni apportate al testo, non senza resistenze da parte dell’autore – non si faccia parola del titolo, e solo quando sono risolti tutti gli altri problemi emergono le perplessità dell’editore circa la sua totale mancanza di attrattiva. Il rimedio proposto da Sartre pare peggiore del male: Le avventure straordinarie di Antoine Roquentin (vengono i brividi a pensare La nausea in veste di “avventure straordinarie”). Ci pensa infine Gallimard in persona a rompere l’indugio e a proporre quello che poi sarà il titolo definitivo.
Dietro quel Melancholia, però, traspare l’intenzione di Sartre di fare i conti con una condizione dell’essere (oggi collocata in ambito depressivo) che nella prima metà del secolo scorso, invece – in piena diffusione della psicanalisi, e in un clima di crescente fiducia nelle “storie che curano” – tendeva a trovare conforto, rifugio, quasi giustificazione, più in ambito iconografico (vedi, fra le autorevoli allegorie del passato, la figura alata di Dürer) che non in eroiche assunzioni di responsabilità personale.
Antoine Roquentin, invece, in controtendenza con l’aria del tempo, batte proprio questa strada, tanto da riuscire a guardare con l’occhio lucido dei non illusi (che è diverso da delusi) lo stato delle cose, e a immaginare, infine, di superarle per consapevolezza attraverso la scrittura di un libro che getti luce sul suo passato: “Un’altra specie di libro. Non so bene quale – ma bisognerebbe che s’immaginasse, dietro le parole stampate, dietro le pagine, qualche cosa che non esistesse, che fosse al di sopra dell’esistenza. Una storia, per esempio, come non possono capitarne, un’avventura. Dovrebbe essere bella e dura come l’acciaio, e che facesse vergognare le persone della loro esistenza. Me ne vado, mi sento incerto. Non oso prendere una decisione. Se fossi sicuro d’aver talento… Ma mai – mai ho scritto niente di questo genere; articoli storici, sì – e ancora. Un libro. Un romanzo […] Ma verrebbe pure un momento in cui il libro sarebbe scritto, sarebbe dietro di me e credo che un po’ della sua luce cadrebbe sul mio passato […] E arriverei – al passato, soltanto al passato – ad accettare me stesso”.
Ecco, questa possibilità che la pagina finale de La nausea suggerisce – ovvero di poter superare l’ostacolo apparentemente insuperabile dell’Assurdo attraverso il rito salvifico di uno scritto che si fa libro e parla anche agli altri – a me che da tanto cerco di darmi quotidiani motivi per considerarmi scrittore sembra una prima buona spiegazione dell’attrattiva esercitata nei miei confronti. È chiaro che la formula con cui si chiude il libro non ha valore in sé (sarebbe bastata da sola, altrimenti) ma come momento conclusivo di un percorso per gradi che poi coincide con la geografia interiore dell’opera, ovvero con il susseguirsi, per più di duecento pagine, di certe parole particolari (e solo di quelle) messe pazientemente in fila l’una dietro l’altra fino a formare quel discorso concluso che ha nome La nausea.
Per attivare altre spie che mi aiutino a capire il funzionamento unico di questo giocattolo – che da più di mezzo secolo ha assunto il ruolo di sole interiore attorno a cui spendo la più parte delle mie gravitazioni – tento la strada delle sottolineature, anche se va detto che la copia de La nausea da cui le ricavo non è quella della prima lettura (persa in uno dei tanti traslochi dove ho la sensazione di aver smarrito anche altro), ma quella della seconda; databile all’incirca verso il 1992 e decisa, forse, più per sfidare la consistenza del mio tempo storico (provando a demolirne i capisaldi), che non per aggiustare la misura critica nei confronti di un’opera che continuavo a ritenere basilare.
A pagina 11 (l’edizione è l’Einaudi Tascabili del ’90) sottolineo: “Credo sia questo il pericolo, quando si tiene un diario: si esagera tutto, si sta in agguato, si forza continuamente la verità”. A pagina 60: “Avrei voluto che i momenti della mia vita si susseguissero e s’ordinassero come quelli di una vita che si rievoca. Sarebbe come tentare d’acchiappare il tempo per la coda”. A pagina 107: “Immagino sia per pigrizia che il mondo si rassomiglia tutti i giorni. Oggi aveva l’aria di voler cambiare. E allora tutto, tutto poteva succedere”. A pagina 171: “La Nausea non mi ha lasciato e non credo che mi lascerà tanto presto; ma non la subisco più, non è più una malattia né un accesso passeggero: sono io stesso”. E da ultimo la pagina finale, già citata.
Queste spie, a ben vedere, forse non dicono nulla. O quanto meno tacciono in forma così discreta da sottrarre il loro eventuale significato a una percezione immediata. Ma anche quando ho conosciuto Sartre ho avuto, nei suoi confronti, la stessa sensazione di essere alle prese, oltre che con la persona e con il pensiero, anche con un sottodiscorso invisibile che, pur sfuggendomi, nondimeno mi consentiva di avvertirne presenza e importanza.
Nel 1971 (è allora che lo conosco) lavoro come fotografo; è un’attività militante, la mia, vivo con le Nikon a tracolla giacché m’interessa, per lo più, il tanto invisibile che brulica per le strade di Roma (oggi quell’invisibile non c’è più, e non perché io sono invecchiato e non lo vedo, ma perché l’invasione continua e crescente di immagini mediatiche ha bruciato la sua delicata pelle e reso incapaci di visione nitida anche gli sguardi che potrebbero ancora registrarlo). Mi telefona un amico, un pittore che fa il barman da Di Marzio, a Santa Maria in Trastevere, e mi dice: “Se t’interessa, seduti ai tavoli fuori, ci sono Sartre e la de Beauvoir”. Mi precipito. La primavera rende soltanto piacevole il sole che scalda la piazza. La luce è di quelle che fanno pentire di aver detestato Roma (considerazione senza dubbio postuma, perché allora questo sentimento nei confronti della mia città mi era del tutto sconosciuto, anche se forse già presentivo che, di lì a poco, l’avrei lasciata; mai immaginando, comunque, che il distacco sarebbe durato ben quindici anni, né che ne avrei detestato, di tanto in tanto, la memoria).
Capelli lunghi fin sotto le scapole, camicione bianco indiano, Nikon a tracolla, dopo aver salutato la de Beauvoir mi presento a Sartre e gli dico che mi piacerebbe intervistarlo. Ci pensa un po’, risponde che domani, nel primo pomeriggio, dovrebbe essere libero, e se lo chiamo in albergo (di cui mi dà il numero) fissiamo un appuntamento. Il giorno dopo, davanti a due birre ai tavoli esterni di un bar dietro piazza Capranica, parliamo per un paio d’ore. Dal ’68 in poi le sue scelte politiche si sono fatte militanti, quindi tocchiamo soprattutto i temi del rapporto fra letteratura e politica. La sua disponibilità è lusinghiera. Avendolo amato in maniera determinante, non ho soggezione alcuna a intrattenermi con lui ma non posso non considerare, al commiato, la gentilezza d’animo con cui si è concesso per oltre due ore a un estraneo senz’altro accredito che se stesso e le sue buone maniere (o, per dirla con le parole che Camus affida al Jean-Baptiste Clamence de La caduta, sulla “sola fede della sua faccia”). Infine mi chiede di leggere l’intervista dopo che l’avrò trascritta; poi acconsente, con una pazienza che ancora mi tocca, a lasciarsi fotografare. So della sua idiosincrasia in proposito, così mi limito a cinque o sei scatti molto veloci e lo ringrazio. Dopo qualche giorno legge l’intervista, che approva, e infine, testo e foto, escono in una delle tante riviste che nascono e muoiono di continuo durante quel periodo ricco di fermenti.
Sartre, allora, ha sessantasei anni, e ricordo che mentre lo ascolto prendendo appunti, ogni tanto provo a dirmi “è lui che da giovane ha scritto La nausea, ti rendi conto, sei davanti alla persona che ha scritto La nausea” ma è come se la sua aura di scrittore più che amato in gioventù soggiacesse di fronte al lui di quel momento. La sua storia – di filosofo, narratore, autore teatrale, militante culturale e politico – sta tutta lì, assieme a lui, è lui. Nella gentilezza con cui mi parla (di sicuro, a quel dialogo, benché estemporaneo, si concede con vero interesse) ci sono i suoi trascorsi di orfano che ritrova un padre nella biblioteca del nonno materno e le sue difficoltà a lasciare la protezione familiare per misurarsi col mondo, ci sono le sue amicizie con Aron e Nizan e la sua polemica con Camus interrotta dalla morte prematura di quello che è stato il suo più impegnativo e rimpianto interlocutore (“…uno di quei rari uomini, di fronte ai quali si può tranquillamente attendere, perché scelgono lentamente e rimangono fedeli alla loro scelta” scrive di lui, nel discorso commemorativo apparso in “France-Observateur il 7 gennaio del ’60), c’era l’assegnazione del Nobel per la letteratura, nel ’64, e il suo motivato rifiuto a riceverlo, c’era il lungo sodalizio amoroso con la de Beauvoir (annota Manuel Cruz in L’amore filosofo: “Coppia su cui si è scritto a lungo, mitizzando la relazione come paradigma di libertà e modello di rottura rispetto alla vita borghese tradizionale (i due si sono dati del lei per più di cinquant’anni, non hanno mai vissuto insieme – pur stando vicini –, hanno scelto di non sposarsi e di non avere figli, ed è ben nota la liberalità con cui entrambi accettavano che l’altro avesse relazioni con terze persone) per essere poi messa in discussione anch’essa”.), e tanto, tanto altro ancora, tutto capace di amalgamarsi, in lui, sotto forma di un’apertura al mondo ovviamente limitata, sì, ma capace di porre quel limite a una grande profondità, e permeata inoltre di una leggerezza che sarei tentato di definire “esistenziale”, quanto meno nell’accezione che può risultare da quanto di meglio è contenuto nel suo L’esistenzialismo è un umanismo.
Certo oggi, a più di mezzo secolo di distanza da quel 1962, mi accorgo che non so evocare la figura di Sartre senza fare altrettanto con quella di Camus. Anche ora ho voglia di metterli in contatto (del resto, dentro di me, lo sono sempre stati), di assegnare loro parti che nella commedia della realtà sarebbe stato impossibile anche solo immaginare, di farli dialogare in forme inedite; non certo nella direzione delle polemiche a causa delle quali, negli anni Cinquanta, sono pervenuti a una rottura che poi non ha fatto in tempo a ricomporsi. Nella sua “Risposta a Camus” contenuta in Che cos’è la letteratura?, Sartre affida la sua lunga e molto argomentata obiezione a un incipit più che esplicito: “Mio caro Camus, la nostra era un’amicizia difficile, ma io ne sentirò la mancanza. Visto che lei oggi la rompe, vuol dire che doveva rompersi. Molte cose ci univano, poche ci dividevano; ma quel poco era ancora troppo: anche l’amicizia tende a diventare totalitaria; non c’è via di mezzo tra l’accordo completo e la discordia, e perfino i senzapartito si comportano come se militassero in un partito immaginario. Non c’è niente da recriminare. È nell’ordine delle cose”.
Mi mancano i dettagli giusti per far dire la sua a Camus in una vicenda che non so con quale dose di onestà sia stata approfondita dagli storici e dai cronisti. Ma per quanto queste considerazioni mi lasciano libero prendo in prestito dal terzo volume dei Taccuini quello che Camus, da Roma, registra il 12 dicembre 1954: “Mi capita fra le mani un giornale. La commedia parigina che avevo dimenticato. La farsa del Goncourt. Stavolta ai Mandarini (il romanzo Les Mandarins, di Simone de Beauvoir, ndr). Sembra che io ne sia il protagonista. In effetti lo scrittore è collocato in un certo contesto (dirige un giornale nato dalla resistenza), ma tutto il resto è falso, i pensieri, i sentimenti e gli atti. Di più: mi vengono generosamente appioppati gli atti equivoci della vita di Sartre. A parte questo, una porcheria. Ma involontaria, come in qualche modo s’intuisce. La salute migliora. Giornata grigia. Piove su Roma, le cui cupole ben lavate brillano debolmente. Pranzo con F.G. La sera, solo; la febbre è passata”.
È intorno all’uscita de L’uomo in rivolta che si consuma la rottura fra due personalità forse troppo diverse per poter condividere, senza attriti, la stessa scena culturale e politica. La guerra che si lasciano alle spalle ha da poco sconfitto gli aberranti propositi della Germania hitleriana e reso più visibili le sanguinose contraddizioni dell’URSS; inoltre ha visto consumarsi, per la prima volta, l’opzione nucleare, e in più a danno di inermi popolazioni civili. Dopo essersi spartiti parte dell’Europa, USA e URSS (già alleati contro il nazismo) cercano di affermarsi l’un l’altro dando luogo a quello stato di tensione continua per cui si conia il termine “guerra fredda”. Capitalismo e comunismo provano a (s)piegare il mondo secondo contrapposti modelli di sviluppo. I problemi etici che questa gigantesca sagra di morti, minacce, sopraffazioni, idee, valori e manipolazioni solleva scuotono le coscienze, mobilitano gli impegni, favoriscono occasioni d’incontro e di scontro.
Entrambi orfani di padre in tenerissima età (è la sola similitudine) da lì in poi è tutto un divergere: la madre analfabeta di Camus è agli antipodi dalla ricca biblioteca del nonno materno di Sartre; una borsa di studio per le doti del piccolo Camus diverge molto dall’insegnamento privato che supplisce la scuola pubblica per Sartre; la frequentazione di un paesaggio mediterraneo che sostanzia in Camus il rapporto determinante con la natura è imparagonabile ai circoli di laica intelligenza parigini dove Sartre si allena al logos come in una palestra dell’anima. L’incontro avviene secondo le fredde regole del gioco di Parigi. Camus cerca di farle sue ma ci riesce fino a un certo punto. Le pubblicazioni de Lo straniero e, poco dopo, de Il mito di Sisifo lo pongono al centro di un notevole interesse, non solo critico. La sua atipicità attrae e insospettisce. Il resto ce lo racconta la storia, compreso il taciuto, l’irrisolto, e compreso anche quanto potrebbe essere stato scritto e ancora non ritrovato. Ad avere la pazienza dei veri cercatori, certi capitoli non si chiudono mai.
Resisto alla tentazione di seguire in dettaglio cause e conseguenze della loro rottura molte delle cui tracce sono contenute qua e là nei libri che intanto, per meglio servire la memoria, ingombrano il tavolo da lavoro. Non avevo iniziato le mie considerazioni con questo scopo, e tanto vale che io resti nel progetto. Ma su tre particolari, ancora, voglio appoggiarmi per chiudere questa testimonianza in modo aperto: con un dubbio piuttosto che con una sentenza, con vista sullo sconosciuto piuttosto che sul rassicurante. Li considero tre fotogrammi di un film ignoto, incapaci di dare luogo a colpi di scena, salvo suggerire l’ipotesi di un improbabile riconoscimento che Sartre farebbe di Camus dopo la sua morte, ma in una forma così forzatamente ellittica da potermi valere le più motivate accuse di tendere alle faciloneria del lieto fine.
Il primo estratto è dal già citato articolo di Sartre in morte di Camus: “Perfino il suo silenzio, in questi ultimi anni, aveva un aspetto positivo; cartesiano dell’assurdo, rifiutava di abbandonare il terreno sicuro della moralità e di impegnarsi nelle vie incerte della pratica. Noi lo avevamo intuito, e avevamo anche intuito i conflitti che lui taceva: la morale, infatti, se la si prende da sola, richiede ad un tempo la rivolta e la condanna”.
Il secondo è preso da La caduta: “Ha notato che soltanto la morte ci ridesta i sentimenti? Come vogliamo bene agli amici che ci hanno lasciato, vero? Come ammiriamo quei nostri maestri che non parlano più e hanno la bocca piena di terra. Allora l’omaggio viene spontaneo, quell’omaggio che forse avevano atteso da noi tutta la vita. Ma lo sa perché siamo sempre più giusti e generosi coi morti? È semplice. Verso di loro non ci sono obblighi. Ci lasciano liberi, possiamo scegliere noi il momento, trovar posto per l’omaggio fra un cocktail e un’amante carina, a tempo perso, insomma. Se un obbligo ci fosse, sarebbe quello della memoria, e noi abbiamo la memoria corta. No, nei nostri amici amiamo il morto fresco, il morto doloroso, la nostra emozione, noi stessi insomma!”.
Il terzo, ancora dalla commemorazione: “Il suo silenzio, che secondo le circostanze e il mio stato d’animo, giudicavo talvolta troppo prudente e talaltra doloroso, era una qualità di ogni giornata, come il caldo e la luce, ma umana. Si poteva vivere in accordo o contro il suo pensiero, quale ce lo avevano rivelato i suoi libri – e soprattutto La Chute, il più bello forse e quello meno capito…”.
Ecco, mi assumo tutta la responsabilità dell’interpretazione, ma a me sembra che Sartre, nel momento in cui fa la pubblica commemorazione di Camus, si esponga volutamente al severo giudizio postumo dell’ex amico; indica addirittura, a chi non lo sapesse o non lo ricordasse, in quale opera è contenuto, quel giudizio “e soprattutto La Chute, il più bello forse”. Se così stanno le cose, credo sia un modo molto elegante per dare all’altro l’ultima parola, per riconoscerne la ragione e per confessare, al tribunale senza prescrizione della Storia, di quali manchevolezze possono risultare permeati anche i più indiscutibili meriti.





