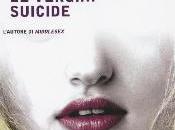Più che raccontare come nascono le storie, nel suo libricino Da dove vengono le storie?, Kureishi racconta la nascita della sua vocazione letteraria che è strettamente legata a quella del padre. Suo padre era un aspirante scrittore e ogni mattina si metteva la sveglia all’alba e pestava sui tasi di una ingombrante macchina da scrivere, prima di recarsi all’ambasciata pachistana, dove lavorava. Scrivere:
Più che raccontare come nascono le storie, nel suo libricino Da dove vengono le storie?, Kureishi racconta la nascita della sua vocazione letteraria che è strettamente legata a quella del padre. Suo padre era un aspirante scrittore e ogni mattina si metteva la sveglia all’alba e pestava sui tasi di una ingombrante macchina da scrivere, prima di recarsi all’ambasciata pachistana, dove lavorava. Scrivere:
«Gli dava un senso o, come gli piaceva dire, una “direzione”. La direzione che gli dava era quella di casa, visto che scriveva spesso dell’India, paese che aveva lasciato quando aveva compiuto da poco vent’anni e dove non era mai più ritornato».
Perciò a 60 anni aveva terminato cinque, sei romanzi. Purtroppo nessuno fu mai pubblicato e questa per lui fu un’autentica tragedia. Ogni rifiuto gli provocava una tremenda disperazione che coinvolgeva tutta la famiglia.

Comunque Kureishi padre amava parlare con le persone e faceva congetture sulle loro vite. “Mettiamo un giorno che quell’uomo laggiù…” e inventava delle storie che raccontava al figlio Anif. E’ stato così, attraverso questo gioco e divertimento, che gli ha insegnato a raccontare storie.
Sebbene la tenacia del padre non sia servita, l’autore del Budda delle periferie resta convinto che la cattiva scrittura possa garantire la buona scrittura e che la quantità possa portare alla qualità. Di certo non crede che diventare artisti presupponga l’abbandono della normalità in favore di una vita bohémienne.
«Le persone scrivono perché è importante esporre il loro punto di vista della storia senza essere interrotti … Scrivere significa farsi trascinare una seconda volta dall’esperienza; significa anche assaporarla».
Se per un verso la scrittura ci permette di lenire le ferite che ci sono state inferte dal mondo e diventa una sorta di auto-guarigione, per un altro la creatività scatena dei disturbi perché: “E’ una

L’arte rappresenta la libertà della mente di andare dove vuole e di esprimere desideri pericolosi. L’artista è in contatto con l’inconscio e “può essere un canale per l’espressione di ciò che è proibito, di ciò che è pericoloso dire”.
E già! Cavalcare il confine che separa realtà e finzione può essere pericoloso per l’equilibrio psichico. Ad esempio c’è il rischio di non sapere più da che parte ci si trova. Agire sulla finzione, la metafora, la rappresentazione ha un’influenza sul reale. Maneggiare le metafore non è innocuo come ben sanno poeti e psicoanalisti. Basta assistere a una riunione di sceneggiatura – dove story editor, produttori e sceneggiatori si accapigliano sui personaggi di una serie tv come fossero loro parenti – per rendersene conto. Gestire le metafore è pericoloso perché si può perdere di vista qual è il confine tra ciò è vero e ciò è finto.