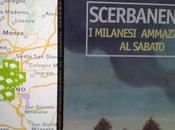Da Potosí a Cochabamba. Oggi viaggiamo attraverso la Bolivia. Prosegue l’itinerario nel mondo in viaggio con la Vespa (e non solo) di Giorgio Càeran, con la tredicesima puntata.
—
di Giorgio Càeran
Da Giramondo libero – In viaggio con la Vespa o con lo zaino (Giorgio Nada Editore)
(gennaio 1988, parte di un viaggio iniziato il 1° ottobre 1987 e finito il 24 aprile 1988)
Dopo due giorni di permanenza a Oruro, il 6 marzo mi separo ancora dal francese Christophe Guyot per dirigermi a sud-est, verso Potosí, su un percorso che si snoda per trecentotrentacinque chilometri su strade non asfaltate e maltenute, che salgono e scendono vivacemente a svolte lungo le pendici delle Ande. Noi due però avremmo avuto un’altra occasione d’incontro: sei mesi dopo, infatti, lui è venuto a Milano dove l’ho ospitato con gioia.

Potosí (da Wikipedia)
Al mattino presto di lunedì 7 marzo giungo a Potosí (m 3976 s/m), località che mi sembra la più bella della Bolivia. Malgrado pioggia e freddo persistenti, faccio lunghi giri per la città, salendo per vicoli lastricati dall’aria antica su cui si affacciano numerose verande dal tetto di lamiera o di fibra di vetro. Le due piazze principali e la via Sucre, animate dal passeggio e dal traffico, sono particolarmente accoglienti.
La storia narra che Potosì nel 1598 fosse la città più ricca del mondo, già famosa per le sue miniere d’argento che riempivano i forzieri dei sovrani di Spagna, e che fosse più popolata di Londra e di Madrid.
Per i turisti una visita alla sua miniera è di prammatica, così decido di visitarla in quella stessa mattinata del mio arrivo. Mi unisco a un gruppo di undici persone condotto da una guida locale, un certo Eduardo Garnica. Per giungere alla miniera privata, quella di San Luis sul Cerro Rico, ci serviamo di un microbus e successivamente saliamo a piedi, sotto una pioggia scrosciante, su un versante dell’alta e ripida montagna (m 4750 sul mare), dove qua e là sorgono le baracche dei minatori. Giunti a destinazione, ci troviamo con un po’ di fiatone, tremanti per il freddo e per la pioggia. Poco prima un tedesco, vedendomi camminare a passo spedito, si era rivolto a me dicendo: “Anch’io alla tua età mi muovevo con disinvoltura, ma quando compirai 32 anni ti renderai conto che non sarai più scattante come adesso”. Gli ho risposto che avevo quasi trentasei anni, ma lui non ha voluto credermi.
Accanto all’ingresso della miniera c’è un’angusta baracca adibita a bar, dove beviamo un tè con la coca, privo di sapore ma almeno caldo. La guida ci fornisce lampade a carbone ed elmetti, dopodiché iniziamo la nostra visita. Dapprima la temperatura è fredda come all’esterno, mentre camminiamo nel buio, in un pantano provocato dall’acqua piovana. Sono in testa al gruppo quando, in una curva stretta, vedo venirmi incontro un carrello spinto a tutta forza da due minatori sudatissimi. Non essendoci spazio sufficiente a fianco del binario, non posso evitare lo scontro e vengo colpito sul braccio sinistro. Eduardo si mette poi a capofila e proseguiamo passando a fatica per basse gallerie che obbligano a piegarsi. Questo però è solo l’inizio, il difficile deve ancora venire. Scendiamo al primo, poi al secondo piano, mentre la temperatura aumenta rapidamente e l’aria si fa più pesante, a tratti irrespirabile. Si scendono scalini scivolosissimi, si sale su scale di legno di fortuna alquanto malferme. Con l’intrecciarsi delle gallerie, i soffitti si abbassano sempre più, sino a giungere a cinquanta e persino a trenta centimetri dal suolo. Procedere è assai faticoso, tanto che se non avessimo l’elmetto le nostre teste sarebbero costellate di bernoccoli. Una volta scesi al terzo piano, le difficoltà aumentano; in più, ci si sente soffocare. Al quarto e penultimo piano siamo sudati e stanchi morti, sia per la fatica sia per la mancanza di ossigeno. La temperatura è salita a circa quaranta gradi, e si respira tanta polvere di silicio, fastidiosissima.
Una coppia d’argentini, un tedesco e io, benché stravolti, seguiamo la guida per arrivare all’ultimo piano, ma a metà strada ci accorgiamo che nessuno degli altri elementi del gruppo ci segue. Non sapendo che cosa sia successo, torniamo indietro e infine scoviamo otto giovani, seduti, letteralmente crollati, i quali dicono di averne abbastanza. Nel mio gruppetto nessuno chiede di continuare, perché siamo a nostra volta al limite della resistenza, perciò ci concediamo una sosta. Sopraggiungono due minatori indios, con i quali chiacchieriamo un po’. Mi vengono i brividi, pensando a quell’allucinante mestiere che non permette loro di vivere oltre i trentasette anni. Noi siamo quasi privi d’energia soltanto per essere scesi e saliti in quegli strettissimi tunnel, mentre i minatori devono addirittura salire portandosi appresso sacchi di minerali (stagno, zinco e argento) dal peso variabile fra i trenta e i quaranta chili: una fatica immane, considerando l’assenza di ascensori. La visita alla miniera è stata utile per avere un’idea di quale sia la vita massacrante di quegli uomini, sfruttati a dismisura. Poveracci! Non meraviglia quindi che a Potosí e a Oruro i minatori fossero da sempre in lotta contro i governanti, nel tentativo d’impedire un simile sfruttamento: per tante, troppe volte, sono stati oggetto di crudeli massacri ordinati dai regimi di turno, ma nonostante ciò sono la parte più attiva del proletariato boliviano, stando sempre in prima fila durante scioperi e manifestazioni, intenti a rivendicare sacrosanti diritti.
Al proposito, segnalo il libro Rulli di tamburo per Rancas, del peruviano Manuel Scorza (Feltrinelli). In Perù brani di questo testo vengono imparati a memoria dagli indios che, a ragione, la considerano la loro opera epica. Pur essendo il romanzo ambientato sulle Ande peruviane, in qualche modo rende giustizia anche agli indios boliviani, descrivendo la loro drammatica realtà.

Mercato a Cochabamba (da Wikipedia)
Lasciata Potosí, vado a nord-est verso Sucre (metri 2.790 s/m), giungendovi dopo aver percorso centosettanta chilometri di strada dissestata. Altri due giorni e riparto su un vecchio torpedone, ovviamente con i bagagli dei passeggeri legati sopra il tetto, spostandomi a nord-ovest, verso Cochabamba. Lì le strade sono terrificanti: i percorsi deteriorati di terra battuta seguono l’andamento ondulato del suolo, salendo e scendendo, in un susseguirsi di stretti tornanti che hanno da un lato alte pareti rocciose e dall’altro paurosi strapiombi. La vegetazione è costituita da cespugli d’erba, cactus e qualche piccola, rara pianta. Si vedono un po’ ovunque campi di mais e più oltre vacche, capre e lama al pascolo. Le cime delle montagne, benché molto alte, non sono impervie, ma hanno un aspetto invitante.
Di sabato a Cochabamba c’è un mercato grandissimo, pieno di bancarelle d’ogni tipo (è il più grande e il più caratteristico di quelli che ho visto nell’America Latina), dove si vende di tutto, ed è il miglior centro boliviano per comprare i famosi charangos (piccole chitarre a cinque e più corde, con la cassa armonica costruita con il dorso di armadillo). Dentro il mercato ci sono anche luoghi di ristoro economici, che io provo spesso. Purtroppo, durante i tre giorni della mia permanenza piove quasi ininterrottamente, cosa alla quale ormai mi sto abituando. Camminando nelle strettoie del mercato, m’infango parecchio: il suolo è ridotto a un enorme pantano costellato di pozzanghere per la pioggia incessante. Se il mercato di Cochabamba è assai vivo e seducente, non si può dire altrettanto della città che, come tutti i grandi centri cresciuti troppo in fretta, non conserva edifici attraenti; purtroppo, ancora una volta, il moderno stile dei gringos soffoca e distrugge le vecchie costruzioni andine.
Per saperne di più consulta l'articolo originale su: