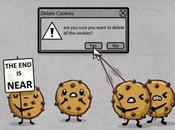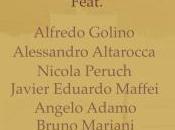Anno: 2011
Durata: 84′
Genere: Drammatico
Nazionalità: USA
Regia: Todd Solondz
Mia madre mi ha detto che ho due anni per sposarmi e figliare.
Dopodiché si va oltre la data di scadenza. Quando me l’ha detto, il pensiero è subito andato ad un episodio preciso. Avevo sedici anni, la professoressa di Italiano, a corto si vede di idee più brillanti, ci diede un tema dal titolo sensualissimo: “Come immagini la tua vita tra vent’anni”. È assolutamente accessorio specificare che qualsiasi cosa avessi scritto, non ha poi trovato minima realizzazione.
Fallire non piace a nessuno, suppongo.
E lo dico brandendo l’ultimo libro di auto-aiuto che ho acquistato: “Superare la fine di una relazione”. In America non si trovano i pomodori San Marzano o lo stracchino, ma se volete capire come prendere in mano la vostra vita, come diventare arbitri attivi del vostro destino, non c’è che l’imbarazzo della scelta.
In America fallire è la vera e temuta piaga sociale, il vero grande demonio.
Quasi trecento milioni di abitanti e le velleità mietono più vittime della gonorrea a Versailles. E d’altronde come sottrarsi a questo mesto fato, quando si viene al mondo con la convinzione che ci sia spazio per te, per le tue idee e i tuoi sogni, che basti lavorare sodo e rimanere positivi. Cosa succede quando si reclama una vita per la quale ci si è allenati per anni e invece ti dicono, che no, hai aperto la scatola e la vita che hai ordinato è ora fuori stock?

Questo è in sintesi il quesito esistenziale alla base dell’ultimo film di Todd Solondz, Dark Horse (in italiano “cavallo nero”). Il titolo è preso di peso dal gergo dell’ippica ed indica per traslato un cavallo che vince una gara a sorpresa, stupendo tutti. La mitologia del dark horse o dell’underdog, dello spostato che s’afferma su tutti in uno slancio di redenzione, è una costante dell’industria culturale e della fenomenologia americana.
Anche Abe, (Jordan Gelber – Boardwalk Empire), il protagonista della pellicola, un trentenne scioperato, collezionista di giocattoli, ancora domiciliato a casa dei genitori, (Mia Farrow e Christopher Walken), vede se stesso sotto questa luce. Anche lui è un dark horse, e non importa che non abbia una carriera e di fatto una vita, il suo momento arriverà, deve arrivare.
L’incontro con Miranda (Selma Blair) sembra corroborare le sue speranze. Poco importa che Miranda stessa sia vittima della medesima sindrome. Esausta dopo la fine di una relazione, svuotata di ogni ambizione artistica e accademica, Miranda si convince che sia giunto il momento di soccombere alla normalità, trovarsi un marito, propagare la specie. Obnubilata dagli psicofarmaci, Miranda cede così alla corte di un estasiato Abe, ignaro di cosa stia in realtà per accadere.

Non sempre si può sostituire il giocattolo difettato. Non sempre si può reclamare la felicità che si è convinti ci spetti. La ricevuta non basta. Tutti hanno una ricevuta, ma la felicità è una merce che scarseggia.
Nonostante la materia cupa e onerosa, Dark Horse è un film estremamente divertente. Ed estremamente profondo e delicato. In passato Solondz aveva affidato la sua vena fustigatrice ad un humour più abrasivo, giocando la carta dello shock, si pensi alla quasi insostenibilità di Happiness (1998), per questa ultima prova, invece, il regista, una voce ormai autorevole e “pacificata” del cinema indipendente americano, retrocede e mostra la perfezione del suo stile, trovando un equilibrio aureo.
Dark Horse commuove e stimola il pensiero, ferisce ed immalinconisce, il tutto tre secondi dopo averti fatto scoprire i denti in un’aperta, seppure amarognola risata. Solondz è finalmente un autore, ha conquistato una cifra espressiva, un marchio, ma forse sarebbe meglio dire uno stigma, personalissimo. Due minuti di immagini e parole bastano per identificarlo. È tutto lì, nei dettagli precisi eppure surreali, nei dialoghi possibilissimi ma bislacchi, nell’immagine ferma e severa, quasi a cercare di dominare la materia umana e narrativa, di fatto ineffabile e crudele.
Ciò che mi ha stupito di Dark Horse non sono solo le proporzioni inattaccabili della messa in scena e della narrazione – non c’è una parola od un gesto di troppo -, no, quello che mi ha letteralmente lasciato senza fiato è l’inedita tenerezza che questo film suscita. Tenerezza ben in incognito, sia inteso, ma così autentica che non può sfuggire.

Le ineccepibili scelte di cast certo facilitano l’effetto. Bravissimi e in ruolo tutti gli attori, forse un po’ prevedibilmente nel caso di Selma Blair, ormai specializzata in borghesi impasticcate sull’orlo di una crisi di nervi. Una menzione particolare va di sicuro al protagonista, Jordan Gelber, professionista di Broadway che ha probabilmente trovato la parte della sua vita.
Solondz sembra aver raggiunto uno stato di grazia, per quanto un’anima tormentata come la sua possa concepire l’idea. Il segreto sta forse nella nuova compassione che il cineasta mostra, coraggiosamente – essere cinici si sa, vende – verso i suoi personaggi così sgangherati, fallati ed irrecuperabili.
Forse che questo sia l’unico atteggiamento esistenziale plausibile?
D’altronde non ci accatastiamo tutti, ricevuta alla mano, a reclamare una vita perfetta, senza magari prestare attenzione al fatto che potevamo semplicemente avere più cura del giocattolo?
Ma che fare dunque, è tardi per recriminare e, soprattutto, è totalmente inutile.
Stefania Paolini