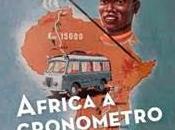Disobbedire significa trasgredire a un’obbligazione imposta da un’autorità, sia questa quella della legge, oppure, ancora, di un imperativo morale o di un precetto religioso o di quello che passa come il conformismo del senso comune. Degli altri casi non mi occuperò, mentre vorrei invece interessarmi dell’ultimo e di alcune sue trappole.
Per noi questo dovrebbe essere un caso particolarmente interessante, poiché, a meno che tu non viva in uno stato dove le libertà politiche e civile siano completamente assenti e la gente venga fatta sparire nei campi di concentramento, credo che la possibilità di disobbedire sia tra i principali obblighi che qualsiasi mente critica dovrebbe coltivare.
Messa giù così, la cosa rischia di essere troppo aulica e alta e puzza di tromboneggiamento moralistico, che poi è la cosa di cui vorrei, in realtà, occuparmi. È anche un’affermazione imprecisa a dire il vero, perché presuppone che ognuno di noi possa essere una mente, sempre quella, costante nel tempo e nella sua capacità di ricostruire la sua biografia. Non è così naturalmente. L’unità della nostra personalità (la nostra identità personale, come si dice) è una finzione, ossia una costruzione, che parte dalla memoria e senza la memoria crolla.
Con una metafora fortunata, David Hume descriveva il nostro io come il protagonista di una rappresentazione teatrale, il raccoglitore disordinato delle sensazioni che ci abitano (bundle of perceptions, la bella espressione che usa). Nulla di sostanziale oltre a questo, non certamente un io e una personalità che permangono dietro questo fascio, a dirigere questo wild bunch.
Tutto questo per dire che non esiste una mente critica, perché ognuno di noi, anche il filosofo più scafato, disincantato, cinico, ha numerosi momenti in cui il suo senso critico latita, le sue capacità di distinguere sonnecchiano nel dormiveglia, nel quale domina l’opinione prevalente e il conformismo che si indossa come l’abito comodo, al quale siamo affezionati.
Tutto questo potrebbe suonare come una excusatio non petita, ed infatti lo è, perché voglio farvi partecipe di due mie momenti di incapacità di disobbedire.
Il primo mi è capitato qualche anno fa. Stavo facendo le pulizie a casa, ascoltando la radio. Intervistavano Umberto Galimberti sull’amore (solo perché ci aveva scritto un libro, non perché passi, per quel che ne ho sentito, come un grande amatore). Ho letto qualcosa di Galimberti quando ero più giovane ed inesperto. Mi sembrava, allora, noiosissimo, sia per la prosopopea moralistica sia per come costruisce i suoi libri: collezioni enormi di citazioni di testi altrui e spesso di testi propri, con un uso disinvolto delle fonti, per il quale subì un affettuoso buffetto dalla sua università, che aveva aperto un’indagine, a pochi mesi dalla pensione e senza nessuna conseguenza. Se non un copione, un pigro che fatica a usare il proprio cervello (è per questo, temo, che continua a imperversare sui giornali, nonostante le accuse che gli sono piovute addosso).
Bene: tutte cose che sapevo, eppure l’intervista di Galimberti mi catturò. L’argomento del suo nuovo libro era l’amore (Le cose dell’amore, il titolo) e Galimberti svolse il suo discorso sulla seduzione e l’irresponsabilità che ci cattura quando siamo, disgraziatamente, innamorati e posseduti, quindi, da una forza che ci fa fare quanto normalmente non faremmo, mostrando perciò che l’io è una parola e una maschera, proprio come diceva Hume.
Galimberti è spesso tutt’altro che sciocco (anche se è stato sciocco a pensare che nessuno si accorgesse del suo uso disinvolto delle fonti, a riprova del fatto che è sempre meglio coltivare la credenza che i nostri interlocutori siano più intelligenti di noi, se non altro per non mettersi automaticamente in una posizione di debolezza) e sicuramente non lo fu in quella circostanza. La mia reazione, che pure sapevo di Galimberti e della disistima che lo circonda in ambienti non marginali del mondo intellettuale, fu quella di pensare che avevo trovato uno che sull’amore la pensava come me: una forza proteiforme che fa sì che l’amore possa essere qualsiasi cosa, al punto che si può amare odiando.
Forte di questa conferma, solamente immaginata, alle mie elucubrazioni mi recai fiducioso a comprare il volume per scoprire, naturalmente, che si trattava sempre e comunque del solito Galimberti, pieno di citazioni risultanti in un centone raffazzonato nel quale tromboneggiare con il paravento di nomi illustri, senza l’ombra di una elaborazione personale.
Avrei fatto meglio a disobbedire al mio stesso io che mi suggeriva di aderire al conformismo della seduzione verbale di Galimberti, del quale ridicolizzavo spesso la fotografia che campeggiava nella rubrica che tiene sul settimanale D, il magazine femminile de La Repubblica. Il viso barbuto sorretto da due manone a deformare le guance in un atteggiamento pensoso. Non so se questa foto ci sia ancora, ma è bella anche quella che campeggia in alto a sinistra del suo sito ufficiale. La mano sinistra sorregge il volto appesantito da profondi pensieri, da troppi pensieri, di solito non suoi, che la sua alluvionale bibliografia minaccia di elargirci in altri libri. Anni fa, la sua casa editrice (Feltrinelli) aveva addirittura varato una collana dedicata alle sue opere. Non so che fine abbia fatto ,dopo le accuse di plagio che gli sono state ripetutamente rivolte e dalle quali si è maldestramente difeso.
Insomma, il caso Galimberti mi insegnava, che disobbedire significa il più delle volte, almeno per noi che viviamo in paesi dove le libertà sono giuridicamente assicurate, disobbedire a se stessi, e non fidarsi di se stessi contenendo il nostro narcisismo, soprattutto quando viene esaltato da qualcuno che abilmente dice le cose che noi vogliamo sentirci dire. Con l’acquisto incauto del libro di Galimberti deve essere accaduto a me quello che è accaduto anche a tante (troppe) altre persone, alle quali Galimberti è stato capace di parlare in termini talmente vaghi da far sì che ognuna di loro leggesse nelle sue parole quello che a lei piaceva.
L’altro episodio di mancata disobbedienza è ancora più significativo, secondo me, perché incorpora una beffarda nemesi. Navigavo sul sito della casa editrice Adelphi per vedere le novità. Mi imbatto in un libro di Goffredo Parise, scrittore che non conosco affatto, ma il titolo mi fa lo stesso effetto che mi aveva fatto sentire l’intervista di Galimberti. Difficile resistere a un titolo come Dobbiamo disobbedire, che coltiva in maniera così evidente il nostro narcisismo, che ci fa credere unici, irripetibili perché capaci di dire la nostra, andare controcorrente, pensare oltre la massa, disobbedendo alle opinioni ricevute. Ci vuole del coraggio per acquistare un libro che incita alla disobbedienza ed io questo coraggio ce l’ho!
Infatti, non ho resistito e mi sono ritrovato vittima del marketing. Quello che ho tra le mani (anzi: sul mio ereader; almeno mi sono risparmiato la fatica di fare la strada per andare in libreria) è un insieme di sconcertanti idiozie passatiste, che lo scrittore compose tra il 1974 e il 1975 per il Corriere della Sera, che si confermava Corriere della Sciura ben prima che Dagospia coniasse questa calzante declinazione del suo stile.
Alcuni di questi pezzi sono esempi di comicità involontaria, come l’irraggiungibile articolo Il rimedio è la povertà (il mio preferito), nel quale sembra di leggere tante delle banalità contemporanee sulla decrescita, oltre che le insopportabili litanie anti-moderne di Pasolini.
Tutte cose insopportabili, non tanto perché sbagliate, quanto perché fatte da chi ha il culo pieno. È un atteggiamento che Nieztsche ridicolizzava quando scriveva (non ricordo più dove, ma spero di non essere accusato di uso disinvolto delle fonti) “sempre i semidei sono vissuti prima. Sempre l’epoca presente è quella degenerata che sospira al cadere delle foglie”.
Dopo aver tuonato che “Lo spettacolo dei ristoranti di massa (specie in provincia) è insopportabile.” (ma perché specie in provincia? Perché gli rovinava l’estetica bucolica la vista di masse di bifolchi morti di fame?), Parise ci informa che “Povertà non è miseria, come credono i miei obiettori di sinistra. Povertà non è ‘comunismo’, come credono i miei rozzi obiettori di destra. Povertà è una ideologia, politica ed economica. Povertà è godere di beni minimi e necessari, quali il cibo necessario e non superfluo, il vestiario necessario, la casa necessaria e non superflua.”
Insomma: la povertà è bella soprattutto se è godimento dei beni minimi. Penso si possa tranquillamente dire che qui è il cretino che parla, immerso nella sua debolezza intellettuale e incapace di vedere che non c’è nessuna grandezza nella povertà, nessuna bellezza nelle case che cadono a pezzi, nessuna riscossa sociale nell’essere costretti a comprare il cibo in superofferta perché sta per scadere, nessuna dignità nella camicia con il collo liso, bensì solo tristezza e minorità. E poi, ognuno di noi capisce che ‘beni minimi’ non significa nulla.
Nella sua miopia Parise non riuscì a vedere oltre la sua mente e ad immaginare che il minimo sarebbe potuto diventare il minimal e uno stile costoso, perché viveva nell’epoca dei beni materiali, dove la ricchezza si misurava nel possesso, mentre ora si misura sempre di più nell’accesso a servizi. Era, insomma, preda della falsa credenza che il capitalismo (sì, proprio il capitalismo, proprio quello che gli permetteva di scrivere sul Corriere della Sciura) sia materialismo, anziché il più potente movimento spirituale si sia mai presentato sulla scena della storia umana (spirituale perché capace di ridurre tutto a merce, creando dei bisogni, che sono prodotti dello spirito, per ciò che prima non esisteva). Parise avrebbe voluto esistere e scrivere nella Vita dell’Italia dei più (titolo di un altro insopportabile pezzo), ma dal momento che i più affollano ristoranti, vogliono andare in vacanza d’estate, e altre cose tenacemente volgari, i suoi lamenti rimangono, ancora oggi, insopportabilmente snob. Oggi me lo vedrei facilmente lamentarsi che tutti hanno una connessione e che i prezzi dei servizi telefonici sono crollati e sollevare le sue lamentele su come è volgare tutta quella gente che telefona in strada, anziché sfondarsi le tasche di gettoni telefonici alla ricerca di una cabina libera, magari per chiamare il pronto soccorso perché ha un micidiale attacco d’asma.
Poi però scopro Parise è stato uno che si è appassionato ai viaggi, che girava il mondo, che ha scritto dei reportage (raccolti in un altro volume, che non leggerò). E allora? Viaggiare andava bene solo se lo faceva lui e i suoi compagni di merenda, ma se lo fa il povero cristo con la morosa per andare in un resort sul Mar Rosso oppure per visitare uno sconosciuto fiordo in Norvegia oppure per andare a vedere una mostra a Parigi, approfittando di un’offerta low cost (come feci io anni fa, trascinando una morosa riluttante a vedere una mostra di Francis Bacon, vero pessimista senza redenzione) allora è una cosa di massa, contaminata da perversioni consumistiche e dannazioni morali. Sentenza: regrediscano alla povertà!
Hanno qualcosa in comune questi due esempi? Be’… per prima cosa hanno in comune che gli autori, uno da vivo, l’altro da morto, ma con la complicità dell’abile marketing della casa editrice, hanno esibito la loro capacità di manipolazione, poiché sono riusciti a precipitarmi nel vortice della debolezza intellettuale e della coazione all’acquisto di un bene che pensavo mi descrivesse quello che credevo di pensare sull’amore e sulla disobbedienza; in secondo luogo, credo abbiano in comune la malafede. Nel primo caso, quella di spacciare pensieri altrui come proprie rarefatte profondità; nel secondo, di mascherare il proprio desiderio di superiorità sulla folla (che evidentemente lo terrorizzava), elargendo un desiderio di povertà, soprattutto se realizzato dagli altri, così che lo scrittore possa elucubrare i suo abissali pensieri in un qualche raffinato ristorante senza la massa volgare e consumista tra i piedi, che però nell’un caso e nell’altro farebbe in ogni caso bene a spendere qualche euro per comprare i loro prodotti, anziché andare in un ristorante etnico, comprare un tablet, prenotare una vacanza.
Entrambi penso siano stati incauti acquisti in un senso prossimo a quello giuridico, proprio perché non avevo accertato la qualità del bene che avevo ricevuto, sebbene avrei dovuto esserne avvertito dalla qualità di chi me lo offriva nel primo caso e non avrei dovuto fidarmi ciecamente nel secondo, solo perché sedotto da un titolo. L’articolo 712 del codice penale infatti recita: “Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda non inferiore a dieci euro. Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza.”
Almeno sono sicuro, per quanto riesca a ricostruire della mia memoria, di non averli consigliati a nessuno e di non essere incorso nella fattispecie dell’ultimo comma.
di Pier Marrone