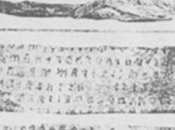Piede fermo.
Non fui che un povero buffone di corte. Nulla che poco più che un mercenario addetto a titillare il diaframma del Re, a provocare il suo riso. In apparenza, dunque, un eruttatore fisso di lazzi, un farmaco contro l’ipocondria dei grandi: il più deforme e il più vile dei servi. Così giudicarono gli uomini, tale mi videro. Io solo e Dio sapeva, invece, chi veramente fossi. Benché ignobile e indegno ero, accanto ai padrini della terra, la verità travestita da pazzia. Gli uomini odiavano la verità ma non potevano farne del tutto a meno. La tolleravano soltanto a briciole e meglio ancora se quelle briciole erano nascoste in pillole vagamente colorate. Il buffone di corte, dentro il suo vestito a strisce verdi e gialle, era quel tanto di verità che i principi riuscivano a sopportare. Ma la verità fa paura: apparisca dunque in persona di gobbo e di contraffatto. La verità non si attenti ad offendere chi sta in alto: sia dunque rappresentata dai nani. La verità è spesso dolorosa: si esprima, dunque, per facezie e per frizzi. La verità è molesta perché savia: si nasconda, perciò, sotto il gaiopinto giubbetto della pazzia. Soltanto così camuffata mascherata e mortificata la verità era ammessa vicino al trono. Come lo scheletro assiso ai banchetti dell’antico Egitto ricordava ai viventi che tutto passa e muore così toccava a me, alla corte di Enrico VIII, ricordare ai grandi che ogni grandezza è ridicola e risibile miseria. Le sue mogli non erano, per me, che moriture concubine; la sua giustizia un legale assassinio; la sua religione una gruccia della tirannide; la sua maestà una commedia mal recitata. Ma non potevo mettere più d’una stilla di verità pura in un boccale di beverone faceto. Ed ero costretto a mulinare cento girandole di ghiribizzi sciocchi e turpi perché vi scintillasse framezzo una favilla di vero. La mia vita doppia era quasi sempre un patire, talvolta un martirio. Avevo anch’io giudizio di uomo e cuore di cristiano eppur dovevo dire e ascoltare ogni sorta di sconce lepidezze, di goffaggini bestiali. Nelle cene notturne avevo l’obbligo di ravviare coi miei sberleffi lo sghignazzio dei bevitori e allora approfittavo dell’ebrietà dei padroni per far ronzare ai loro orecchi villosi qualcuno dei pensieri che dentro mi ribollivano. E siccome la verità è anche libertà io, il più sbertucciato servo di palazzo, ero l’unico che potesse dire il parere suo liberamente senza giocarsi la vita. Rappresentavo, sotto la protezione del berretto a sonagli del buffone, la satira della vita, il rovesciamento delle convezioni venerande, il giudizio di Dio costretto a far la parte dell’advocatus diaboli. La mia voce, anche se recitava goffe filastrocche o sguaiate salacità era pur sempre la voce degli schiavi muti e dei ribelli che ciondolavano dalle forche. Ebbi anch’io le mie macchie e le mie viltà eppure confido che mi sarà data perdonanza per quel tanto di verità e di giustizia ch’io seppi mischiare alla mia finta pazzia. (Meditazione su Will Summers in Giudizio universale di Giovanni Parini).
E R S O V R A N O P R A T I C O
C’era una volta un celebre buffone
che se beccava cento scudi ar mese
pe’ tené alegro er Re d’una nazzione:
er Re rideva, e er popolo minchione
piagneva su li conti de le spese.
Un ber giorno, però, fu licenziato.
-Come sarebbe a di’? Me cacci via?
-chiese er buffone- E quanno m’hai cacciato
chi farà divertì la monarchia?
chi farà ride er Capo de lo Stato?-
Er Sovrano rispose:-Per adesso
me basta quer partito intransiggente
che me combatte còr venimme appresso
e me s’alliscia rispettosamente…
Tu nun me servi più: rido lo stesso!
-Trilussa-
[Cerca: MERCENARI (settembre 2009) ]