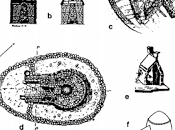L’Africa nord-occidentale, a ben vedere, è una delle linee di frattura del mondo, un estremo socio-ambientale che le carte geografiche non sanno mostrare. Il Sahel, la fascia di territorio stepposo che avvolge Mali e Senegal, raccoglie il grande fiato rovente del deserto che avanza. Il Sahel è frontiera nel senso più verticale del termine, è il cancello lungo migliaia di chilometri presso cui gli uomini si spezzano nel tentativo di arginare i danni della siccità. In senso opposto, è il penultimo terminale delle vie crucis emigratorie, quaggiù ci si imbarca per le lunghe traversate sahariane appesi a un camion sfasciato, con la speranza di arrivare vivi, senza essere rapinati degli ultimi dollari utili a scavalcare l’estremo baluardo del Mediterraneo
L’Africa nord-occidentale, a ben vedere, è una delle linee di frattura del mondo, un estremo socio-ambientale che le carte geografiche non sanno mostrare. Il Sahel, la fascia di territorio stepposo che avvolge Mali e Senegal, raccoglie il grande fiato rovente del deserto che avanza. Il Sahel è frontiera nel senso più verticale del termine, è il cancello lungo migliaia di chilometri presso cui gli uomini si spezzano nel tentativo di arginare i danni della siccità. In senso opposto, è il penultimo terminale delle vie crucis emigratorie, quaggiù ci si imbarca per le lunghe traversate sahariane appesi a un camion sfasciato, con la speranza di arrivare vivi, senza essere rapinati degli ultimi dollari utili a scavalcare l’estremo baluardo del Mediterraneo  (per conoscere i particolari di questo folle viaggio neo-iniziatico consultare il bellissimo “Bilal”, di Fabrizio Gatti, che racconta dal vivo l’esperienza).
(per conoscere i particolari di questo folle viaggio neo-iniziatico consultare il bellissimo “Bilal”, di Fabrizio Gatti, che racconta dal vivo l’esperienza).
Il Fuori-menù WSF di oggi è anche un fuori pista, un atto d’amore nei confronti del Reportage di viaggio, di ciò che non appare al mondo se non sulla tela del proprio percorso, quando siamo in grado di soffrirne intimamente ogni particolare.
Uno sguardo di qua e di là del Sahel, attraversando via terra questa linea di frattura che inquieta per unire i mondi incredibilmente distanti di due città-simbolo. Da una parte, sostenuta ancora dall’interesse occidentale di marca francofona, la grande centrifuga umana che anima Dakar, capitale del Senegal, cinque milioni di abitanti in perpetua dinamica; dall’altra il segno vuoto delle dimenticanze post-coloniali, il disfacimento architettonico, il morso dell’assenza di prospettiva, quella sorta di socialità arresa che si respira poco oltre confine a Bissau, capitale della Guinea portoghese, quattrocentomila anime scarse.
Dakar-Bissau, trecentosettanta chilometri di strada appena, due giorni di percorrenza via terra, con la benedizione di quattro taxi collettivi e due piroghe, nella migliore delle ipotesi che vi possa capitare.
Abbiamo messo insieme due stanze d’Africa e un’ipotesi di migrazione al contrario. Siamo due voci diverse, impressionate, su un confine che ci riguarda molto da vicino.
Bissau
Ascolto la sottile tensione dei nervi che si scarica sul taccuino. Sono partito stamattina alle otto e trenta dal Saltinho sotto la luce di un sole che mi squadra loscamente fin dentro il metro quadro d’ombra da cui vorrei farmi nascondere, ora.
L’agitazione della piazza si esprime di fronte a me come una paradossale moviola tra cortine di calore e polvere, nessuno sembra un personaggio reale all’incrocio di Makuti.
Dai puntelli ancora visibili, qualche tronco di ciò che una volta era un alberello testimonia un’antica cura evaporata. Oggi, poco prima delle quattro di pomeriggio, a ottanta chilometri scarsi dalla capitale, quelle filiformi nudità di tronchi sembrano puntellare la scena tutta, compreso quel poco di affetto assente che provo per questo che sembra l’oltretomba di un paese.
Aspettiamo tutti che qualcosa si metta in moto, realmente. I piccoli venditori d’anacardi con il negozietto chiuso in una mano, qualche improbabile funzionario con camicia a righe scure e cartella sotto braccio, molte donne cariche di ogni genere di pacchi, alcuni starnazzanti, tenuti provvisoriamente per le zampe.
Una famiglia in viaggio ha tirato su una vera casa d’emergenza con tre cartoni, un pareo stinto e una vecchia trapunta a far da pavimento, e ora si passano l’un l’altro una mezza carcassa di avocado dove piccole dita nere ancora raspano con desiderio.
C’è stato un momento un paio d’ore fa, ero appena sbarcato sulla desolata piazza, in cui ho visto tutto questo circo minore di pendolari bisognosi sollevarsi faticosamente e cominciare a correre sbandando sulla destra, davanti all’unico porticato dello spiazzo, poi ancora sul lato opposto, gettando a terra e riprendendo più volte con inesausto tono tutto l’universo tascabile che li accompagna.
Due o tre vecchi furgoni si stavano muovendo, nessuno gridava “Bissau, Bissau, Bissau”, come quando un trasporto collettivo apre il proprio fantasioso check-in, e i furgoni stessi si avviavano con portelli e finestrini chiusi ma, in un giorno di festività nazionale, la fame di distanza colmata è una molla insindacabile quaggiù, nei meandri rarefatti della Guinea portoghese.
Dakar è appena trecento chilometri di polvere e posti di blocco alle mie spalle, Dakar, a modo suo una raffinata entreneuse del caos organizzato, covo di procacciatori e ragazze bellissime, coacervo di gas e ferraglie e locomozione sbilenca, di sciami di bambini che s’intraversano, che fanno esplodere le urla in strada.
Dakar è un gioioso bilico di adrenaline vitali al confronto con le introversioni umane e le illusioni paesaggistiche della confinante Guinea.
E’ difficile credere agli inusuali estri delle maree del golfo di Bissau, così come me li hanno raccontati. Per questo il primo gesto che compio appena sceso sullo spiazzo polveroso della stazione d’arrivo è quello di trovare una macchina che mi accompagni velocemente al porto. Nessuno sa nulla del Ferry che parte per le isole Bijagos. Quando c’è acqua a sufficienza il battello va, più di questo è stato impossibile sapere.
In effetti, sono tornato in momenti diversi della giornata a scrutare la gettata di fanghiglia giallastra che fin sotto i pontili malmessi si stendeva a partire dall’orizzonte. Ho guardato e riguardato questa pittura marcia a tono giallo-ocra punteggiata dalle pozzanghere di mare intrappolate tra piccoli argini provvisori di una materia indefinibile, davanti a me, ho fatto fatica a immaginare le isole, e anche un po’ a respirare.
Le grandi piroghe da pesca mezze seppellite nello sconfinato pantano, la lugubre sagoma di ferraglie arrugginite di un porto che chiude la baia, non si riesce a trovare un angolo che sollevi lo sguardo in quella fatiscente capitale di una nazione poco più che trentenne, una delle ultime afriche a ottenere l’indipendenza.
Al consolato di Guinea, ospitato in una stanzetta di un’altra ambasciata africana, un modesto funzionario m’aveva rassicurato, quasi scusandosi: girare il paese non presentava alcun reale problema, contrariamente a quanto riportato dal sito ufficiale del ministero degli esteri italiano. L’anno prima, soltanto, c’era stato un piccolo golpe militare, ma non s’era sparato tanto, avevano solo deposto il vecchio presidente ubriacone. Nessun reale problema, quindi, a ribadire il concetto.
Il problema non è affatto reale, infatti, nessuno m’ha dato fastidio quaggiù, ed è proprio questo il punto, le persone sembrano vivere un’esistenza retrocessa, un’umanità silenziosa e sfumata che si muove in un quasi soppiatto lungo i larghi viali derelitti del vecchio centro coloniale in disfacimento. Il problema, se ce ne fosse uno, sarebbe filosofico.
Se c’è un motivo valido per arrivare fin quaggiù, in una realtà africana moribonda, laterale, che non gode nemmeno dei casuali riflettori di qualche sporadica indignazione occidentale. A poche centinaia di chilometri da qui, in Liberia e Sierra Leone, si continuano ad addestrare i bambini soldato.
Nella onirica Bissau, un po’ di vita la trovi lungo il marciapiede divelto che dà accesso all’unico internet point della città, dove lunghe teorie di cittadini intorpiditi si accalcano finalmente in uno spazio lineare esiguo. La fila più corta serve a prenotare il proprio turno di visita alla Rete, quella più lunga ad attendere che i collegati presenti finiscano di sforare la loro finestra temporale dedicata e lascino libera di nuovo la postazione del computer.

Si sopravvive come ovunque, nel terzo e quarto mondo. La vita si sposta altrove, restano a casa i cimiteri delle presenze, le mani protese, le ricevute dei pochi denari che viaggiano da banco a banco, le file interminabili che riconnettono gli affetti scomodamente, ma a prezzo ragionevole, tra server e server.
Solo dieci paesi al mondo producono meno pro capite della Guinea Bissau. I trasporti pubblici non esistono, la gente si organizza con ciò che di marciante gli riesce di trovare lungo il percorso. Nell’anticamera di nessun cervello appare un concetto superfluo come quello del turismo, nessuno si cura della mia presenza, non ci sono mendicanti in giro ma parecchi locali ne hanno il dolorante aspetto.
Non c’è nemmeno il sorriso della semplicità spontanea, quel po’ di africa cartolina che solleva appena, cammino nel centro di vuote strade polverose come all’oscuro di ognuno. Vado a sedermi al bar più probabile di Bissau, in Praça Che Guevara.
Ai tavolini intorno si affollano quella decina di europei che lavorano in zona per le ONG nei progetti di cooperazione.
Con scatti leggeri sollevano in aria gli aperitivi, con mani nervose afferrano pugni di noccioline annerite. A voce alta, altissima, si chiamano e sorridono tra di loro e dichiarano enfaticamente le carte in qualche gioco di scale provvisorie.
La cameriera scura fa un mezzo gesto di scusa e mi indica un unico tavolo possibile occupato da un francese con una camicia hawaiana che grida vendetta. Saluto cortesemente e mi accomodo, almeno un minuto o due, forse, poi la tristezza specifica di questa comunissima faccia d’oltralpe mi morde la coscienza. E’ così che mi rialzo improvvisamente in piedi.
I venditori di ammennicoli, simili a statue di mogano invalicabili, presidiano senza sosta il perimetro esterno del bar. I taxi Mercedes barriscono inutilmente a caccia di clienti, mentre girano ossessivamente l’ovale della polverosa piazza. Una puttana giovane, raffinata e molto carina, si aggira sorridendo tra i tavolini cercando di scacciare la morte volatile dalle spalle crollate degli europei.
Do un ultimo sguardo intorno, e sto quasi per sorridere di rimando, vivaddio, perché no. Si tratterebbe solo di cooperazione bilaterale, in fondo.
West Africa, Bissau, ore 13e10. E’ ora di tornare a Dakar.
A. G.
Dakar

foto di Franco Visintainer
Dakar, la più europeizzata delle città africane, circa 5 milioni di abitanti distribuiti su una penisola interminabile, è una sorta di allucinazione reticolare, un immenso tessuto senza inizio né fine, se non i contorni irregolari delle coste, che sfumano nella luce estatica dell’oceano: una specie di tenebra luminosa che avvolge l’allucinazione.
L’immenso reticolo che ricopre compattamente la terra rossa e umorosa della brousse, è formato da cellule umane avvolte nel triplice guscio degli abiti, delle auto e delle case. Come nella nube quantica, nel web e nel sistema nervoso, i punti della rete fluttuano freneticamente da un ganglio all’altro: gli uomini dentro o fuori della capsula di lamiera, attraverso i nodi di scambio delle case o i macrogangli dei mercati, o collegati fra loro dalla fittissima rete di fatiscenti telecentre o portable della Vodafone. Gli uomini mutuano incessantemente il loro posto fisico e psichico, le loro informazioni e esperienze, il loro denaro e i loro beni. Scambiano e commerciano tutto, anche i loro stati psichici, ovvero quello che chiamiamo anima, ma poiché hanno un senso della proprietà poco accentuato, non la perdono, come accade in occidente. Il loro commercio è dunque essenzialmente una forma della comunicazione, filosofia che si giustifica nella figura di Maometto, commerciante oltre che mediatore fra umano e divino.
Il 62% del Pil senegalese è prodotto dallo scambio, cioè dal commercio e le telecomunicazioni, ma il problema è che attraverso questo scambio qui si scambia il nulla. Il Senegal infatti importa tutto e non produce nulla: produce pulsazioni: un grande battito che si irradia fra la terra e il mare. Nello stesso modo non producono nulla (il reddito pro-capite è estremamente basso) e non sembrano perseguire una finalità precisa le singole cellule del sistema: per una legge strutturale, infatti, maggiori sono le dimensioni e la densità del sistema, minori sono il valore e la libertà d’azione individuali. Gli uomini agiscono in base a un impulso impersonale e indeterminato: sopravvivere, e far sopravvivere il sistema. Ciò spiega e determina anche la grande capacità comunicativa di queste popolazioni, l’empatia e simpatia e quel senso di accorata, intima solidarietà – flebile e depotenziato nelle nostre razze – che coinvolge e commuove il visitatore di queste zone.
L’allucinazione del sacro
La capsula ermetica, il grande “emboutillage” umano che è Dakar, ha solo un punto di comunicazione con l’esterno: la preghiera: 5 bocche di deflusso, in 5 determinate ore del giorno, in cui i dakarensi, nelle moschee, in stanzette dedicate, o dovunque riescano a stendere un tappetino, con una devozione e uno zelo ben maggiore di quello di noi occidentali, entrano in contatto con ciò che non comprendono. Posto che la religione sia davvero un legame fra l’umano e il non umano, il che è ancora più dubbio nel caso di umani particolarmente umani come gli africani. Qui la funzione coesiva e sociale della religione si manifesta infatti con particolare evidenza, le feste e i matrimoni sono eventi collettivi che accomunano nella frenesia della danza e della preghiera tutta la comunità, le foto dei marabut, rigorosamente stinte dal sole, sono attaccate ovunque, e i loro lunghi discorsi vengono diffusi di continuo dalla tv nazionale e ascoltati con grave attenzione. E tuttavia se il sacrificio, il dispendio, rappresenta la componente propriamente mistica e sacrale della religiosità, anche questo carattere è qui più forte che altrove. Se le rigorose interdizioni (alimentari, sessuali, economiche) e regole musulmane (che nel pacifico Senegal non assumono mai la forma del fanatismo) fossero finalizzate, come nell’antipodica etica protestante, alla produzione e all’efficienza, se il culto di Allah integrasse in sé quello del lavoro, o almeno lo contemplasse, lo sviluppo non avrebbe assunto le forme dell’inviluppo, del viluppo che soffoca e irretisce questa megalopoli. L’allucinazione reticolare di Dakar è dunque anche l’immagine dell’umano sospeso nell’indeterminato, della vita che agisce nell’inconoscibile.
L’allucinazione tecnologica

Qui insomma il tecnologismo e il consumismo occidentale si sono andati a sovrapporre violentemente e discontinuamente a una cultura arcaica, generando una sorta di tribalismo tecnologico, di tecnologismo istintuale. Arrivano le auto, i cellulari, le mitologie televisive, ma continuano a colonizzare, in forma meno cruenta ma più strisciante e insidiosa, un tessuto che non ha avuto il tempo di strutturare difese e anticorpi culturali, attecchiscono su psichi irriflessive, che ne vengono spesso devastate, o li metabolizzano in una forma confusa e instabile, una forma estremamente dinamica, ma che in ogni caso porta con sé tutti i deterioramenti e impurità dell’imitazione. Senghor è stato un “grande” presidente (guida dell’indipendenza nel 1960, più volte candidato e inspiegabilmente privato del Nobel per la letteratura) perchè è stato uno dei teorici della negritudine e della riscoperta delle radici territoriali. Eppure si ha talvolta la preoccupante impressione che perfino quello di Natura sia una categoria “bianca”, importata, o tout court un artefatto che i neri potrebbero rifiutare.
Da una parte bisogna ovviamente considerare la relatività del concetto di natura. Nel quartiere di Wakhinane fotografo degli splendidi aironi bianchi, che nidificano liberamente sui rari alberi, e spiego ai bambini che mi accompagnano che mi piace fotografare “les oiseaux”. Mi fanno capire che hanno degli uccelli molto migliori, e li seguo in una catapecchia maleodorante di pesce essiccato. Nella semioscurità, con gli sguardi luccicanti di orgoglio, mi mostrano il tesoro di 4 galline spelacchiate e starnazzanti. Mi viene in mente che la nostra più preziosa rivista di ambientalismo si chiama Airone, e che qui forse gli preferirebbero un nome come Gallina. Forse non avrebbero torto, un airone è infine una gallina stinta, nasuta e col collo curvo.
Oppure la verità è un’altra, e cioè che l’africano è un sincretista, assimila, mescola, centrifuga, secondo una modalità che è infine squisitamente culturale, e proprio in virtù della quale, insieme a una serie di comportamenti che a noi possono apparire spuri o kitsch, ha elaborato nel tempo ciò che chiamiamo negritudine o identità culturale africana. Alcuni studiosi di colore sono arrivati peraltro a considerare lo stesso relativismo di matrice antropologica, che vorrebbe salvaguardare i caratteri etnici di questi popoli, come un’ennesima ideologia di sopraffazione, finalizzata a confinare le culture africane in un presunto primitivismo, e incapace di riconoscere la dinamicità della loro nuova realtà.

Qui siamo vicini alle radici biologiche e culturali dell’uomo, e ogni fenomeno psichico si manifesta nella sua forma più pura, intensa e disinteressata. Se l’Africa è un’immagine altamente probabile del nostro futuro, è perché è da questo centro che si è irradiata la nostra specie, ed è qui che, grazie alla nuova velocità di scambio informativo del mondo globalizzato, la tecnologia di ritorno potrebbe assumere le sue caratteristiche definitive e più propriamente umane. Dopo le mutazioni che milioni di anni fa hanno prodotto la nostra variante depigmentata e esangue, fisicamente degenerata, l’africano ha ora la possibilità di riappropriarsi del mondo, o solo, speriamo dal nostro punto di vista, della propria funzione e identità.
L. B.