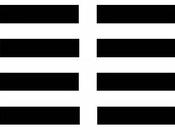Fine agosto. Una di quelle giornate che volgono al termine troppo in fretta, perché spinta dai cicli solari che vanno a ritirarsi, e la luce viene via prima che tu possa renderti conto che è già ora di tornare a casa.
Sei rimasta sola sulla spiaggia, scorgi in lontananza gli ombrelloni chiusi dai bagnini, senza poesia, genitori che raccolgono palette e secchielli dei loro figli, due ragazzi che giocano a pallone, altri due che si stringono sul lettino, ipnotici e belli.
Afferro gli occhiali da sole, indosso la mia camicia di lino maschile, infilo i sandali e prendo la borsa. Il mare accompagna le mie gesta con il suo muoversi discreto e perpetuo, come una musica che proviene dall’ultima sfumatura all’estremo largo di tutti i miei pensieri, che tremano all’orizzonte.
In quel preciso istante decido di non dirigere la mia scassatissima macchina verso casa ma portarla in un altro posto.
Non ricordavo di quanto fosse strano vedere le stradine che mi guidavano all’altro mare, il mio, segnate solo da numeri, come se i nomi fossero di colpo superflui e che certi luoghi non necessitano tanto di etichette, quanto renderli conoscibili e nutrirli di tutta la fila di ricordi che accompagnano il nostro vissuto.
Strada n. 12. Proseguo con cautela, come si prosegue quando il cemento è venuto via perché contagiato da una sabbia sottile e incisiva che l’ha reso fragile e sferrato.
Intorno silenzio e tapparelle abbassate, nuovi volti che si aprono ai miei occhi, ancora un tuffo nelle rimembranze di una gioventù dai colori di seppia, in cui eri minuta e innocente, discola e in perenne fremito, dai boccoli ribelli e dal sorriso di perla.
Parcheggio adiacente al muretto, intravedo le prime luci di un tramonto che odora di Giappone ma che si scaglia dietro le dune che assumono le vesti dell’ombra che il sole dormiente va a ricreare. Una pace dal piglio sofisticato e un vento regolare di tramontana, danzano sopra la mia fronte.
Ci siamo, riesco a vederla appena, procedo affondando i piedi privi di sandali che catturano il bianco manto di una sabbia avorio, sporcata qui e là da mozziconi di sigaretta e alghe in superficie.
Dialogare con il mare è anche prendere confidenza e agio con la sua pelle, con la sabbia e poi con l’acqua, ma prima ancora con la sabbia, che battezza il tuo sodalizio emotivo con lui.
Il mare, perché è la sostanza di cui io e te siamo fatti. Apparteniamo entrambi a lui, siamo nati distanti e complici e permeabili alla sua dolce potenza, alla sua instabilità sfacciata, alla calma apparente che ci regala di continuo.
Il mare ci ha fatto conoscere. Nel mio viaggio in Grecia, una vita addietro, hai incrociato il tuo sguardo su di me, mi hai vista, e io non sapevo nulla di te, se non vaghe reminiscenze di altri incontri fuggiaschi nei freddi dintorni cittadini.
Posasti i tuoi occhi sui miei e io non li ho catturati abbastanza da portarli con me.
Il mare ci accomuna e ci rende saldi.
Anni dopo ci siamo ritrovati, ed è stato come un accadimento inevitabile, come se un fato romantico e dispettoso avesse spinto affinchè potessi meglio rubare quegli occhi che ti ho negato in quel tempo, in cui avevo il cuore altrove.
Siamo andati avanti così, a cercarci ma con timidi distacchi, come a non voler fare troppo rumore mentre i passi dei nostri istinti più insensati tuonava per noi, senza controllo che frenasse la corsa.
Due vite posate di fronte, io con la mia esistenza sbagliata e frenetica, tu con i tuoi amori mancati e le tue inquietudini glicemiche, di un’innocenza tale da rendermi inerme quando tentavo di scalare i tuoi silenzi cadenzati e le tue parole servite come centesimi sparsi, da raccogliere e riporre in ordine.
Due vite come due linee allo specchio, senza sfiorarsi mai, ma con l’energia della tentazione che pervade e ci fa avanzare ma tenendoci per lo sterno e impedendo a entrambi di varcare il confine.
Mi fermo a pochi metri dal ciglio dell’acqua. Come un compasso ridisegno la curva che segna la riva e abbraccio quella visione perfetta e definita.
Di fronte si aprono le barche lasciate ammollo, coperte e sognanti, che delimitano il punto in cui si fermava il mio pregresso nuotare, come se quel bacino di mare volesse catturare ogni mia voglia di scappare via, perdermi oltre.
Stendo il telo e mi siedo. Sono sola e non mi curo delle poche persone che condividono con me questo quadro eterno, a fotografare una bellezza su cui ognuno posa il suo personale afflato, come carta pregna di parole necessarie, mentre una storia sta per essere scritta perché diventi più reale, meno sulfurea.
Sei incastonato tra le ciglia della mia mente, ho fatto scorrere rimmel d’inchiostro per fermarti, tenerti stretto, anche se chiuso e inconsistente tra i miei sogni così nitidi e reali, ma sempre sogni, mentre tu eri preso a pianificare i tuoi giorni con una donna che non ero io, a proliferare sbagli e speranze di neve, vestendoti di cappotti di freddo e malinconia.
E io ti guardavo incespicare e rialzarti, e mettevo a tacere ogni mia spinta compulsiva e tesa a sciogliere quel gelo in cambio di calore e sorrisi, di mutati copioni e abbracci veri, per riportarti dove tu avresti capito, perché corriamo simili su biciclette di spighe e terra, rotolandoci esausti e felici senza disturbi né cieli neri, senza chiederci il perché delle cose, amandoci e basta, perché è quello che riesce meglio, a noi due.
Sono rimasta in attesa per un tempo lunghissimo, passiva e in perenne potenza di compiere qualche gesto che avesse un senso vero, scuoterti il cuore e rendermi visibile, riconoscerti, come colui che desidero e che non voglio lasciare andare.
Ma accade anche questo. Accade che si ha paura di rovinare quello di cui tendiamo ad accontentarci, per non sprofondare in un quasi nulla assordante, a racimolare briciole di emozioni, senza capire quanto siamo lontani da macinare felicità, da provare a salvarci. Non ho provato fino in fondo a dirti chi sono, e a dirti, ti porterò con me, con il suono commosso proveniente da un’anima sensibilmente pizzicata come un contrabbasso in rovere, baritonale ed elegante.
Sublime.
Guardo il mare. Immobile, come quella volta in cui non ho sopportato la visione di te abbracciato all’ennesimo satellite che facevi ruotare intorno alle tue spalle perfette, e io immobile che ingoiavo un vino amaro e pesante, mentre trattenevo un pianto puerile e inevitabile, e fingevo un orgoglio da dea si, ma di false illusioni.
Capisci di amare una persona solo quando percepisci che non sei più tu a gestire i metri che segnano le vostre distanze, non sei l’architetto di quel piano scosceso che vi tiene insieme e in equilibrio, quel piano s’inclina e il tuo amore scivola sgraziato, veloce fugge come si fugge da un temporale repentino e violento, il tuo amore non viaggia sulla tua linea celeste, è sceso dall’asta e cambia direzione.
Li ti accorgi di amare, di non sopportare la carne lacerata dall’assenza e dalla consapevolezza di come andranno persi, da li in poi, tutti quei progetti di quotidiano vivere insieme, legati come rami di pesco e tutte le risate, il sesso, il cibo, i passi, le notti, che saresti andata a costruire insieme, non esisteranno mai. Per sempre mai.
Sarebbe stato tutto più facile se ti avessi lasciato la chiave che apre la porta tra il mio dire e il mio volere e ti avessi dato la libertà giusta per farti un giro e scoprire da solo, quanto amore sei riuscito a catalizzare senza che me ne rendessi conto abbastanza. In grado, tu, da subito, di sconvolgere ogni mia stabilità così a fatica conquistata, quella serenità meschina di chi non si getta a pieno nelle cose e guarda la vita arrampicata ai bordi del mondo, chi si mette da parte per un’ipocrita scelta di arginare sofferenza. E soffri allo stesso modo, un modo subdolo e incisivo, come piccoli rovi che carezzano la pelle, costanti e insopportabili.
Quante volte avrei voluto chiamarti “amore”, in tutte quelle parole che ho fatto filtrare fino a te, in tutti quegli orrendi codici criptati di reticenza e pudore, gonfi di paura e stupidità, mentre sono stata capace solo di posare sul tuo capo inconsapevole la mia corona di rimpianti.
I rimpianti, mangiano la carne e scorticano le ossa, nel loro puntuale banchetto macabro in un obitorio qualsiasi dei nostri tanti “vorrei”.
Vorrei…vorrei che tu vedessi questo posto dove mi trovo ora, che potessi vedere la mia spiaggia e il suo carico di meraviglia, di purezza, di mare immenso.
Ricordo di averti parlato di questo angolo di bellezza, tutto mio, mentre condividevamo una corsa in motorino, contatto involontario che volevo fissare e rendere immortale. Parlavo come parlano certe onde, lente e chiuse, e parlavo al tuo orecchio come se fosse una conchiglia di seta e salsedine, amplificata sul mio petto.
Siamo come il mare io e te. Rincorriamo il tempo, ci ritiriamo a modo nostro, ci sporchiamo dei colori del cobalto e rinasciamo con le trasparenze degli smeraldi più vivi. Conteniamo ogni sensazione mai descritta, lottiamo con il vento e ci perdiamo tra le braccia della luna riflessa. Godiamo di un’immortalità bagnata e ci facciamo attraversare da tutta l’umanità che ci sceglie.
Siamo nostalgici e vitali, siamo dentro il mare, amore mio.
E tu continui a sostare dentro di me, ricordandomi quanto la paura mi abbia fregata e quanto la tua cecità mi abbia sconfitta.
Avrei dovuto liberarmi dal terrore di non poterti avere e svelarmi senza il cruccio di ricevere un tuo diniego. Ma avrei voluto che tu scoprissi i tuoi fari candidi, che togliessi la benda dalle tue stanche iridi e guardarmi per quella che sono sempre stata, pervasa da te.
Il silenzio è calato. Le luci iniziano a macchiare un cielo ovattato dalle strisce di luce violacea che dipingono i confini e danno il benvenuto alla catartica sera.
Un ultimo saluto carico del mio più acuto palpito cardiaco…verso il mare.
Il mare è come te, senza una fine