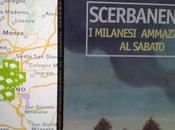FUORI STRADA – Rubrica di approfondimento della piccola e media editoria “extra-capitolina”: intervista a Emanuele Tonon, autore di La luce prima e Il nemico
Di lei, in realtà, si conosce già molto dai suoi libri e dalle interviste che ha rilasciato. È nato a Napoli nel 1970, vive in provincia di Gorizia, ha fatto l’operaio e il frate francescano, è uno scrittore. Si è anche definito «saltimbanco del lavoro». Può partire da qui per provare a tracciare un suo profilo, magari ancora inedito?
Vivo in campagna, mi sveglio alle cinque, leggo, scrivo, faccio lavori saltuari nei campi e negli allevamenti di bestiame per mettere insieme il pranzo con la cena, dallo scorso settembre ho girato un po’ tutta l’Italia, invitato a parlare de La luce prima. Solo da poco ho ritrovato un minimo di quiete, una apparente stanzialità. Mi divido, quindi, tra anacoretismo e pellegrinaggio. Non sono ancora morto.
I suoi libri sono intrisi di teologia. Il Nemico nasce come dittico di un’opera trinitaria, con l’intento di utilizzare le tre Persone della Trinità cattolica, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Poi è intervenuta la morte di sua madre e ha scritto La luce prima, un canto di dolore e di amore e, come lei ha affermato, non era questo il libro che avrebbe dovuto concludere la sua trinità. Ma anche in questo la presenza di Dio, anche se di un Dio senza amore che non sembra voler salvare nessuno, è ricorrente. Può spiegarci il suo rapporto con Dio? Che cosa è successo e che cosa sta ancora succedendo con la sua fede?
No, il Dio che immagino nella mia trinità è un Dio d’assoluto amore. Ma di assoluta impotenza nei confronti della sua creazione tutta sbagliata. La fede religiosa, l’immaginario ad essa legato, è una rivolta contro questo mondo farcito di dolore e ingiustizia. Immagino un Dio che nulla può e che avrebbe da essere amato per questa sua impotenza, per il solo amore del suo amore disarmato. Il mio è un Dio-Nulla, un Dio-Vuoto, un Dio che si manifesta solo nella luce dell’estasi, nella tensione del mistico che questo Dio lo ha ucciso per troppo amore e troppa disperazione. Il mistico deve resuscitare il cadavere di Dio, nella luce dell’estasi. Il mio è un Dio sconfitto, come scrive Sergio Quinzio nel finale di quel tremendo libretto che lessi da novizio francescano, e che rileggo in continuazione, quasi a volerlo mandare a memoria, La sconfitta di Dio: «Allo Spirito di Dio che è in noi – fiato, vento che «spira dove vuole» (Gv 3, 
La contraddizione che metto in scena nel mio fare letterario è tutta nell’umanissimo bisogno di consolazione e di salvazione. E’ in questa contraddizione che sale la temperatura, che tutto entra nel crogiuolo. E’ qui che metto in scena la “figura” del Figlio, del Cristo che è l’uomo dei dolori, il “servo sofferente”. Utilizzo l’immaginario religioso come allegoria. La perdita della fede, nei miei libri, non sta per perdita di un immaginario fondamentale come quello religioso. La mia fede non è cambiata: credo che attraverseremo il limite, prima o poi.
In La luce prima ciò che risalta, tra molto altro, è la ricorrente, quasi ossessiva dichiarazione di colpa. Perché si è sentito colpevole della morte di sua madre, perché giunge alla conclusione (come è accaduto anche in Il Nemico) che il figlio (lei) sia appunto il nemico? Esiste solo questa interpretazione dell’esistenza, un continuo duetto tra peccato e senso di colpa, quindi espiazione?
Io sono il nemico perché sono il figlio. E tutti siamo figli. Non ho titolato il mio romanzo con la enne maiuscola: non Il Nemico ma Il nemico. È proprio così che cerco di andare oltre la dinamica del capro espiatorio, richiamando, dopo il delirio delle sociologie d’accatto, alla responsabilità individuale. Nel mio libro non c’è peccato e non c’è senso di colpa. Se lo si vuole vedere per forza, il senso di colpa, non posso farci nulla. Ne La luce prima mi porto, filosoficamente, all’origine, al contatto tra libertà e nulla. La libertà è energia creatrice e benefica ma anche forza letale distruttiva. La libertà può essere positiva solo se ha conosciuto la negazione, quindi il male e il nulla, e ha sgominato il male e il nulla. La madre povera che genera il figlio ha sgominato il male, nella sua libertà positiva. Il figlio si fa carico di questa energia devastante che lo ha posto sulla scena del mondo. Ora sta a lui esercitare la libertà come arricchimento ontologico o come forza annientatrice. Responsabilità e irresponsabilità, scelta e consapevolezza, non senso di colpa. Nel mio libro non dico che sono colpevole della morte di mia madre: dico solo che avrei dovuto baciarla di più, accarezzarla di più, portare a compimento i suoi piccoli sogni. E che non ci sono riuscito. Io, il figlio, l’io narrante che parla alla madre non-personaggio, non sto ad indicare la colpa ma sto ad indicare la responsabilità individuale che viene prima di ogni astrazione. Ovviamente, ho scritto La luce prima in un periodo di totale sbilanciamento emotivo. Avrei potuto tornare su quanto scritto, dopo i tentativi di elaborazione del lutto, ma, facendolo, avrei dovuto scrivere un altro libro, mi sarei prostituito, avrei rinnegato la memoria che stavo consegnando alla letteratura. La Luce prima è un canto d’amore che ho cantato in lacrime per Vincenza Pucci, la mia mamma piccola e povera che ha attraversato questo mondo con poche parole e una ridda di gesti di dedizione, sacrificio e tenerezza. Un canto che ho voluto far diventare letteratura. Poi, ognuno ne tragga quel che vuole.
Ha definito la sua scrittura «una scrittura di voce». Che cosa significa esattamente? Tale definizione implica l’esistenza di altri tipi di scrittura? Se sì, quali sono?
Ci sono le scritture epigonali, quelle storielle fritte nell’olio sfinito, dette e ridette, fatte e strafatte. La postletteratura. Ormai metti in mano una storia ad un editor decente e ti tira fuori un “romanzo”. E’ spesso solo un giuoco per rendere i libri come un Big Mac: deve avere lo stesso sopore a New York come a Roma. La “voce” è altra cosa, è unica, è un piatto tipico, locale, fatto in casa. La “voce” è quanto ti permette di dire, leggendo una frase “questo lo ha scritto Pinco Pallino”, senza altri riferimenti oltre la frase. La “voce” è unica. La voce è sempre periferica, nasce da una profonda solitudine spirituale e geografica, non è mai prodotto di bitter con le olive nei bar del centro. Piace o non piace, non ha vie di mezzo, come è giusto che sia. Infine, piacere a tutti è come piacere a nessuno.
Dice che La luce prima è il frutto di un’urgenza. Ha anche detto che ha impiegato circa tre giorni per finirlo, scrivendolo tutto d’un fiato, in modo quasi compulsivo. Come scrive invece di solito?
Un amico poeta, Antonio D’Agostino, mi mandò, qualche tempo fa, una sua poesia che comincia così: «Scrivo in condizione di tempesta …». Scrivo così, in condizione di tempesta, da sempre. Non ho mai detto che ho impiegato tre giorni per finirlo. Ho detto che per tre giorni e tre notti ho devastato una tastiera, in uno stato di trance. E poi: ogni scrittura letteraria ha da essere frutto di un’urgenza. Ho scritto Il nemico in otto anni, ma era frutto di un’urgenza. Sto scrivendo un romanzo da cinque anni, anch’esso frutto di un’urgenza continua. Si fa letteratura solo per urgenza. Ho impiegato tredici mesi, non tre giorni, per finirlo. L’incipit («Mi hai chiamato, prima di continuare a morire») l’ho appuntato sul taccuino il 23 giugno 2010, nella sala d’attesa di un Pronto Soccorso. Ho continuato ad appuntare frasi per tutti i nove giorni in cui mia madre è rimasta in coma, a elargirmi il suo magistero di silenzio. Quegli appunti mi hanno tenuto in vita, ora posso dirlo. Poi ho passato circa un mese di mutismo. Non riuscivo a parlare, a scrivere. Tutto è esploso, infine. Ho buttato giù, a partire dagli appunti, il grosso del libro, dividendolo idealmente in tre parti: infanzia, adolescenza, maturità e morte. Ho passate intere notti senza sonno. Mi sono ritrovato con un file di duecentoquarantadue pagine. Sono stato ospite in casa di amici per due settimane, nel dicembre 2010: lì ho rimosso le pagine di troppo. Ho dimezzato il libro, ho tolto il vomito, ho deciso di tacere alcune cose, ho addolcite verità altrimenti troppo amare, in un testo così, senza filtri. Ho cercato di restare nella misura del salmo, dell’epicedio, di “raccontare” il meno possibile. Son tornato a casa, ho passato il 31 dicembre 2010 da solo nella casa deserta, vociferando col fantasma di mia madre mentre scrivevo le ultime pagine, quelle dove il figlio invita la Madre a danzare. Nel mese di gennaio ho consegnata la prima stesura. Fino ad agosto 2011 è stato un continuo tornare sul testo, per sole minuzie, ripensamenti. Un tornare inesorabile, operato con implacabile determinazione. Sono arrivato a telefonare in casa editrice poche ore prima che il libro andasse in stampa, per far apportare l’ultima modifica.
Una questione di stile: nel brano estratto da La Luce prima e uscito sulla rivista Watt, usa le concordanze alla latina in maniera sistematica. È stato un esercizio di stile isolato, oppure quel modo di scrivere un po’ le appartiene?
Ho sempre scritto usando le concordanze “alla latina”. Anche ne Il nemico, nella mia versione, usavo le concordanze alla latina. È retaggio delle mie letture conventuali. Sembra sia cosa troppo complicata. A qualcuno non sta bene. Infatti mi si è installata una sorta di autocensura nel cervello; ormai mi ritrovo a scrivere a metà le concordanze, da quando ho esordito. Faccio confusione. Forse smetterò di usarle. Si tratta proprio di una questione musicale. Basti confrontare l’estratto che lei cita con la versione pubblicata: provi a leggerlo ad alta voce. Il ritmo, il suono, sono altra cosa, nella versione pubblicata in estratto. Forse fa comodo un linguaggio tendente a un esperanto minore, una languida melassa universale. Prenda questa cosa qui che è stata editata ne La luce prima, a mia insaputa. Me ne sono accorto alla prima presentazione, leggendo pubblicamente le pagine finali: «Come, da viva, mai hai voluto fare». Dunque, io avevo scritto: «Come, da viva, hai voluto fare mai». Non le pare brutto quel «mai hai»? è una pura questione di suono. Ma questi son preziosismi, dicono.
I suoi libri sono intrisi di realtà. Sono in gran parte autobiografici o prendono spunto dall’esistenza reale per affrontare temi che appartengono al quotidiano incedere dell’umanità. La letteratura, quindi, può essere strumento di verità o ennesima illusione?
I miei libri sono intrisi di realtà come il sonno di un oppiomane. Scriveva Salvatore Toma, poeta morto suicida che ci ha lasciato pochi versi terminali e assoluti: «C’è da chiedersi se la realtà / sono gli occhi / il naturale il tangibile / oppure lo sgambetto l’alcol / il perdono impossibile». Qualcuno mi ha destinato al genere autobiografico; invece, ho scritto di un resto di me, votato alla trasfigurazione. Ho scritto del resto di altri che hanno attraversato la mia vita. Ho cercato di costruire un romanzo tripartito, immaginandolo, mentre lo scrivevo, pubblicato in due volumi. Ho scritto un romanzo dell’amore paterno, uno dell’amore coniugale e uno dell’amore materno. La resa finale dovrebbe essere la lettura di quanto resta vivo dell’amore dopo l’esperienza sconvolgente della morte. Un trattato delle cose ultime. Le cito Manganelli, a proposito dell’autobiografia: «Mi viene in mente che la Chiesa con il sacramento della estrema unzione fa il tentativo di inventare un’autobiografia finale, alternativa a tutte le altre. Tenta di irrigidire un’autobiografia rispetto a tutte le altre, consacrandole. Questa è quella vera. Tu vai davanti a Dio con l’autobiografia timbrata dal Sacramento. Quindi la Chiesa è perfettamente consapevole che le autobiografie sono tante, che noi andiamo in giro con una quantità di autobiografie, e il suo tentativo finale è quello di farne esistere una sola. Tu muori, con un’autobiografia, l’ultima che ti viene scelta. L’unica che ti possa consentire il trapasso. Avere un’unica biografia consacrata: io commetto un delitto e lo ricordo, questa è una autobiografia; se lo ricordo e me ne pento, viene fuori un’altra autobiografia».
La letteratura è solo approssimazione alla verità, è una approssimazione al limite, un tentativo di sfondamento. La mia opera vorrebbe essere un trattato delle cose ultime, quelle che stanno al limite, appunto. La verità la si intravede solo nei pressi del limite, in quell’interregno tra la l’orrore e la felicità. Poi se ne va, oltre. La letteratura è quel tentativo disperato di vedere quell’oltre e raccontarlo.
Chi è per lei Antonio Moresco? Ne parla come «incarnazione della letteratura», «un padre e un fratello». Può spiegarci l’origine e l’evoluzione di questo incontro?
Quando mi invitano ai festival letterari, vedo la folla di persone in adorazione davanti ad autori che a me paiono cabarettisti incompiuti, e immagino un monstrum come Moresco che cammina, solo, di notte, per le strade di Milano, e la gente che lo guarda storto per il suo vestire dimesso, per la barba, mentre è un demiurgo, un creatore di mondi. Penso al culto catacombale cui è costretta la sua opera che invece è una cattedrale. Bisogna scendere nel buio, per trovare la luce della scrittura di Moresco. Bisogna aprire tombini, prendere confidenza coi topi e colle fogne. Ci siamo conosciuti semplicemente, come può capitare agli scrittori di conoscerci e di apprezzarsi. Di diventare amici, anche. Ci sentiamo ogni tanto al telefono, ridiamo tanto al telefono, ci incontriamo in giro per l’Italia, quando capita, un paio di volte sono stato a casa sua, saremmo dovuti andare insieme a Trieste ma ormai è difficile, non abito più in Friuli (però ci siamo promessi che prima di crepare riusciremo a passare una giornata insieme a Trieste). Ho stima sterminata per la sua coerenza, la coerenza di uno dei più grandi scrittori al mondo, che per vent’anni ha continuato a scrivere senza trovare sbocco editoriale. Avrebbe potuto prostituire la sua scrittura, in quei vent’anni. Invece no, ha continuato a tirare le sue staccate al limite, a entrare in curva senza paura della morte che arriva da dietro, sul collo, sulla schiena. Ma con profonda umiltà, pur nella sua implacabile determinazione. Moresco è maestro immenso, per me. E le parole dette a bassa voce che mi regala al telefono, o mentre beviamo una birra, o mentre camminiamo per le strade di una città qualunque, quelle parole per me sono la sola testimonianza diretta che ho della Letteratura. Quando mi è capitato di stare con lui in una libreria, ma anche in un bar, mi è capitato anche di pensare: sono qui con Dostoevskij e nessuno se ne avvede. Ecco, questo non avvedersene, mi ha data l’esatta misura di cosa sia questo mondo. Ma è giusto che sia così: lo scrittore è il folle, è l’errore. Non è l’intellettuale socialmente accettato e riverito. Non è il tronista o la velina. Ancora Manganelli: «Anarchica, la letteratura è dunque un’utopia; e come tale ininterrottamente si dissolve e si coagula. Come è proprio delle utopie, essa è infantile, irritante, sgomentevole. Scrivere letteratura non è un gesto sociale. Può trovare un pubblico: tuttavia, nella misura in cui è letteratura, esso non ne è che il provvisorio destinatario. Viene creata per lettori imprecisi, nascituri, destinati a non nascere, già nati e morti; anche, lettori impossibili. Non di rado, come il discorso dei dementi, presuppone l’assenza dei lettori. Di conseguenza, lo scrittore fatica a tenere il passo con gli eventi; come nelle vecchie comiche, ride e piange a sproposito. I suoi gesti sono goffi e clandestinamente esatti. Assai imperfetto è il suo colloquio con i contemporanei. È un fulmineo tardivo, i suoi discorsi sono inintelligibili a molti, a lui stesso. Allude ad eventi accaduti tra due secoli, che accadranno tre generazioni fa».
Ci sono altri riferimenti fondamentali per la sua formazione di scrittore?
I miei riferimenti sono le osterie, la povertà, la solitudine irredimibile, la vita che ti esce dalla pelle mentre ti fai devastare da un lavoro di fatica, i miei libri e i miei fumetti che intasano le case e le cantine dove transito e dove so che non potrò morire in pace. I vecchi manicomi. La grande musica. Il sogno del cinema, quello, vero, antico, quello che potevo vedere con stupore, nell’innocenza, prima di facebook, prima di questo tempo ultimo. Null’altro.
I suoi libri sono pubblicati da Isbn. Come è arrivato a questa casa editrice? Ha inviato casualmente i manoscritti, ha seguito il consiglio di qualcuno, è stato scoperto da loro?
Nella mia vita non ho mai seguito consigli. Forse questo è il motivo delle pezze al culo che porto in giro per il mondo. L’anarchia è la mia libertà e la mia gioia. L’unica autorità di cui godo è quella di non averne alcuna, di perdermi mentre scrivo. Ho mandato il manoscritto in formato digitale solo a Isbn perché mi facevano impazzire le bordature rosse da breviario dei loro libri che avevo visti in libreria. Sono stato un frate e il breviario, per un frate, è come la persona perdutamente amata, quella che è sparita condannandoti a restare vivo, a maledirla e invocarla. C’era, in me, questa fascinazione puramente estetica per i libri di Isbn che vedevo esposti in libreria. Comprai qualche titolo Isbn, il primo fu Uomini e canidi Omar di Monopoli, che mi conquistò. Poi fu la volta di Trilobiti di Breece D’J Pancake: una folgorazione. Mandai il manoscritto solo a loro, in formato elettronico. Solo e unicamente a loro. Fui tentato di mandarlo anche a un’altra casa editrice ma, aprendo il loro sito, mi ritrovai davanti alla supplica di non inviare manoscritti. Cosa buffa: per La luce prima, ci fu una proposta da parte di quella casa editrice. Altre case editrici mi cercarono ma Isbn mi blindò, promettendomi odalische, ostriche e la vita eterna. Insomma, mandai il mio libro alla Isbn – libro che stava da quattro anni, fatto e finito, nel mio hard disk -, al termine della lettura di Lettere a Nessuno di Antonio Moresco. Mi era capitato di mettermi a piangere leggendo il finale: «Ho trovato un posticino segreto dove scomparire. Di notte si vede il firmamento. Mi sono comperato un telescopio, per essergli più vicino e scomparirgli dentro. Scriverò lì quell’ultima cosa che ho in mente, se non crepo prima. Poi basta. Nonostante tutto, in questa disperazione e in questo orrore riesco ancora a incontrare di tanto in tanto dei piccoli momenti di gioia, che nessuno mi può rubare. Il mio ultimo sogno è che venga finalmente il giorno in cui mi dimenticherò persino di essere stato, un tempo, uno scrittore». Era un libro, il mio, di cui provavo vergogna. Non avevo il coraggio di mandarlo a nessuno. Nel 2002 mi era stato categoricamente stroncato un romanzo da uno scrittore (neIl nemico ci sono molte pagine tratte da quel romanzo abortito). La notte stessa, dopo quelle lacrime, mandai il mio testo in formato elettronico alla Isbn. Un mese dopo mi contattarono e Il nemico uscì nove mesi dopo l’invio.
Ha detto che prima di immergersi nella scrittura de La luce prima aveva quasi concluso Cosa vogliono i morti, il romanzo che nei suoi progetti iniziali doveva essere la terza parte della sua trinità. A che punto è ora quel libro e quale sarà il suo posto nella sua opera?
Quel libro è qui, aperto in un altro file di Word mentre le sto rispondendo. È un viaggio iniziatico, sette vite che si incrociano, un road movie sciamanico, lisergico. Non posso sapere quale posto avrà nella mia opera. So solo che è qui, finito come le cose che stanno appena cominciando.
«Che cosa farai d’ora in poi? Che libri scriverai?», le chiede Antonio Moresco in quella bellissima lettera che le ha scritto. Può rispondergli e risponderci? Il prossimo libro che sta scrivendo o scriverà uscirà sempre con Isbn? Può darci qualche anticipazione?
Il mio prossimo libro uscirà in settembre, per Edizioni Biblioteca dell’Immagine. Faccio ritorno ai luoghi de Il nemico, però attraversati quarant’anni dopo. La malinconica resa di un uomo solo, davanti al suo bicchiere di vino. È un libro nato da una stretta di mano, come facevano i contadini silenziosi di una volta. Sto rivedendo altri testi di passaggio, alcuni scritti prima di esordire (ho scritto tanto prima di esordire, perché ero ancora innocente e non sapevo nulla delle dinamiche editoriali; sto cercando di disintossicarmi, di tornare a sapere nuovamente nulla. Voglio tornare a leggere i libri nella meraviglia, a scrivere come quando scrivevo senza nemmeno fantasticare uno sbocco editoriale.
Che tipo di lettore è? Che cosa in genere le fa apprezzare un libro? Cosa invece non le piace?
Apprezzo i libri dove c’è stile e sangue. Apprezzo gli scrittori che sanno guardare l’abisso, che ne fanno l’unico vero principio di conoscenza. Apprezzo le scritture inclassificabili, quelle che sfondano il genere romanzo. Apprezzo chi scrive per i morti, chi sente la riconoscenza e il debito verso chi ha scritto prima di lui, nutrendolo, dandogli parola, voce. Abbiamo bisogno dei morti per vivere e ne abbiamo per scrivere. Tutto il resto non mi interessa, semplicemente.
Dei suoi libri si è molto parlato. C’è qualcosa che non è stato detto secondo lei? O c’è qualcosa che le ha dato fastidio? Com’è il suo rapporto con la critica letteraria?
Vede, spesso è stato scritto che i miei libri sono urlo, bestemmia, preghiera, comunque il risultato di stati alterati di coscienza. Mentre credo che la mia scrittura sia sorvegliata, che il ritmo sia preciso, che ci sia una narrazione anche nella dinamica oracolare e apparentemente solo allucinata. Quando entri definitivamente nella morte capisci che qualunque commento o giudizio, sperperato nell’orrore normalizzato della massmedialità, è puro flatus vocis. La portata allegorica della mia opera, quella ancora non è stata detta fino in fondo. Mi pare sia venuta proprio meno la capacità di comprendere il simbolico e l’allegorico, da qualche decennio. Nei miei libri, ad esempio, il “nemico” è moltitudine. È di volta in volta persona, condizione sociale, stato di coscienza e delle cose. Per questo ci tengo a sottolineare che non ho utilizzato la enne maiuscola, che il mio nemico è nominato in minuscolo, nel titolo. Non è una finezza, è proprio tutto il senso della mia opera. Anche neLa luce prima la madre che era mia madre, la mia mamma piccola, diviene la madre Pellicano, la madre Costellazione, la madre Madonna invocata con i superlativi assoluti delle litanie mariane, la madre di tutti quelli che vogliono riconoscersi come figli. Per questo mi pare sciocco relegarmi alla sola autobiografia. Il mio rapporto con la critica letteraria non so cosa sia. La mia opera ci ha messo due anni e mezzo per arrivare sulle pagine culturali ufficiali, quasi fosse un errore, uno scarto, un’eccedenza, una malattia. Dopo la prima recensione sul Corriere della Sera, una delle ragazze dell’ufficio stampa della mia casa editrice, mi ha telefonato con l’entusiasmo che si prova davanti a qualcosa di straordinario. Abbiamo passato un’ora al telefono. Lei sembrava una miracolata di ritorno da Lourdes. Io un vecchio definitivamente spremuto dal mondo, quindi indifferente a quel tipo di miracoli. Il mondo culturale ha da funzionare così, dicono, come tutti i mondi lavorativi. Bisogna farsene ragione e continuare per la propria strada, senza farsi inebetire dalla frustrazione ma anzi trasformando la frustrazione in momento di crescita. So quale è, invece, il mio rapporto con la critica non ufficiale, so dei molti lettori che mi scrivono e mi regalano consolazione. È importante quello che sta suscitando La luce prima, che, ci tengo a precisarlo, è un testo anche feroce, che non si discosta dalla tensione de Il nemico, essendone la conclusione. La luce prima è un testo letterario, non è solo una memoria. La tenerezza non è consolatoria, non risparmio parole impudiche e impietose.
Ho scritto, sinora, quello che volevo scrivere, nessuno mi ha messo morso alla bocca, nessuno mi ha bacchettate le dita. Mi è concesso di raccontare il mondo ormai impossibile da raccontare, nella mia vita entrano queste schegge di luce, persone che all’improvviso mi diventano amiche, che mi invitano a casa loro e mi riempiono di anarchico amore, mi impediscono di morire disperato e solo a causa di quanto ho scritto. Non perché ho potere o successo o il soldo (spesso viaggio con cinque euro in tasca), ma solo ed esclusivamente per quanto ho scritto. Quello che mi differenzia da molti scrittori, è che non ho nulla da difendere. Se avessi a smettere di pubblicare domani, la mia vita non cambierebbe in nulla. Quello che dovevo dire l’ho detto ne Il nemico e ne La luce prima. Quello che verrà, se verrà, sarà solo un tornare su quanto già ho scritto per provare a spingermi più avanti, a salire, percorrendo, magari, altre strade. Non appartengo, grazie a Dio, al sindacato degli intellettuali, a quella invenzione umanistica. Non ho poltrone da difendere, non ho padroni da servire. Scrivo per desiderio, per urgenza e necessità, non per presidiare una fortezza di marzapane, non per lavoro e per il palcoscenico.
Che cosa fa Tonon quando non legge, non scrive e non lavora?
Tonon è stato molto amato: per questo pretende molto amore e ne fa continuamente le prove (in tutte le sue manifestazioni, rifiutando, però, quella struttura ideologica di potere chiamata “amore romantico”). Ha grande passione per l’epica motociclistica, quella sublime allegoria del limite cui approssimarsi che persegue in letteratura. Passeggia, raccoglie fiori ed erbe medicamentose, parla coi gatti e coi cani e gli uccelli e coi pesci e coi morti, principalmente. Ama la donna che lo ama. Ama i suoi amici, odia i suoi nemici e non conosce più il perdono. Sa che è impossibile la redenzione ma vuole solo essere redento. Un paio di giorni all’anno crede di essere felice. E gli bastano per continuare, finché riuscirà a credere che abbia senso continuare.