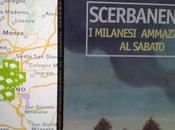Titolo: Gli indifferenti
Autore: Alberto Moravia
Anno: 1929 (Prima Edizione Originale)
Gli indifferenti costituisce il primo romanzo di un ancora poco più che ventenne Alberto Moravia, che lo pubblicò a proprie spese, nel 1929, presso la casa editrice Alpes.
L’opera si inserisce precocemente all’interno di quella corrente neorealista che troverà poi il suo massimo splendore negli anni successivi al secondo conflitto mondiale, grazie ad esponenti come Calvino, Pavese e Vittorini. Moravia non fu però il solo a dare un primo significativo contributo a tale movimento: accanto a lui si possono fare i nomi di Corrado Alvaro, che pubblicò Gente in Aspromonte solo un anno dopo l’uscita de Gli Indifferenti; Fontamara di Ignazio Silone vide invece la luce nel 1933; ed infine Tre Operai di Carlo Bernari fu invece pubblicato a Milano nel 1934. Opere, queste, accomunate da un profondo senso di aderenza alla realtà delle cose strettamente connesso alla voglia di dialogare con un pubblico sempre più vasto di lettori.
Il romanzo di Moravia è caratterizzato da un celebre incipit in medias res, che catapulta immediatamente il lettore all’interno del salotto della famiglia Ardengo, famiglia della borghesia romana, ormai in declino, composta dalla vedova Mariagrazia e dai suoi due figli, Carla e Michele. Accanto ad essi ruotano altri due personaggi: Leo Merumeci e Lisa. Il primo, uomo abbiente e dai dubbi costumi morali, è l’amante di Mariagrazia e successivamente anche della figlia Carla; la seconda, invece, è una giovane donna invaghita di Michele.
Il romanzo non può dunque definirsi corale, vista la scarsità dei personaggi che lo popolano, e non può nemmeno essere inserito all’interno del genere d’azione, dal momento che i dialoghi sono i veri protagonisti. Si potrebbe dunque forse parlare per Gli Indifferenti di «romanzo di costume», anche se la portata innovativa di tale opera è tale da renderla davvero unica e poco ascrivibile a un genere prestabilito. La stessa etichetta di «romanzo» è a dir poco limitante, a fronte di un’opera che potrebbe benissimo essere rappresentata all’interno di un teatro.
La scarsità d’azione fa dunque da contraltare alla grande attenzione che Moravia mostra nell’approfondimento psicologico dei suoi personaggi; la vita borghese nella sua routine, nei suoi giochi di finzione e nella sua apparente moralità viene smascherata e mostrata in tutta la sua cruda realtà.
Ciò che permette al lettore di approdare alla verità delle cose è proprio il sapiente rapporto che Moravia riesce a stabilire tra la vita verbale e quella riflessiva dei propri personaggi. Essi spesso dicono ciò che non pensano, fanno ciò che non vogliono e ma alla fine non possono che adeguarsi passivamente ad una vita che non vorrebbero vivere.
In particolare, vi sono personaggi, come Mariagrazia e come Leo, che hanno pienamente compreso i falsi meccanismi su cui si reggono le loro vite ma che, ciononostante, continuano ad aderirvi in pieno: “Come si fa?” disse la madre; “non si può mica dir sempre la verità in faccia alla gente…le convenzioni sociali obbligano spesso a fare tutto l’opposto di quel che si vorrebbe… se no chi sa dove si andrebbe a finire…”. Altri invece, come Carla e Michele, instaurano una lotta serrata contro il dramma da essi stesso recitato, uscendone però entrambi sconfitti e finendo per aderire essi stessi a quella trama di finzioni da cui invece vorrebbero uscire.
“… Dritta dietro la poltrona della madre, la fanciulla ricevette quell’occhiata inespressiva e pesante come un urto che fece crollare in pezzi il suo stupore di vetro; allora, per la prima volta, si accorse quanto vecchia, abituale e angosciosa fosse la scena che aveva davanti agli occhi: la madre e l’amante seduti in atteggiamento di conversazione l’uno in faccia all’altra; quell’ombra, quella lampada, quelle facce immobili e stupide, e lei stessa affabilmente appoggiata al dorso della poltrona per ascoltare e per parlare. “La vita non cambia”, pensò, “non vuol cambiare”. Avrebbe voluto gridare; abbassò le due mani e se le torse, là, contro il ventre, così forte che i polsi le si indolenzirono”.
E ancora:
“… Michele non si muoveva, non gli era mai accaduto di vedere la ridicolaggine confondersi a tal punto con la sincerità, la falsità con la verità; un imbarazzo odioso lo possedeva”.
L’impossibilità di essere veri e la necessità di dover recitare ciascuno la propria parte in un mondo di finzioni e di ipocrisie trova il suo culmine al termine del romanzo stesso dove, a chiudere la scena, non sono nemmeno i personaggi, ma le maschere da questi indossati.
Il finale aperto, inoltre, senza una piena risoluzione dell’intreccio, costituisce un ulteriore spunto di riflessione per il lettore, non più accompagnato dal narratore verso una piena comprensione del reale ma lasciato in balìa dei fatti, libero di trarne le proprie conclusioni.
Discesero la scala, l’uno accanto all’altra, il Pierrot bianco e la spagnuola nera; sul pianerottolo la madre fermò la figlia:
“Ricordati” le mormorò in un orecchio “di essere…come dire?...gentile con Pippo…Ci ho ripensato…forse ti ama…è un buon partito”.
“Non aver paura” rispose Carla seriamente.
Discesero la seconda rampa. Ora la madre sorrideva soddisfatta: pensava che anche l’amante sarebbe venuto al ballo, e pregustava una piacevole serata.