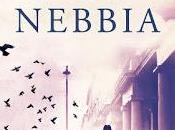Di norma sarebbe il contrario, ma ci sono casi rari in cui la letteratura si trova ad essere solo un’ispirazione per il cinema, un punto di partenza da cui scatenare il talento dell’arte visiva, amplificando l’effetto della parola scritta, che si discosta a volte, per regalare emozioni più grandi a chi si appresta ad ascoltare una storia che crede già vista e che in realtà quasi non conosce. Questo è il caso di Big Fish, un romanzo del 1998 che l’esordiente Daniel Wallace scrisse in memoria di suo padre, trasformato in un capolavoro assoluto dal talento di Tim Burton – dopo aver sfiorato Steven Spielberg – nel 2003, con un film omonimo girato proprio poco dopo la morte di entrambi i genitori, tra il 2000 e il 2002. Di fatto, tra le due opere, si potrebbe dire che un contatto avviene solo per le linee guida, più un soggetto base che una sceneggiatura, che Burton ha reso un’opera indimenticabile.
Di norma sarebbe il contrario, ma ci sono casi rari in cui la letteratura si trova ad essere solo un’ispirazione per il cinema, un punto di partenza da cui scatenare il talento dell’arte visiva, amplificando l’effetto della parola scritta, che si discosta a volte, per regalare emozioni più grandi a chi si appresta ad ascoltare una storia che crede già vista e che in realtà quasi non conosce. Questo è il caso di Big Fish, un romanzo del 1998 che l’esordiente Daniel Wallace scrisse in memoria di suo padre, trasformato in un capolavoro assoluto dal talento di Tim Burton – dopo aver sfiorato Steven Spielberg – nel 2003, con un film omonimo girato proprio poco dopo la morte di entrambi i genitori, tra il 2000 e il 2002. Di fatto, tra le due opere, si potrebbe dire che un contatto avviene solo per le linee guida, più un soggetto base che una sceneggiatura, che Burton ha reso un’opera indimenticabile.
“Il giorno in cui Edward Bloom nacque, venne la pioggia.”(Big Fish, Daniel Wallace, 1998, p. 14)
Big Fish è infatti la storia di Edward Bloom, un personaggio singolare, unico, che ha fatto della sua vita una favola, e non si riesce a comprendere fino a che punto questa sia un’affermazione da prendere in senso letterale o figurato. È lo stesso figlio, William, narratore del film, ad avvisarci: «In tellin' the story of my father's life, it's impossible to separate fact from fiction, the man from the myth. The best I can do is tell it the way he told me. It doesn't always make sense and most of it never happened... but that's what kinda story this is». Resta infatti un sentimento misto di meraviglia o, tra i più cinici, scetticismo per quanto raccontato dal figlio riguardo a ciò che suo padre ha compiuto nella sua esistenza, dato che ora si trova costretto a letto e in punto di morte. Ma se nel libro, spezzettato come una storia ad episodi, il figlio è un semplice narratore esterno che solo di rado fa percepire il disappunto verso suo padre, nel film il giovane William viene presentato sin da subito ostile a chi, secondo lui, per tutta la vita non ha fatto altro che raccontargli frottole e rubargli la scena in ogni occasione («You're like Santa Claus and the Easter Bunny combined - just as charmin', and just as fake»: affascinante, ma finto, appunto). Eppure la vita incredibile di Edward Bloom narrata da Wallace, fatta di barzellette e qualche evento straordinario, è quasi nulla rispetto a quello che Burton porta sul grande schermo, aprendo lo scrigno della sua immaginazione e lasciando libera l’immensità del suo immaginario, che lo spettatore non può che prendere come regalo per il suo film più luminoso esteriormente, ma non per questo meno cupo e malinconico. Lo hanno definito il suo film della maturità, forse perché, nonostante gli eventi narrati siano fuori dal comune, la storia segue un filo conduttore solido, molto più di quanto non faccia il romanzo, cui sono state donate una coesione e una forza altrimenti poco incisive. Nel film di Burton, Edward è magistralmente interpretato da Ewan McGregor, per le sequenze della gioventù, e soprattutto da un favoloso Albert Finney per ciò che riguarda la narrazione presente: due interpreti capaci di incarnare in pieno la positività, l’ottimismo e il fascino di Bloom, abile nel trovare in ogni episodio di vita un motivo di crescita, una spinta verso il futuro, un occhio ottimistico che non si spegne neanche nel letto di morte. In questo, la differenza con il libro è notevole, anche perché in generale il tono è molto più crudo, con immagini molto forti, come quando è costretto a strappare il cuore ad un cane.
“They say when you meet the love of your life, time stops, and that's true. What they don't tell you is that when it starts again, it moves extra fast to catch up.” “Dicono che quando incontri l’amore della tua vita il tempo si ferma...ed è vero. Quello che non ti dicono è che poi va a doppia velocità per recuperare” (Edward Bloom in Big Fish, Tim Burton, 2003)

“Coloro che erano destinati a lasciare Ashland passavano incolumi, gli altri restavano lì per sempre, incapaci di tornare indietro o di andare avanti” (Big Fish, Daniel Wallace, 1998, p. 45)
L’episodio di Specter è fondamentale, e Burton decide di fondere le due città in cui l’Edward “d’inchiostro” si muove, dando vita a quest’unica cittadina dell’Alabama che tanto ricorda le ambientazioni di Forrest Gump, compresa la piccola Jenny innamorata e mai corrisposta da Edward, neanche da adulta (Helena Bonham Carter). Una città ideale, apparentemente felice, dove però a regnare è la rassegnazione, la noia, la routine di una vita fatta di ripetizione e prevedibile omologazione, tutto l’opposto di ciò che Edward vorrebbe, di ciò che un creativo come Burton si augurerebbe dalla propria esistenza. «Non si fa altro da queste parti, Edward. Ci si abitua», e nel termine abitudine si ritrova tutto il senso di oppressione e noia che immobilizzano gli abitanti, strabiliati da Edward e salvati due volte, perché non solo quando la città cade in rovina lui la compra e la rimette a nuovo, ma ridà nuova linfa a chi la abita.
“Lo vedi?” dico io ”Anche quando parli seriamente non puoi fare a meno di scherzare. È frustrante, papà. Sembra tu mi tenga a distanza.” (Big Fish, Daniel Wallace, 1998, p. 120)
Solo verso la fine del libro emerge con forza quella che è la natura del rapporto padre-figlio, argomento chiave di Big Fish, assieme ad una riflessione sulla narrazione in senso lato. William, all’ennesimo tentativo di suo padre di sdrammatizzare e sviare il discorso con una risata, non resiste più e sbotta definitivamente: «Ogni volta che ci avviciniamo a qualcosa di significativo, di serio o di delicato, lui racconta una barzelletta». Ed è significativo che Burton abbia voluto cancellare dal suo script le battute, concentrandosi molto di più sull’Edward affabulatore, che sfrutta ogni spunto per appigliarsi e raccontare una vicenda di vita, senza scherzare, senza humour, solo con il desiderio di raccontare, e di raccontarsi.
“Ricordare le storie che un uomo ha raccontato lo rende immortale, lo sapevi?” (Big Fish, Daniel Wallace, 1998, p. 14)
L’aspetto più importante, però, è la narrazione, che è il fulcro della storia. Edward, oltre che un incredibile avventuriero, è anche un meraviglioso retore, un cantastorie da cui tutti sono ammaliati e che ha poca stima della maniera di raccontare che hanno gli altri, in particolare di suo figlio Will: «L’avrebbe raccontata male, tutto fatti e niente colore», confida alla nuora (Marion Cotillard) riguardo alla storia dell’incontro tra lui e Sandra. Eppure, con Big Fish, Tim Burton compie il suo più grande elogio alla favola, sostenendo che i colori, le emozioni, sono ciò che rende speciale un racconto. C’è dell’incredibile, è vero, eppure nel commovente finale ci rendiamo conto di come tutti quei “colori” esistessero davvero, di come la realtà e la fantasia spesso coincidano. Big Fish è un inno alla vita, molto più ottimistico di quanto non lo sia il romanzo, ed è doveroso concludere come il genio di Burton ha deciso di salutare il suo pubblico, con le parole di William Bloom, che ha finalmente compreso a fondo suo padre:
«Vi è mai capitato di sentire una barzelletta così tante volte da dimenticare perché è divertente? E poi la sentite di nuovo e improvvisamente è nuova. E vi ricordate perché vi era piaciuta tanto la prima volta... A furia di raccontare le sue storie, un uomo diventa quelle storie. Esse continuano a vivere dopo di lui, e così egli diventa immortale».