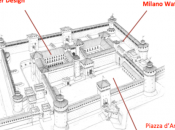di Giacomo Gabellini – Eurasia Rivista
di Giacomo Gabellini – Eurasia Rivista
L’entità della crisi economica indotta dall’onda d’urto propagatasi dallo shock del 2007-2008 ha sortito ripercussioni decisamente inaspettate sul piano delle teorie economiche dominanti e, conseguentemente, sulle operazione compiute dai vari Paesi in campo economico. Il successo che in questi anni hanno riscosso economisti “keynesiani” come Paul Krugman, Joseph Stiglitz, ecc. è effettivamente dovuto al fallimento del economia imperniata sul concetto di “laissez-faire”, di cui i padri della “scuola austriaca” (Ludwig Von Mises e Friedrich Von Hayek) e i loro allievi della “scuola di Chicago” (Milton Friedman in primis) sono stati i principali sostenitori. Il disastro economico odierno può essere infatti considerato come il risultato delle misure neoliberali applicate inizialmente in tutti i Paesi industrializzati, e successivamente in quasi tutto il mondo per effetto del processo di globalizzazione irradiato dal pulsar statunitense attraverso le sue potenti propaggini finanziarie (Banca Mondiale e Fondo Monetario Internazionale).
Ma l’affermazione delle teorie neoliberali è a sua volta dovuta all’inadeguatezza delle ricette keynesiane manifestatasi in seguito allo shock petrolifero del 1973.
La validità della teoria generale di John Maynard Keynes rimase praticamente indiscussa dagli anni ’40 fino a quel particolare episodio storico per alcuni motivi piuttosto peculiari.
In sostanza, la teoria economica sviluppata da Keynes è incardinata sul concetto di “domanda aggregata”, che risulta dalla somma della domanda di consumi da parte dei cittadini, della domanda di investimenti da parte delle imprese, la domanda del settore statale mediante la spesa pubblica e i tassi di interesse, e la domanda dei mercati internazionali, sostenibile incentivando le esportazioni e quindi correggendo verso il basso i tassi di cambio.
Focalizzando l’attenzione sulla variabile della domanda aggregata e sui suoi componenti, Keynes offrì una base teorica volta a combattere due dei principali problemi che le economie nazionali si sarebbero potute trovare ad affrontare, ovvero la disoccupazione e l’inflazione.
Dal momento che riteneva che la disoccupazione scaturisse da una depressione della domanda aggregata, Keynes suggeriva di intervenire per sostenere questa domanda. Per una nazione sarebbe quindi stato possibile:
A – stimolare i consumi attraverso il taglio delle imposte dirette, in modo da consentire ai cittadini di conservare più soldi da spendere;
B – favorire gli investimenti delle imprese applicando bassi tassi di interessi così da rendere più abbordabile il costo del denaro;
C – edificare nuove infrastrutture e potenziare quelle esistenti allargando i cordoni della spesa pubblica, coinvolgendo direttamente i cittadini nella costruzione di strade, ponti, ferrovie, ospedali, ecc.;
D – colmare la carenza della domanda interna orientando la produzione verso le esportazioni, da promuovere mediante la svalutazione della moneta locale.
D’altro canto, Keynes era convinto che l’inflazione fosse dovuta a un aumento eccessivo ed incontrollato della domanda aggregata cui non corrisponderebbe una offerta adeguata, e indicava pertanto di agire per comprimere la richiesta di beni e servizi. Lo Stato sarebbe quindi stato chiamato ad applicare misure diametralmente opposte a quelle necessarie per fronteggiare la disoccupazione. Avrebbe quindi potuto:
A – deprimere i consumi aumentando le imposte dirette;
B – scoraggiare gli investimenti delle imprese applicando alti tassi di interesse;
C – focalizzare l’attenzione sul bilancio adottando politiche di austerità volte a tagliare la spesa pubblica;
D – sostenere la moneta locale in modo da rendere più problematiche le esportazioni.
I presupposti che Keynes fissò per escogitare questa brillante teoria non contemplavano, naturalmente, che i fenomeni di disoccupazione e inflazione potessero manifestarsi contemporaneamente, dal momento che la disoccupazione, spingendo verso il basso i prezzi, si manifestava generalmente in periodi deflazionistici. Va sottolineato che nel momento in cui il grande economista britannico ideò le sue teorie gli Stati erano molto “chiusi” verso l’esterno, e riuscivano quasi sempre a rifornirsi dei beni di cui avevano bisogno attingendo alle risorse di cui disponevano all’interno dei confini nazionali o importandoli alle proprie insindacabili condizioni dalle colonie. Ma la decolonizzazione e le sue logiche di base, associata all’aumento costante della domanda di energia determinarono una progressiva apertura dei mercati nazionali, che cominciarono ad interconnettersi tra di loro in maniera sempre più salda.
Così, quando si verificò lo shock del 1973, il “paradosso” keynesiano finì per verificarsi, poiché l’aumento esorbitante del prezzo del petrolio (pari al 400%) circa innescò un brusco aumento dei costi di produzione da parte delle imprese che si videro costrette a scaricare il tutto sul prezzo finale. Le politiche keynesiane adottate per arginare il fenomeno si rivelarono completamente fallimentari, poiché in quel caso l’inflazione non era dovuta a un aumento incontrollato della domanda, ma a una decisione politica assunta dai Paesi membri dell’OPEC in combutta con lo Shah di Persia, nonché con Richard Nixon ed Henry Kissinger.
Il trionfo del neoliberismo nacque proprio sulle ceneri delle ricette keynesiane, il cui fallimento costituì un’occasione da non perdere per i principali esponenti della “scuola di Chicago”. Milton Friedman in persona ebbe a scrivere che: «Soltanto una crisi, reale o percepita che sia, produce vero cambiamento. Quando quella crisi si verifica, le azioni intraprese dipendono dalle idee che circolano. Questa, io credo, è la nostra funzione principale: sviluppare alternative alle politiche esistenti, mantenerle in vita e disponibili finché il politicamente impossibile diventa il politicamente inevitabile».
La celebre giornalista canadese Naomi Klein ha individuato in questa espressione la base su cui è stata costruita la cosiddetta “shock therapy”, ovvero la prassi operativa attraverso cui decine e decine di Paesi sono stati convertiti, sotto la sorveglianza di Banca Mondiale e Fondo Monetario Internazionale, all’economia liberista dopo l’“esperimento” attuato dagli esponenti della scuola di Chicago nel Cile di Augusto Pinochet.
Secondo il nuovo paradigma di riferimento, l’attenzione generale non sarebbe più dovuta cadere sul lato della domanda, ma su quello dell’offerta, e l’approccio alla realtà sarebbe dovuto passare dal macroeconomico al microeconomico. Lo Stato si sarebbe pertanto dovuto limitare a mantenere i conti a posto, ad applicare tassi di interesse volti a garantire la stabilità e a ridurre le imposte allo scopo di stimolare le aziende ad investire migliorando la qualità dei loro prodotti. In tal modo si sarebbe favorita la concorrenza, e ciascuna impresa sarebbe stata costretta a comprimere i cosiddetti “costi fissi” per mantenersi competitiva sui mercati mondiali. L’aumento dei costi indotto dallo shock petrolifero fu quindi mitigato con il taglio dei salari, la rimozione degli apparecchi volti a limitare l’impatto ambientale e tutte le altre misure rientranti nel programma di “razionalizzazione produttiva”.
Grazie a queste circostanze, le tesi di Milton Friedman sostituirono quelle di Keynes, giudicate ormai obsolete, e numerosissime nazioni di tutto il mondo vararono robusti programmi imbevuti di neoliberismo.
Con lo scoppio della crisi del 2007-2008, le teorie di Keynes sono state rapidamente riscoperte ed evocate specialmente in riferimento all’Europa, alla luce del fatto che nel Vecchio Continente ha cominciato a permanere nuovamente il fenomeno di deflazione combinato a disoccupazione di massa. Numerosi economisti come Paul Krugman hanno ripetutamente stigmatizzato l’Unione Europea e la Banca Centrale Europea, perché impediscono per statuto ai singoli Paesi sia di stabilire i tassi di interesse da applicare sia (soprattutto) di svalutare la moneta per favorire le esportazioni. Ciascun Paese ha il potere di agire unicamente attraverso strumenti fiscali. Ma limitarsi ad aumentare la spesa pubblica ed abbassare le tasse senza poter intervenire sui tassi di interesse e sulla moneta finisce soltanto per alimentare il deficit e il debito pubblico. Con la sottoscrizione del cosiddetto “patto di stabilità”, gli Stati sono stati espropriati anche del potere di avvalersi di questi strumenti, poiché ogni Paese è tenuto a rientrare in determinati parametri di disciplina di bilancio (deficit al 3% e debito pubblico al 60% del Prodotto Interno Lordo).
Secondo la teoria keynesiana, i Paesi mediterranei, che hanno tassi di disoccupazione che in alcuni casi supera il 20%, necessiterebbero di politiche espansive, in cui la spesa in disavanzo dovrebbe essere associata a una riduzione delle tasse, a una diminuzione dei tassi di interesse e a una svalutazione competitiva, ma l’Unione Europea proibisce l’applicazione di questo genere di misure. La BCE ha abbassato notevolmente i tassi di interesse e concesso denaro a basso costo alle banche che, lungi dall’utilizzare questa liquidità per sostenere imprese e famiglie, hanno fatto incetta di Buoni del Tesoro dei Paesi mediterranei e successivamente scommesso pesantemente sul loro declino attraverso i Credit Default Swap, in modo da lucrare sull’aumento degli spread. Le banche tedesche (Deutsche Bank e Commerzbank) si sono distinte per solerzia e disinvoltura con cui hanno applicato questa prassi allo stesso modo in cui Berlino si è opposta a qualsiasi genere di apertura finalizzata a dar respiro all’economia greca, spagnola, italiana e portoghese. La Germania intende mantenere le condizioni che le consentono di registrare i propri esorbitanti avanzi nella bilancia dei pagamenti, il 60-65% dei quali è assorbito dai Paesi membri dell’Eurozona. Angela Merkel e il ministro delle Finanze Wolfgang Schaeuble si sono irriducibilmente opposti sia alla svalutazione dell’euro, sia alla federalizzazione del debito sia al lancio dei cosiddetti “Eurobond” – che impedirebbero le periodiche fiammate degli spread –, sostenendo che la “fiducia” dei “mercati” si recupererà soltanto mostrando finanze pubbliche in salute, in conformità alle tesi sostenute da Carmen Reinhart e Kenneth Rogoff clamorosamente rivelatesi prive di alcun fondamento. In tal modo l’intera Europa mediterranea rischia concretamente di sprofondare nella depressione economica, con tutti i suoi corollari di disoccupazione galoppante e disintegrazione del tessuto sociale ad essa connessi.
L’opposizione a qualsiasi genere di politica espansiva è peraltro aggravata dal cambio di paradigma deciso dal nuovo governo giapponese, che intende, molto keynesianamente, raddoppiare la base monetaria nazionale nell’arco di pochi anni allo scopo di far lievitare sensibilmente l’inflazione e di deprimere la valutazione dello yen, in modo da favorire le esportazioni.
Negli Stati Uniti, le istituzioni hanno addirittura attinto a piene mani alle teorie di Keynes. Ma ciò non toglie che la politica espansiva condotta dal Dipartimento del Tesoro e dalla Federal Reserve appaia estremamente pericolosa, nonostante l’intero comparto informativo continui a parlare incessantemente di “ripresa degli USA” e di “calo della disoccupazione”. Con i suoi continui quantitative easing, la Federal Reserve sta infatti riacquistando titoli di debito emessi dal Tesoro al ritmo di circa un trilione di dollari all’anno, cosa che ha reso i bond estremamente costosi e portato la loro redditività a livelli negativi, in termini reali. Per la Fed si tratta di una mossa indispensabile ad assicurare la solvibilità delle banche, le quali, nonostante la loro spaventosa esposizione sul mercato dei derivati (la sola JP Morgan Chase ha un’esposizione sui derivati equivalente al Prodotto Interno Lordo mondiale), hanno utilizzato questa liquidità non per allargare il bacino del credito a famiglie e imprese, ma per operare pesantemente sui mercati azionari – non è un caso che gli indici Dow Jones e Standard & Poor’s abbiano registrato ben due record nell’arco di poche settimane. Ma l’evidente surriscaldamento degli stock market rappresenta un segnale molto pericoloso, perché indica la presenza di un’euforia capace di dissolversi in pochi attimi, provocando una caduta ben peggiore di quelle verificatesi nel 1987 e nel 1999.
L’evidente collusione tra la Fed e Wall Street (va ricordato che la Banca Centrale è controllata da banche private – gruppi Rothschild, Warburg, Lazard, Rockefeller, Kuhn Loeb e banche come Goldman Sachs, Citigroup, ecc. – azioniste dei 12 distretti che compongono la “riserva federale”) si è tuttavia spinta ben oltre il sostegno indiscriminato ed illimitato alle grandi banche. Un economista molto addentro a queste questioni come Paul Craig Roberts (ex alto funzionario al Tesoro nonché padre della cosiddetta “reaganomics”) sostiene infatti che la Federal Reserve abbia più o meno direttamente affidato ai giganti del credito il compito di inondare di short “nudi” il mercato dei future sull’oro. Merrill Lynch e Goldman Sachs in primis avrebbero teleguidato questa potente offensiva tesa a far crollare il valore del metallo, in modo da scoraggiare gli investitori a puntare sul bene-rifugio per eccellenza orientandoli verso la divisa statunitense.
Con il valore del dollaro tenuto a galla attraverso questo genere di “prodigi”, la Fed è riuscita a tenere (molto) parzialmente a freno l’inflazione (già altissima, come sostiene l’economista John Williams, il quale, attraverso calcoli specifici, ha scoperto che i dati ufficiali sottostimano notevolmente il livello reale dell’aumento dei prezzi), che aumenterebbe inesorabilmente in misura esponenziale qualora l’allontanamento generalizzato dalla divisa statunitense attualmente in atto dovesse ulteriormente radicalizzarsi. L’effetto di aumentare considerevolmente l’offerta di valuta statunitense in presenza di una sensibile contrazione della domanda innescherebbe automaticamente una sonora caduta di valore del dollaro, e per un Paese come gli USA, la cui bilancia dei pagamenti è cronicamente in passivo per effetto della pesante deindustrializzazione subita in passato (anche a causa delle dinamiche legate alla globalizzazione), il deprezzamento della moneta provocherebbe forti fiammate inflazionistiche immobilizzando i redditi.
Per mitigare l’aumento dei prezzi, la Federal Reserve si vedrebbe costretta ad alzare il tassi di interesse, ma ciò provocherebbe la caduta del valore e la conseguente esplosione della redditività dei Treasury bond, il che appesantirebbe enormemente gli oneri a carico dello Stato e indurrebbe una drastica stretta creditizia (credit crunch) suscettibile di strangolare defintivamente l’arrancante economia reale. Verrebbe così innescata una tremenda spirale distruttiva che abbatterebbe i redditi e farebbe crollare le entrate fiscali, alimentando il già colossale deficit nazionale. Si manifesterebbe, in altre parole, di una forma estremamente radicale di stagflazione, in cui il fenomeno dell’inflazione galoppante si presenterebbe in presenza di una grave fase depressiva. La materializzazione del fenomeno che la dottrina economica ha sempre bollato come paradosso (inflazione mista a depressione) delineerebbe i contorni di una catastrofe inaudita di fronte alla quale non esistono rimedi.
Sull’economia statunitense gravano quindi tre gigantesche bolle (obbligazionaria, azionaria e del dollaro), che potrebbero scoppiare da un momento all’altro generando ripercussioni inimmaginabili che si propagherebbero ben oltre l’economia e il tessuto sociale nordamericano. Tutto dipende quindi da quale atteggiamento Cina e Giappone in primis decideranno di tenere nei confronti della valuta statunitense. Malgrado Pechino e Tokio siano ben consapevoli che un deprezzamento del dollaro ridurrebbe considerevolmente il volume del credito che possono vantare nei confronti di Washington, non sono mancati segnali di fastidio. Il 26 dicembre 2011, infatti, si è tenuto il vertice di Pechino, al termine del quale l’allora capo del governo cinese Wen Jibao e l’allora primo ministro giapponese Yoshihiko Noda hanno sottoscritto un accordo dall’enorme coefficiente strategico, che prevede l’abbandono del dollaro come valuta di riferimento nell’ambito degli interscambi tra le due potenze asiatiche. Yuan e yen saranno chiamate a sostituire la moneta statunitense, che fino a quella fatidica data costituiva l’indice di riferimento di oltre la metà delle transazioni commerciali tra Pechino e Tokio. Come se non bastasse, i governi di Corea del Sud, Malaysia, Australia, Indonesia, Bielorussia, Argentina e Brasile hanno stipulato accordi bilaterali con Pechino attraverso cui si è stabilita la possibilità di utilizzare lo yuan come moneta di riferimento alternativa al dollaro. La Cina ha fatto valere le proprie posizioni al riguardo anche nella riunione del BRICS tenutasi a Durban nel marzo 2013, al termine della quale i Paesi membri hanno deciso di escludere il dollaro dai loro scambi e di dar vita a un ente bancario destinato verosimilmente ad esercitare una forte concorrenza alle istituzioni di Bretton Woods, controllate dagli USA.