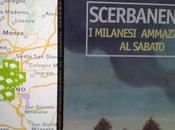Lo scandalo della Regia dei Tabacchi: il primo scandalo dell'Italia Unita. Una storia del nostro passato che però, a rileggerla, anche col tono da romanzo storico che Stella usa nel racconto, sembra uno degli scandali che leggiamo oggi nelle pagine della cronaca giudiziaria.
«La madre di tutte le tangenti», secondo Gian Antonio Stella, che ha ricostruito con un lavoro certosino tutta la storia: la convenzione stabilita nel luglio 1868 (lo stesso anno della tassa del macinato) tra il ministero delle Finanze e Domenico Balduino, rappresentante della Società del Credito Mobiliare, a sua volta legata ad altri istituti di credito. Lo Stato cedeva per vent'anni la gestione dei Tabacchi ad una società anonima privata, che riconosceva alle Finanze una certa percentuale sulle entrate e anticipava alle pubbliche casse 180 milioni di lire. Una vendita in realtà, visto il lungo periodo della convenzione e il basso costo del privato.
Una concessione che avrebbe dietro una storia di tangenti ad uomini politici della destra storica, allora al governo. Gli zuccherini, come vengono chiamati nel libro.
O tangenti, come le chiamiamo oggi. Che sarebbero arrivate fino al re Savoia.Non solo: alcuni parlamentari, a conoscenza dell'accordo, avrebbero anche speculato sulle azioni del Credito, intascando un lauto guadagno.
In aula questo accordo fu denunciato persino
dallo stesso presidente della Camera, Giuseppe Lanza, anche
lui esponente della destra.
Il presidente attaccò:
«il
sistema degli appalti in materia di imposte, perché aveva dato
sempre gli stessi risultati: appaltatori impinguati, finanze
stremate, ira popolare, rivoluzione». «Signori - concludeva - vi
siete informati in prima in che condizione sia il Credito Mobiliare,
quale sia il suo capitale effettivo, quale sia il corso delle sue
azioni, de' suoi titoli, quali sono gli affari che ha fatto da che fu
istituito e come li abbia condotti?».
Ma, al momento del
voto, prevalse nel partito governativo la disciplina di partito.
Il
giornale il «Gazzettino Rosa» di Milano denunciò, facendo i
nomi, dei deputati che avevano preso mazzette per votare a favore
della Regia: girava voce «che non meno di sei milioni si fossero
distribuiti per comperare voti di deputati, che in numero di
sessantacinque avevano messo al traffico la propria coscienza».
I
giornalisti furono condannati a 8 mesi di carcere: assieme agli
effetti della tassa del macinato (fruttata allo stato solo 28
milioni), queste notizie creavano tensione in un paese allo stremo,
dove la gente non tollerava questi scandali.
Finchè, il 5
giugno 1869, il deputato Cristiano
Lobbia, maggiore dell'esercito, uomo di fiducia di Garibaldi,
un eroe del Risorgimento, denunciò la corruzione, gli
arricchimenti,lo scarso rispetto per il bene pubblico e chiese una
Commissione di inchiesta.
Per forzare la mano, agitò in aula lo
spauracchio, per il governo che quella concessione l'aveva fortemente
voluta, di alcuni plichi che contenevano le prove.
«Annunzio
solennemente alla Camera che posseggo dichiarazioni di testimoni,
superiori a qualsiasi eccezione, le quali dichiarazioni sono a carico
di un deputato nostro collega, e si riferiscono a lucri che avrebbe
percepito nelle contrattazioni della Regìa dei Tabacchi».
La
commissione fu così convocata il 16 giugno, ma il 16 sera, mentre si
stava recando a casa dell'amico Martinati, Cristiano Lobbia fu
vittima di un attentato, in via dell'Amorino: ferito ad un braccio e
alla testa, riuscì a salvarsi, dopo aver sparato all'aggressore.
L'attentato suscitò una forte reazione: si vide nella mano dell'assassino (rimasto ignoto) la mano di un potere politico che non intendeva fare luce sulla Regia dei Tabacchi.
Sensazione che si accrebbe per lo scarso impegno da parte delle forze dell'ordine (che si muovevano sotto ordine del Re, come la magistratura) nel trovare il colpevole, nel raccogliere le prove.Nel frattempo, il Re chiudeva le Camere il 17 giugno, impedendo di fatto la continuazione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta e la testimonianza di Lobbia.
Se una parte della Stampa continuò la sua azione di critica nei confronti del Re e del governo, la stampa di destra, in particolare il giornale La nazione (di proprietà di Brenna, deputato coinvolto nella Regia) iniziò a far girare voci, insinuazioni, per cui Lobbia si sarebbe fatto l'attentato da sé. Una simulazione per nascondere l'assoluta mancanza di prove a carico di Civinini (ex garibaldino, passato alla destra, anche lui coinvolto nel giro di mazzette) e degli altri personaggi da lui accusati.
Oggi la chiameremmo macchina del fango: Lobbia dovette però difendersi da un pericolo ben peggiore. Fu istruito, in fretta e furia, un processo a suo carico (e ai suoi amici che avevano firmato con lui i plichi con le prove) per simulazione di reato.
Lobbia si ritrovò da vittima ad accusato: l'indagine fu avocata dalla procura generale, il ruolo dell'accusa fu preso da tale De Foresta (che scrisse una requisitoria piena di menzogne, tirata per i capelli, ma ritenuta incredibilmente “la più probabile”.
Il sostituto procuratore generale spostato all'Aquila e sostituito dal conte Augusto Avet: ancora non erano tempi di giustizia uguale per tutti, e la giustizia, nello statuto albertino, era considerata emanazione del Re. Re e governo che avevano tutti gli interessi a chiudere in fretta i lavori della Commissione (a porte chiuse e a Camera dei deputati chiusa) che mandò tutti assolti. E a distruggere l'immagine del maggiore Lobbia, non una persona integerrima (come ritenevano le persone che protestavano in piazza) ma uno con problemi di demenza in famiglia e che si era inventato tutto.
Il processo, Kafkiano, fu pilotato in una sola direzione: screditare la sua immagine, far intervenire in aula solo testimoni (provenienti da settori governativi, dunque ricattabili dall'esecutivo) che raccontavano la stessa versione (nel vicolo, Lobbia era solo e si sarebbe sparato).
Funzionari di polizia, dei ministeri, dell'agenzia delle dogane.
Perfino le prostitute di una vicina casa di Tolleranza. Fino al testimone chiave: un tale, che non era presente nelle carte della requisitoria, che giura di essere stato presente quella sera in via dell'Amorino.
Ma non tutti gli uomini dello Stato si lasciano governare dai desiderata del Re e del governo. Il procuratore del Re Giuseppe Borgnini, dopo la decisione di accogliere anche quest'ultimo testimone e dopo la requisitoria del sostituto procuratore generale De Foresta (piena di accuse e menzogne), scrive una lettera di dimissioni al guardasigilli Pironti, il cui finale merita di essere ricordato:
«Rassegno le mie dimissioni dal posto di procuratore del Re di Firenze. Al rimprovero che mi si volle fare, io sacrifico venti anni di fatiche, spese con amore al mio Paese che può essere più intelligente ma non più intenso: offro il mio passato e il mio avvenire; ma una maggiore condiscendenza, ove si volesse, sarebbe una pretesa eccessiva. Signor ministro, se in me fu ferita la più preziosa prerogativa del magistrato, io provo almeno il conforto di lasciare, a chi succederà a me, un posto non compromesso da basse adulazioni o da indebite compiacenze. Firmato: Giuseppe Bognini».La procura generale bloccò anche la richiesta dei difensori di applicare le sue guarentegie: per portare a processo un deputato serviva l'autorizzazione della Camera. Ma solo nel caso in cui la Camera fosse aperta. Ma il Re la tenne chiusa (caso unico nella storia) fino a metà novembre 1869. Un arco di tempo sufficiente per arrivare a sentenza. Il 17 novembre 1869.
Sentenza di condanna, per "simulazione di reato", «perché venne a trovarsi nell'assoluta necessità di scuotere fortemente con qualche fatto la pubblica opinione». Il giornale “Il popolo d'Italia”, vicino a Crispi, commentò la sentenza con queste parole:
“Noi sapevamo già come la camorra scellerata che ci governa fosse tale da non retrocedere innanzi ad alcuna infamia; sapevamo che un governo come il nostro non avrebbe avuto ribrezzo né ritegno di sorta, ma che alcuni della magistratura, che dovrebbe tutelare l'onore e le sostanze dei cittadini, fossero così servili da scoprire in pubblico la loro lurida vergogna era tal cosa che non volevamo credere: ma poiché la cosa è vera noi diremo a questi signori che le donne da mercato, di cui invocarono la testimonianza, non sono che un pallido ritratto delle loro figure”.Non solo le prostitute chiamate a testimoniare, col sospetto di essere state imbeccate per dare una versione di comodo. Ma anche la sensazione di testimoni manipolati, minacciati dal procuratore Nelli e dal giudice istruttore Tondi. Testimoni, quelli che avrebbero potuto dare sostegno alla tesi dell'aggressione, che si cercò anche di corrompere.
Lobbia, che non aveva presenziato alle sedute del processo in protesta contro il tribunale (che non aveva atteso la decisione della Camera), accettò la condanna e rifiutò (immaginiamo anche con un certo sdegno) l'amnistia (decretata dal Re, proprio per coprire tutti i reati politici).
Si arrivò all'appello: la procura generale arriva perfino a rifiutare le carte del processo alla Camera, per la necessaria autorizzazione a procedere. Uno scontro tra poteri dello stato (non indipendenti, come si è visto). Lo scandalo fu così forte, nel paese e nei palazzi del potere, che il presidente del Consiglio Menabrea (al potere quando fu firmata la concessione) fu sfiduciato in favore dell'esponente della destra, Giovanni Lanza che in aula aveva denunciato l'accordo.
Era in corso, in quei mesi, un altro processo, relativo
al furto dei documenti del deputato Fambri al cognato Brenna
(proprietario del giornale La Nazione): in una di queste, pubblicate
sui giornali, si parla di speculazioni sulle azioni del Credito.
Questo processo viene ignorato dai media, diversamente da quello
contro Lobbia su cui i giornali hanno molto romanzato, poiché
coinvolge anche persone della maggioranza.
Siamo nel 1870:
chiamato da Garibaldi, che non ha mai smesso di manifestargli la sua
stima, Lobbia
accorre al suo fianco per difendere la Repubblica francese nella
guerra contro la Prussia.
Anche qui ha modo di farsi onore, in
prima linea.
Rinunciò al mandato parlamentare e tornò a
combattere con
l'Armata dei Vosgi,
stavolta con il grado di generale, e partecipare valorosamente alla
battaglia di Digione.
La
sentenza di appello arrivò nel 1872, confermando la condanna: ma la
Cassazione la annullò, ma solo per un vizio procedurale. Il processo
fu spostato a Lucca dove, nel 1875, il tribunale assolse Cristiano
Lobbia. La notizia fu riportata solo su pochi giornali in poche
righe.
Non interessava più a nessuno di Cristiano Lobbia, se non
i suoi compaesani di Asiago. Ma intanto, attorno alla Regìa
dei Tabacchi,
continuavano a capitare strane morti di testimoni.
Gente che aveva
assistito agli spari, uno che era stato indicato come presunto
assassino.
Stava diventando, il mistero della Regia dei
Tabacchi, forse il primo mistero dell'Italia unita.
Lobbia
trascorse i suoi ultimi anni a Venezia, senza vedere la sua
onorabilità ripristinata. Dimenticato dalla gente, avvilito,
mortificato nell'anima, chiedendosi se non fosse stato meglio morire,
quella sera in via dell'Amorino, piuttosto che subire quella infamia
di un processo politico.
Lui che aveva abbandonato gli studi in
Ingegneria per unirsi ai moti insurrezionali del 1848 contro la
tirannia austro-ungarica in Veneto, costituendo e comandando un corpo
di 800 volontari da lui chiamato
“Legione Cimbrica”.
Lui
che aveva combattuto a fianco di Garibaldi in Sicilia; che aveva
attraversato il Mincio a nuoto per raggiungere i Mille.
Che di
fronte alle notizie dello scandalo per la concessione dei Tabacchi,
delle mazzette, dei parlamentari comprati coi soldi dei banchieri,
dello sperpero di denaro pubblico, seppe subito cosa bisognava fare.
Sicuramente sarebbe stato giusto, per celebrare i 150 anni di storia, ricordare anche personaggi come Cristiano Lobbia, per cui la definizione di eroi, non è la solita frase di circostanza.
“I Misteri di via dell'Amorino” è un pezzo della nostra storia: una storia in cui a persone nobili, si sono affiancati servitori dello stato infedeli, “magistrati integerrimi e giudici servili, patrioti idealisti e viscidi voltagabbana, povere peripatetiche divorate dalla sifilide e giornalisti dalla penna avvelenata. Intrighi, violenze, omicidi” . Sembra una storia dell'oggi, a ben vedere: specie se si rileggono le parole con cui il ministro delle Finanze dell'epoca (un altro nobile) giustificava la concessione. Per imporre la scelta del monopolio (invisa anche a pezzi della maggioranza) la mascherò parlando di riforma. Siccome nella conduzione della Regìa c’erano sprechi, inefficienza, sacche di parassitismo (anche allora), la proposta di ricorrere al capitale privato fu motivata da Cambray Digny (il ministro) con l’opportunità di risanare e razionalizzare l’azienda. Alla Camera, disse il ministro, si riteneva utile affidare la Regìa dei Tabacchi, a "una associazione di capitalisti, la quale, svincolata dai molti legami e tradizioni degli uffici governativi, potesse sradicare gli abusi, procedere a decisive riforme, ed avere l’interesse privato a sprone nell’introdurvi quelle norme e quei sistemi più semplici e capaci di cavarne un prodotto maggiore".
Lo Stato italiano aveva appena sette anni.
La storia dello scandalo della Regìa dei tabacchi. L'articolo di Pietro Citati sul corriere: “L'affare tabacchi, il primo scandalo”.
Il link per ordinare il libro su ibs La scheda del libro sul sito di Rizzoli Technorati: Gian Antonio Stella