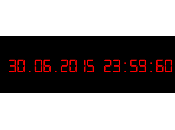LA TERRA E’ UNO STRANO POSTO.Se la guardate con gli occhi di Raj Patel. Le persone in sovrappeso sono un miliardo, mentre 800 milioni sono quelle che soffrono la fame. Ogni anno le multinazionali del cibo mettono sul mercato 15-20 mila nuovi prodotti alimentari, ma nei paesi in via di sviluppo è in corso un’epidemia di suicidi tra gli agricoltori che vanno in rovina per via dei mercati globali.”Per ogni dollaro speso per promuovere alimenti naturali si spendono 500 dollari per pubblicizzare junk food”, spiega Patel. Ma chi è Patel? E perché è diventato famoso? La risposta (minimalista) è: è un sociologo che si occupa del cibo, globalizzato e non, che mangiamo. Ed è egli stesso un prodotto della globalizzazione.Sua madre viene da una famiglia di impiegati pubblici del Kenya, suo padre dalle miniere delle isole Fiji. Lui è nato a Londra, ha studiato a Oxford, ha lavorato alla Banca mondiale e al Fondo monetario di Washington, esperienza che lo ha trasformato in uno dei più agguerriti critici delle due organizzazioni. Un uomo che conosce l’universo mondo, compresi i sapori e i profumi di quel che si mangia.Oggi Patel insegna a Berkeley, in California, e il libro che ha pubblicato, ‘Stuffed & Starved’ (rimpinzati e affamati), in uscita in Italia da Feltrinelli con il titolo ‘I padroni del cibo’, è un bestseller, ed è diventato un testo chiave, lodatissimo anche da Naomi Klein, per tutti quelli che indagano su che cosa sta succedendo al cibo che mangiamo. O meglio, per tutti coloro che sono convinti che è il cibo la chiave del potere (economico, culturale, politico) nel XXI secolo.
L’INTUIZIONE CHE HA PORTATO PATEL A UN TALE SUCCESSO E’ SEMPLICE.Il peccato capitale della nostra economia è avere dimenticato che il cibo non è una merce come le altre . Il cibo è prima di tutto cultura, e lo è per diverse ragioni tutte ugualmente importanti: perché al cibo sono legate tradizioni culinarie antiche, sapori e odori che fanno parte del sentire collettivo, dell’identità e della geografia stessa, ma anche perché l’agricoltura è il necessario complemento di questa tradizione e rappresenta il motore fondamentale delle economie regionali, specie nei paesi poveri.Già il movimento dei no global, di cui Patel fa parte, fino dagli esordi, aveva provato a lanciare questa operazione culturale alla fine degli anni Novanta. Quel movimento, in Occidente, è stato spazzato via dall’11 settembre, dopo una fiammata tra il 1999 e il 2001, da Seattle a Genova. Ma quelle idee hanno continuato a scavare, e in questi ultimi anni la discussione sul ruolo del cibo ha assunto importanza centrale.E non si tratta solo di militanti. Per capire il ruolo che il cibo, dalla sua produzione e fino al nostro modo di stare a tavola, ha assunto nel nostro immaginario, basti citare alcuni film di questi anni: da ‘Supersize Me’, denuncia del fast food di Morgan Spurlock, a ‘Sideways’ di Alexander Payne in cui fare e gustare lentamente il vino è associato all’idea dell’amicizia, a ‘Couscus’ di Abdel Kechiche dove l’ottima cucina rende possibile l’integrazione di una famiglia di immigrati in una cittadina francese in crisi.
E POI CI SONO I LIBRI DENUNCIA.Nel 2001 fece scandalo Eric Schlosser con il suo ‘The Fast Food Nation’, che metteva a nudo le miserie delle grandi catene di ristorazione americane. Poi Paul Roberts, con ‘The End of Food’, ha svolto un’inchiesta sulla fragilità della catena produttiva che porta cibo scadente sulle nostre tavole. Michael Pollan (’In Defence of Food: An Eater Manifesto’) si è scagliato contro una cultura alimentare più attenta alla chimica che alla qualità. E Taras Grescoe, in ‘BottomFeeder’, ha raccontato la crisi ecologica del pesce negli oceani.La novità è che Patel mette insieme tutti i pezzi di questo mosaico in una visione unitaria che comprende gli affamati del Terzo mondo e gli obesi di casa nostra, cercando di capire che cosa è andato storto in un mondo in cui la tecnologia potrebbe consentire a tutti di mangiare decentemente e di mantenere la propria identitàl libro di Patel è stato al centro dell’attenzione anche perché ha previsto con anticipo l’aumento dei prezzi degli alimenti dell’inverno scorso. Quell’evento ha indotto molti economisti a ripescare le previsioni catastrofiste di Thomas Malthus sulla possibilità che la produzione di cibo non fosse in grado di tenere il passo della crescita demografica. Malthus scrisse il ‘Saggio sul principio della popolazione’ 210 anni fa e nel frattempo tutti hanno pensato che quel suo testo fosse stato superato dall’innovazione tecnologica e dalla rivoluzione dei trasporti.E invece, all’inizio del XXI secolo, eccolo tornare alla ribalta come il tema centrale dell’umanità. Patel ci rassicura: Malthus aveva torto. Il cibo non manca, a soffrire di fame sono i poveri che non possono procurarselo, dice, ma per affrontare la questione della miseria bisogna incoraggiare i governi a difendere l’agricoltura anziché obbligarli a distruggerla. Per farlo basterebbe invertire le priorità: capire che il libero mercato dei prodotti alimentari è “una menzogna che ci viene venduta per ragioni propagandistiche”.
IN REALTA’ NEGLI STATI UNITI E IN EUROPA.Le grandi aziende agricole hanno accesso a enormi sussidi da parte dello Stato. Così, quando la Banca mondiale e la World trade organization obbligano i Paesi poveri a liberalizzare i loro mercati, intere culture e modi di vita vengono spazzati via. A maggio Patel, nel corso di un’audizione al Congresso Usa, ha definito lapolitica della Banca mondiale “ignominiosa”. E ha ricordato il caso del Ghana, dove negli anni ‘90 la produzione di riso copriva l’80 per cento dei consumi interni e quella di pollame il 95 per cento. Dopo la liberalizzazione imposta dalla Banca mondiale le produzioni locali sono crollate rispettivamente al 20 e all’11 per cento.E qui si arriva all’altro corno del dilemma: se ci sono tanti affamati, come mai ci sono anche tanti obesi? Semplice, perché la politica che porta una parte del mondo alla fame è nata nell’unico paese dell’universo, gli Usa, che non ha una tradizione alimentare e considera un’assurdità passare troppo tempo a tavola.
SI E’ INSOMMA OBESI PER MANCANZA DI CULTURA.Di identità, perché si ignorano quei gusti che altrove sono l’espressione del territorio e della geografia. Oltre un terzo degli americani non ha la più pallida idea della provenienza di ciò che mangia. Il 20 per cento delle decine di milioni che ogni giorno si nutrono di fast food lo consumano in automobile. Quella cultura ha fatto proseliti e nel mondo la grande M della McDonald’s è oggi un simbolo più conosciuto della croce cristiana.Fame e obesità sono due fenomeni contigui e persino negli Stati Uniti questa prossimità è evidente. Qui ci sono 35 milioni di persone che talvolta nel corso dell’anno non hanno i soldi per comprarsi da mangiare. Ma in maggioranza sono obese, perché quando hanno i soldi si nutrono di alimenti di scarsa qualità: “E questo accade perché sono subornati da una cultura alimentare che incoraggia a mangiare cibo dannoso, che provoca diabete e malattie cardiache”. Le quattro maggiori multinazionali dell’alimentazione controllano il 50 per cento del mercato alimentare. La sola Unilever controlla il 90 per cento del mercato mondiale del tè.Patel ricompone in un’unica logica le battaglie diVandana Shiva, la militante indiana che non vuole cedere alle multinazionali la sovranità sulle sementi, e quelle di Carlo Petrini, il fondatore dello Slow Food che invoca il controllo delle comunità locali sulla qualità del cibo. Sono passati 20 anni da quando il Nobel Amartya Sen pubblicò il suo memorabile saggio su ‘Libertà e cibo’, sostenendo, contro i liberisti alla Milton Friedman, che la possibilità di procurarsi alimenti decenti va considerata una delle libertà fondamentali dell’uomo. Allora Sen parlava del Terzo mondo. All’inizio del nostro secolo la battaglia economica e culturale per il cibo ci riguarda tutti.
Redatto da Pjmanc http:/ ilfattaccio