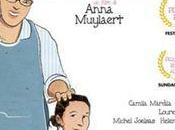Oggi l’esercito marciava per raggiunger la frontiera e far contro il nemico una barriera. Oggi, un secolo fa, con un giorno di anticipo rispetto al 24 maggio rimasto nella leggenda per via della canzone del Piave che aveva bisogno di una sillaba in più rispetto al 23. Ed è straordinario quanto poco ancora gli italiani sappiano su una guerra che ha determinato in tutti i sensi le sorti del Paese, oltre a costituirne una precoce e disperatissima autobiografia. Ma insomma come si è arrivati all’esercito in marcia contro gli imperi centrali che erano stati fino all’anno prima gli alleati di elezione e avevano tra l’altro coperto le spalle alle ambizioni coloniali italiane dall’Eritrea fino alla Libia? Bè la storia non è delle migliori e presenta i maledetti caratteri da mercato delle vacche che non mancano mai, che determinano la nostra fama di inaffidabilità e che finiscono regolarmente per svendere le possibilità del Paese per qualche piatto di lenticchie. Avvelenate per giunta.
Oggi l’esercito marciava per raggiunger la frontiera e far contro il nemico una barriera. Oggi, un secolo fa, con un giorno di anticipo rispetto al 24 maggio rimasto nella leggenda per via della canzone del Piave che aveva bisogno di una sillaba in più rispetto al 23. Ed è straordinario quanto poco ancora gli italiani sappiano su una guerra che ha determinato in tutti i sensi le sorti del Paese, oltre a costituirne una precoce e disperatissima autobiografia. Ma insomma come si è arrivati all’esercito in marcia contro gli imperi centrali che erano stati fino all’anno prima gli alleati di elezione e avevano tra l’altro coperto le spalle alle ambizioni coloniali italiane dall’Eritrea fino alla Libia? Bè la storia non è delle migliori e presenta i maledetti caratteri da mercato delle vacche che non mancano mai, che determinano la nostra fama di inaffidabilità e che finiscono regolarmente per svendere le possibilità del Paese per qualche piatto di lenticchie. Avvelenate per giunta.
Dunque nell’ estate del 1914 quando l’Austria dichiarò guerra alla Serbia, mettendo in moto l’infame meccanismo del massacro, l’Italia, nonostante la sua appartenenza alla Triplice alleanza, scelse la neutralità per due sostanziali motivi: in primo luogo perché non voleva dare una mano all’impero austroungarico ad ampliare la sua influenza nei balcani sui quali il Paese a torto o ragione riteneva di dover avere delle pretese e in secondo luogo perché temeva la potenza della Germania e non voleva opporsi apertamente alle mosse di Vienna. Più tardi successero alcune cose: la Germania fu fermata sulla Marna dagli anglo francesi sia pure a prezzo di enormi risorse umane e dunque apparve meno invincibile di quanto non si credesse, mentre l’Italia, ancora formalmente nella Triplice, diventava la pedina decisiva in quel gioco: se la Francia avesse dovuto aprire un fronte sud sarebbe stata spacciata. Perciò Londra e Parigi non risparmiarono denaro e sforzi per creare una corrente interventista di natura antiaustriaca proprio per evitare questa possibilità: una campagna ad ampio spettro che andava dai fondi dati a Mussolini per uscire dal partito socialista e fondare Il popolo d’Italia a opache concessioni, finora solo indiziarie riguardanti il favoreggiamento degli affari di casa Savoia nel campo dei petroli. Quelle stesse per le quali sarebbe stato ucciso Matteotti dieci anni dopo, secondo una non trascurabile scuola di pensiero .
Ma non corriamo troppo. Sta di fatto che alla fine del 1914 il ministro degli Esteri, Sidney Sonnino apre una sorta di trattativa sia con gli anglo francesi e che con gli austro tedeschi per cercare di lucrare il più possibile dagli uni o dagli altri. Ovvio che fosse l’Intesa ad avere il maggiore interesse ad offrire le ricompense più alte perché si trovava in maggiori difficoltà e sempre sull’orlo di una sconfitta decisiva non fosse altro che per questioni demografiche. Austria e Germania invece erano molto più in difficoltà a fare promesse perché le richieste territoriali italiane andavano dalla concessione di territori di lingua tedesca (l’Alto Adige dove domani non verrà esposta la bandiera, tanto per dire che affare abbiamo fatto) alla sottrazione dell’unico sbocco marittimo per l’Impero Austroungarico, ovvero Trieste e la Dalmazia. Qualcosa di quasi impossibile anche se poi venivano promesse, in caso di vittoria, la Corsica e il Nizzardo. Una scelta difficile per un governo che era pressato dagli industriali a scendere in guerra per ovvi motivi e che vedeva crescere sempre di più i movimenti nazionalisti e interventisti. Nonostante questo la trattativa andò avanti a lungo e fu sostanziamente sbloccata dagli avvenimenti: nella primavera del 1915 l’esercito zarista conseguì travolgenti successi sul fronte austriaco mettendo in grave crisi tutto il sistema difensivo imperial regio per cui si cominciò a pensare che una guerra contro l’Austria (il governo italiano tentò in effetti la mossa di dichiarare guerra solo a Vienna e non a Berlino) sarebbe stata facile e che in qualche mese se non in qualche settimana le truppe italiane avrebbero potuto arrivare alla capitale austriaca. Così il 26 aprile del 1915 l’Italia firmò il Patto di Londra (successivamente disatteso per volontà soprattutto degli americani scesi in guerra molto dopo) e un meno di un mese dopo entrò in guerra. Purtroppo per uno scherzo del destino pochi giorni dopo la firma del patto, esattamente il 2 maggio una controffensiva austro tedesca sul fronte della Galizia compresa tra le cittadine di Gorlice e Tarnov provoco il crollo del fronte russo: la ritirata delle truppe dello zar si trasformò in rotta e gli attaccanti in pochi mesi penetrarono in tutta la Polonia, prendendo Varsavia il 5 agosto.
Dunque la guerra che sembrava in un primo momento facile e rapida ( esattamente come accadrà venticinque anni dopo) divenne anche per gli italiani un massacro senza fine sia sulle Alpi che sul fronte dell’Isonzo con alterne vicende che rispecchiavano grosso modo gli eventi del fronte russo su cui l’Austria era costretta a mantenere il grosso delle’esercito e le truppe migliori. Infatti non appena la Russia fu attraversata dai fermenti rivoluzionari e l’esercito, decimato dalle perdite e dalle diserzioni in favore dei bolscevichi, non riuscì più a combattere efficacemente, fu subito Caporetto. Una mazzata che probabilmente avrebbe decretato una disastrosa sconfitta per un Paese che aveva appena cinquant’anni di travagliata vita alle spalle. Ma non accadde solo perché furono trovate le risorse militari per organizzare una resistenza davvero straordinaria.
Questo è davvero il nodo della guerra e degli eventi successivi: la resistenza sul Piave a quello che era ormai l’esercito austriaco al completo, con le truppe migliori e più agguerrite, per giunta rafforzato da molte divisioni tedesche provenienti dal fronte orientale, non furono il risultato di un particolare valore o della brillantezza degli stati maggiori che al contrario scontavano un’arretratezza cronica, quanto dalla prodigiosa e inaspettata capacità del complesso industriale di sfornare armi. Quasi tremila cannoni prodotti in più, messi in magazzino, fecero contro il nemico una barriera, ma in generale, fatto pressoché sconosciuto, la produzione italiana di armi, di munizioni, sistemi bellici fu doppia e spesso tripla rispetto a quella dell’impero Austro Ungarico consentendoci di resistere e poi di avere partita vinta.
E questo implica un fatto decisivo: al fronte, oltre ai militari di mestiere e agli uomini delle popolazioni vicine alle zone di guerra, andavano i figli della piccola borghesia del centro nord e i contadini del sud, mentre gli operai rimanevano in fabbrica con turni massacranti. Così alla fine della guerra la classe operaia rivendicava sul fronte dei salari e dei diritti la sua parte di vittoria che tanti profitti aveva portato ai padroni del vapore, mentre tra gli uomini delle trincee di sviluppava il fenomeno del reducismo. Della vittoria mutilata, ma soprattutto della disillusione e delle aspettative tradite dopo anni di orrenda vita di fronte. Entrambi si contendevano il merito della vittoria pur all’interno di una visione radicalmente diversa del futuro. Come sappiamo l’esercito dei reduci, come accade inevitabilmente anche oggi sia pure in forme diverse e più ambigue, fu man mano arruolato dalla classe dirigente in difesa dei propri interessi e alla fine confluì nel fascismo che pareva loro come una continuazione dello spirito di trincea e una rivalsa nei confronti degli “imboscati”. Del resto lo aveva detto un singolare personaggio che negli anni della guerra e negli afflati camerateschi aveva trovato la sua strada: “i soldati sono proletari senza coscienza di classe”, una frase che sorprendentemente non appartiene all’universo rivoluzionario di quegli anni, ma ad Adolf Hitler che peraltro tentò nel 1919 di iscriversi al partito comunista, ma fu respinto in quanto testa eccessivamente calda.
Quello che è accaduto dopo è ben noto: gli industriali del nord si presero la rivincita sugli operai e dormirono sonni tranquilli al riparo da sindacati e rivendicazioni. Sonni tanto tranquilli e coperti dalla condiscendenza complice e opaca del regime e delle commesse di comodo, che nella successiva guerra mondiale riuscirono a compiere un altro miracolo: quello di dar vita a una produzione bellica del tutto marginale rispetto anche ai protagonisti minori del conflitto e per giunta di qualità pessima, salvo quando si accorsero che il bengodi era in pericolo. Ma certo qualcosa di quei giorni di un secolo fa lo si riconosce ancora oggi sotto le spoglie mutate di un Paese che dovrebbe ripudiare la guerra, ma si trova impegnato in molti conflitti e che vive alla giornata la sua inquieta pace.