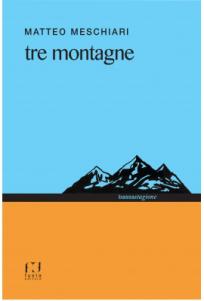
 Il canale bracco e Tre montagne. Scarti semantici
Il canale bracco e Tre montagne. Scarti semantici
_____________________________
di Stefano Costa
.
Ho aperto più volte su una pagina a caso “Tre montagne”, prova narrativa in tre tempi di Matteo Meschiari (pubblicato a fine 2015 da Fusta, editore indipendente di casa a Saluzzo, in provincia di Cuneo). L’esperienza è quella di una solida semantica, di una cerchia di termini e combinazioni che indagano – attraverso un’analisi che non esiterei a dire “scientifica” – la trasformazione del gesto in parola. Il gesto di cui si narra in tutti e tre i capitoli di quella che sembra essere, anche se non lo è appieno, un’unica storia, chiama lo stigma preistorico, il graffio fissato per sempre in una roccia – il segno che un essere umano può ritrovare a distanza di millenni, mutato nel tempo ma sempre uguale a se stesso. Tale il destino del fossile: quello di impoverirsi di tessuto muscolare, quello di veder asciugarsi il nervo che ne percorreva il dorso al fine di lasciar affiorare le informazioni criptate nella sabbia delle ossa, e in esse soltanto.
I tre tempi in cui l’autore si misura portano rispettivamente i titoli di “Svernamento”, “Primo Appennino” e “Pace nella valle”. Il primo e il terzo tempo narrano di “partite a due”, che sia l’ultima ascesa di un vecchio a una vetta che al lettore pare tale solo se rapportata alla mente dello scalatore, o che sia la battuta di caccia che un padre e un figlio conducono accompagnandosi all’usta della preda più che al lezzo del bracconiere… narrano di partite a due, si diceva, durante le quali il primo imperativo è dare un significato percorribile, calpestabile all’ambiente come alla battaglia.
La montagna non sembra più luogo fisico in quanto identificabile mediante le virtù della toponomastica, sembra – al contrario – un luogo sottratto all’identificazione toponomastica e al quale un’identità può essere riconsegnata solo battendo palmo a palmo la sassaiola che ne segna i sentieri, misurando con le dita la porosità o la levigatezza dei pietroni.
Persino la denominazione di “Primo Appennino”, il secondo tempo, fugge alla geografia per come la conosciamo e va a cercare quella gioia che è nel mito, e il mito è anche un’Italia occupata dal nazifascismo: se anche di essa rimanesse una lapide, non è da dimenticare che sarebbe sempre e comunque pietra.
La scrittura di Meschiari è percorsa dalla stessa tranquillità feroce che anima “Il canale bracco”, solo che attraverso il “Canale” la percorribilità del luogo è distesa, non verticale, e certo non solo poiché la fisica ci insegna che l’acqua non scorre da valle a monte. Mentre in Meschiari lo scarto di prosa si palesa in numerosi punti e il gestito narratologico si frange in dialoghi, narrazioni nella narrazione, ciuffi di diario… mentre in Meschiari questo scarto è riconoscibile nel salto che lo scalatore compie tra sasso e sasso o nell’avvicinare il naso al trattino di roccia segnato dal sangue animale, in Magliani la semantica della passeggiata illude il lettore che non sa, non si aspetta, quanto possa essere insidioso raccontare l’elemento umano quando già integrato nel paesaggio.
La montagna di Meschiari è infatti la risultante dei movimenti preistorici che hanno mosso esistenze tanto vegetali quanto animali, è il regno in cui la comparsa del manufatto è epifania (e non meno testimonianza) di un tempo che va percorso a ritroso. In Magliani invece il manufatto – l’umano – è talmente integrato da essere indistinguibile: il canale, non si capisce da dove nasce né dove muore, da che parte scorre l’acqua.
«La lettura di un canale va affrontata dal suo incipit. Ma come si fa a dire dove inzia il nostro? L’acqua è ferma, oppure la distribuiscono per mezzo di pompaggi, la fanno penetrare nelle chiuse con l’ingresso di una nave, ed è come se una volta scorresse verso Amsterdam e l’altra verso il Mare del Nord.» (M. Magliani, “Il canale bracco”, Saluzzo, Fusta editore, 2015, p.13.)
Nonostante sia la mano dell’uomo a comandare i pompaggi e le chiuse, sentiamo con quale spontaneità sia l’acqua stessa ad andare da una parte o dall’altra per un incontro tra la volontà propria e quella dell’ingegneria: come avviene quando orientiamo i passi di un bimbo verso una direzione che lui stesso desiderava già percorrere.
Magliani cammina e la ricerca che pone in essere, di animaletti come d’incroci di correnti profonde – tanto profonde da non spostare quasi l’acqua in superficie – ci dice del cuore di questo bellissimo testo, che sta nell’indagare l’avventura biologica all’interno di catene, piccole dighe, nastri di ferro.
Meschiari lascia invece camminare i propri personaggi, e li osserva per capire se riusciranno a indovinare con quale precisione si manifesta la declinazione antropica che sta nella montagna, il destino fatale che sta nel cervello del pianeta.
«Siamo diventati pazzi a forza di modellarci la mente sulla geografia della regione magellanica e siamo morti soli tra gli acquitrini del Nord America, dove non c’era niente che valesse la pena cercare tranne le forme della Terra.»
(M. Meschiari, “Tre montagne”, Saluzzo, Fusta editore, 2015, p.170.)
Seguire percorsi come questo è un gesto – anni fa vidi in televisione un famoso cartone animato Disney in cui un cane, appoggiando un orecchio al suolo, percepiva con precisione millimetrica il numero di piede di chi si stava avvicinando e in quale punto della suola aveva un buchino; anni fa lessi un romanzo in cui un pellerossa appoggiava un orecchio al binario per valutare la posizione della locomotiva: solo adesso comprendo che l’informazione non stava nell’abilità di chi ascoltava, ma nella mutata condizione dell’ambiente circostante. L’ambiente circostante può sdoppiarsi (com’è il caso di Magliani che si muove tra Noordzeekanaal e Ponente ligure) o sfrangiarsi (com’è il caso di Meschiari, che in “Primo Appennino” ne fa regione di riti e cori ancestrali) ma sarà sempre il suo movimento a indicarci la strada.

