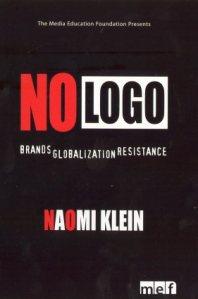Il rapporto tra i movimenti e la loro rappresentazione mediatica, dopo il 1989
 Prendi il telecomando, accendilo sul mondo, e non cambiar canale. Lascia le chiacchiere, sfuggi agli sguardi, procedi a testa bassa. Tienila al massimo ad altezza schermo, abbandona il confronto al bar della piazza. Quella piazza avara di pacche sulle spalle, prodiga invece di pugni e mazze apparentemente rudimentali, con l’atmosfera patinata da fiction d’azione. Prendi il telecomando, accendilo sulla rivoluzione. Vivila in diretta. Guardala in HD, seguila in streaming. Oppure, attendila come si attendeva una puntata di Dallas, a metà anni ottanta. Già, gli anni ottanta. Il decennio a effetto sisma che segnò la caduta delle ideologie, quelle sventolate, quelle urlate nei comizi, quelle tramandate dai padri e dai nonni. Quelle che ti facevano credere nel senso giusto delle cose, in un’idea di mondo migliore. Il motore del dissenso, che fino a quel momento risiedeva nella storia di crude e umane coscienze immerse in passioni autentiche, cambiò rotta.
Prendi il telecomando, accendilo sul mondo, e non cambiar canale. Lascia le chiacchiere, sfuggi agli sguardi, procedi a testa bassa. Tienila al massimo ad altezza schermo, abbandona il confronto al bar della piazza. Quella piazza avara di pacche sulle spalle, prodiga invece di pugni e mazze apparentemente rudimentali, con l’atmosfera patinata da fiction d’azione. Prendi il telecomando, accendilo sulla rivoluzione. Vivila in diretta. Guardala in HD, seguila in streaming. Oppure, attendila come si attendeva una puntata di Dallas, a metà anni ottanta. Già, gli anni ottanta. Il decennio a effetto sisma che segnò la caduta delle ideologie, quelle sventolate, quelle urlate nei comizi, quelle tramandate dai padri e dai nonni. Quelle che ti facevano credere nel senso giusto delle cose, in un’idea di mondo migliore. Il motore del dissenso, che fino a quel momento risiedeva nella storia di crude e umane coscienze immerse in passioni autentiche, cambiò rotta.
Già dai primi anni della nuova era, apparve evidente come i movimenti di contestazione cominciarono a seguire l’immaginario dello show mediatico. Si pensi alla contestazione studentesca del 1990, con quel movimento della “Pantera” che non aveva più alcun riferimento ideologico e sociale, ma qualche richiamo all’immaginario culturale americano, riprendendo il nome delle famose “Black Panthers”, che negli anni sessanta
rivendicavano a suon di violenza i diritti degli afroamericani residenti negli States. Si pensi all’introduzione di nuovi mezzi di comunicazione, come il fax, che soppiantò il vecchio ciclostilato battuto su vecchie macchine da scrivere. Insomma, la contestazione non era più strumento di umana protesta, ma effetto di una propaganda. Nel 2000,
Naomi Klein con il suo saggio “No Logo” indicò quali furono i disastri del nuovo capitalismo, disposto ad incentrare i suoi aspetti sul fenomeno del branding. L’opera, considerata “la Bibbia del movimento No Global”, sancì l’inizio della battaglia contro le multinazionali del brand. L’errore, però, fu quello di non accorgersi che lo stesso dissenso era diventato un brand, già da un decennio. Il dissenso omogeneizzato, mescolato ad arte come un marketing ossessivo. Un dissenso che danza tra il social-network, il giornalismo partecipativo, appoggio di intellettuali, dirette streaming. Il dissenso che entra in salotto, e che si diffonde con gli stessi metodi del capitalismo più sfrenato. Un grande circo, su cui si accendono le spie alle telecamere, si mette in atto il sequel della contestazione. Scenografia differente, sceneggiatura consona ai tempi. Primavere Arabe al posto di Autunni delle Nazioni, indignazione e studenti incazzati, simboli di unità a stender lenzuola su un passato vivo e pulsante, nella forma più che nel contenuto. La protesta di
Belgrado del 2001, quella che cacciò Milošević. Le rivoluzioni colorate in Ucraina, Bielorussia, Iran. Le società di consulenza per la rivoluzione, come “Optor!”. Il pugno chiuso serbo, che diventa egiziano, newyorkese, madrileno. Romano. Tutto con l’appoggio dei potenti, non più nemici della rivolta, ma sponsor. Le riunioni degli artisti e degli intellettuali, a prestare volti come un qualsiasi testimonial di una qualsiasi marca di profumo, o di biscotti. I rivoltosi che diventano personaggi da fumetto riconosciuti dalla pelliccia. La violenza nelle piazze, l’ipocrisia nelle dichiarazioni. I buoni a casa, i cattivi in strada. L’espansione dei media, l’espansione della bugia. Una carta ingiallita ristampata con un progetto valutato migliore, ma senza consultazione. Un progetto indotto e consumato in salotto, sfruttando i prodromi del formato fiction.

La fiction formato sequel, quella della nostra era, quella interattiva, con l’abito del Grande Fratello: tu sei dappertutto, tu sei stufo, tu sei arrabbiato. Dal 1989, passando per il 2001, e arrivando al 2011. Ieri le cortine, oggi Wall Street. Ieri la tivvù, oggi il social network. Ieri pianificazione, oggi pure. Tu partecipi, ma tu“non esisti”. E così, come scriveva il ribelle Emmanuel Goldstein, «Nessuno ha mai visto il
Grande Fratello. È un volto sui manifesti, una voce che viene dal teleschermo. Possiamo essere ragionevolmente certi che non morirà mai. Già adesso non si sa con certezza quando sia nato. Il Grande Fratello è il modo in cui il Partito sceglie di mostrarsi al mondo. Ha la funzione di agire da catalizzatore dell’amore, della paura e della venerazione, tutti sentimenti che è più facile provare per una singola persona che per una organizzazione». In cima alla gerarchia piramidale, dunque. E allora prendi il telecomando, accendilo sul mondo, e guarda il Grande Occhio che spettacolo ti mette in scena, puntata dopo puntata.
(pubblicato su Gli Altri Settimanale del 28 ottobre 2011)
 Prendi il telecomando, accendilo sul mondo, e non cambiar canale. Lascia le chiacchiere, sfuggi agli sguardi, procedi a testa bassa. Tienila al massimo ad altezza schermo, abbandona il confronto al bar della piazza. Quella piazza avara di pacche sulle spalle, prodiga invece di pugni e mazze apparentemente rudimentali, con l’atmosfera patinata da fiction d’azione. Prendi il telecomando, accendilo sulla rivoluzione. Vivila in diretta. Guardala in HD, seguila in streaming. Oppure, attendila come si attendeva una puntata di Dallas, a metà anni ottanta. Già, gli anni ottanta. Il decennio a effetto sisma che segnò la caduta delle ideologie, quelle sventolate, quelle urlate nei comizi, quelle tramandate dai padri e dai nonni. Quelle che ti facevano credere nel senso giusto delle cose, in un’idea di mondo migliore. Il motore del dissenso, che fino a quel momento risiedeva nella storia di crude e umane coscienze immerse in passioni autentiche, cambiò rotta.
Prendi il telecomando, accendilo sul mondo, e non cambiar canale. Lascia le chiacchiere, sfuggi agli sguardi, procedi a testa bassa. Tienila al massimo ad altezza schermo, abbandona il confronto al bar della piazza. Quella piazza avara di pacche sulle spalle, prodiga invece di pugni e mazze apparentemente rudimentali, con l’atmosfera patinata da fiction d’azione. Prendi il telecomando, accendilo sulla rivoluzione. Vivila in diretta. Guardala in HD, seguila in streaming. Oppure, attendila come si attendeva una puntata di Dallas, a metà anni ottanta. Già, gli anni ottanta. Il decennio a effetto sisma che segnò la caduta delle ideologie, quelle sventolate, quelle urlate nei comizi, quelle tramandate dai padri e dai nonni. Quelle che ti facevano credere nel senso giusto delle cose, in un’idea di mondo migliore. Il motore del dissenso, che fino a quel momento risiedeva nella storia di crude e umane coscienze immerse in passioni autentiche, cambiò rotta.