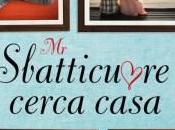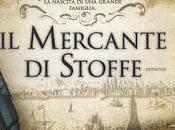Un esegeta (exēgētḗs) è una semplice guida nella giungla del significato. Un hermēneutikós è alleato di Hermes, il dio messaggero, che induce nuovi significati. Hermes come Indra, è grande in furbizia e ironia. “Il nostro Dio è un fuoco che consuma” dice L’epistola agli Ebrei citando la Bibbia ebraica. R. P.
Nel 1992 in occasione di un simposio tenutosi a Vivarium (Tavertet) nell’ambito di un intervento in difesa della lingua catalana Raimon Panikkar, sentì il bisogno di racchiudere inizialmente il suo contributo in pochi versi, che premise come riassuntivi di quanto aveva da dire. A ciò seguì una messa in prosa di quei versi con cui Panikkar riteneva di ripetere un concetto importantissimo di cui la breve poesia iniziale era tuttavia una sintesi esaustiva. Ai fini del discorso di Panikkar, quell’intervento aveva un carattere di tale importanza che quando nel 2007 pubblicò il libro Lo spirito della parola, fu proprio quel contributo in favore di una lingua minoritaria, oltre che il metodo che aveva scelto, la premessa per un messaggio che partendo dalla particolarità geografica di una minoranza linguistica, voleva indirizzarsi a un ascolto molto più ampio. Panikkar nacque a Barcellona nel 1918 da madre spagnola e padre indiano indù. Sacerdote cattolico dal 1954, ricercatore e insegnante universitario in molti paesi tra cui l’Italia, dedicò la sua vita alla filosofia della scienza, alla metafisica, al dialogo tra culture e religioni con la pubblicazione di oltre quaranta libri. Una delle immagini più belle usate ne Lo spirito della parola, un libro importante da leggere per chi ama la poesia, è quella relativa alla parola vocabolo, inteso come sinonimo di definizione. Nella specifica e in tutto il relativo mondo che il significato di un termine delimita, Panikkar, riscontra la crudeltà di un atto simile al tagliare le ali a un uccello. Viene da pensare alla suggestione che questa immagine offre soprattutto in senso poetico. Il significato di una parola in quanto enunciato umano, non può essere limitato alla sua etimologia che è un dato scientifico. Questo perché c’è la voce che concerne quell’enunciato che alimenta pure una parola ancora da scriversi. E oltre la voce di chi la dice, c’è l’orecchio di chi ascolta a mutare quella parola in un elemento carico di un potenziale indipendente altrimenti che dall’ipotesi di scambio rappresentata da una fluttuazione acustica, visibile quindi a suo modo attiva. Concetti come coerenza, mantenimento di una continuità, approfondimento, sono relazionabili a una modalità di adesione conscia, volontaria, deliberata, che non appartiene in nessun modo alla poesia. Questi concetti puramente intellettuali o funzionali rispetto a un fine pratico, come potrebbero essere inseriti in una sintassi del tutto permeabile a un potenziale in cui una sola parola è fatta genitrice di un intero discorso? Un discorso che dipende solo dal possibile dialogo che quella parola stabilisce essendo scritta in modo scevro dell’intenzione di significare, ed essendo impegnata profondamente in un dire che è comunque dimentico. Un dire che al di fuori del suono, e del sentore che quel frammento eredita da una storia dal principio inconoscibile, è spesso un detrito che ha nella pronuncia tutta l’opacità di una rimozione. Una poesia quando dice qualcosa che necessariamente deve e può essere trasferito in una sintassi che la rispecchia, si trova a riflettere, spesso nonostante il poeta, una verità in cui altri si riconoscono con una naturalezza insospettabile. E ciò accade senza che chi l’abbia scritta, incarni nella sua persona quella verità. Perché se un poeta avesse deliberatamente l’intenzione di dire cose vere, mentirebbe peggio che stonando col risultato piuttosto comune di deturpare il silenzio.
____
Lo spirito della parola, Raimon Panikkar, Bollati Boringhieri editore p. 19, 20
La parola non è parola/ se non vi è chi la pronunci;/la parola è parola solo quando c’è chi la ascolta. /La parola è voce solo/ quando rompe il mutismo cosmico/ diffondendosi nel suo suono. / Questo qualcuno però dice qualcosa/ che nella musica si incarna./ Questo qualcosa è il grido/ dell’Essere stesso che è la parola.
Lo ripeto in prosa:
Tra l’Essere e la Parola la relazione è costitutiva. Essere e parola non sono due; non si possono separare. Non sono nemmeno uno; non si possono confondere. La relazione è advaita (aduale); è trinitaria, l’Essere parla; e la Parola non gli è inferiore.
Questa relazione si rispecchia nelle cose. Ogni cosa ha il suo vocabolo e ogni vocabolo dice una cosa. Il vocabolo non è la cosa, ma la dice. La cosa non è il vocabolo ma è essa che la realizza.
L’uomo è un essere che parla e parla perché pensa, ma anche pensa perché parla. Se pensassimo allo stesso modo parleremo allo stesso modo e viceversa. Quando un popolo non ha nulla di suo da dire non ha bisogno di una sua propria lingua. E non avrà nulla da dire se non pensa autonomamente. E non penserà autonomamente se la sua vita imita uno stile altrui. Questo è il nostro tema.