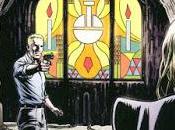già pubblicato su ventisei barrato

Questo accade anche quando uno scrittore alle prime armi (o che non si sia fatto certe domande) cerca di descrivere una scena. Ci sono troppe cose a cui pensare, descrizioni di ambienti o circostanze in cui calare i personaggi o le considerazioni, e così si cade nei cliché: la bionda tipica, il bello e impossibile, il buono sfigato, il funerale con la pioggia, il bambino innocente. La richiesta più frequente che un editor possa fare oggi a uno scrittore, mi pare, è «dimmi qualcosa che non so, quello che so non scriverlo, non esiste». E troppe persone (mi metto nel gruppo) sono tentate dallo scrivere che il cielo è blu, che la risata dei bambini è rinfrancante, che stendersi su un prato è bello. Quale cielo? Blu come? Il cielo sopra quale città o paese? Che bambino è? Ha tutti i denti? Cosa intendi per bello, il prato è senza cacche o lumache? Perché hai sentito il bisogno di menzionare cose vaghe? Se non sai maneggiare il vago, se non sai essere ellittico, se la tua vaghezza è semplicemente mancanza di argomenti, di parole, di precisione, salta subito all’occhio e tu non hai scritto niente.

Uno scrittore sapiente non deve necessariamente descrivere in modo minuzioso ogni cosa: anche la vertigine della lista così presente in Perec è una cifra stilistica, non una soluzione universale al problema. Perec usa la lista come dimostrazione dell’indocilità del reale, in cui ci si può solo perdere affinando la vista. Mi trovo in un salotto e se fisso lo schermo sento attorno a me solo il beige della carta da parati, ma spingendo lo sguardo verso il tavolo noto per la prima volta che ha delle gambe bizzarre, unite in una colonna che poi si dipana in quattro zampe con i piedi dorati. Le zampe hanno una sottile scanalatura con una foglia in finto oro applicata sopra, sono curve. Il legno è abbastanza lucido, scuro, le venature rossastre mi fanno pensare che sia ciliegio o una cosa simile. Se fisso a lungo quelle gambe penso che potrebbero muoversi e scappare, e che il tavolo sembra un ragno. Potrei descrivere tutta la stanza, potrei descriverla nei particolari e poi riscrivere il pezzo in dieci modi diversi. È una via di scrittura, è una dichiarazione d’intenti che mi fa pensare a quando Wittgenstein diceva che la filosofia non aggiunge nulla alla realtà. La scrittura dovrebbe riuscirci? Per me questo è ancora un grande quesito, e mi sento ancora al bordo della piscina rispetto a chi nuota e scrive senza paura (il fatto che ci pensi sopra non significa che prima o poi mi tufferò, naturalmente).

Si arriva all’iceberg, che non si rilegge mai abbastanza: «If a writer of prose knows enough of what he is writing about he may omit things that he knows and the reader, if the writer is writing truly enough, will have a feeling of those things as strongly as though the writer had stated them. The dignity of movement of an ice-bergis due to only one-eighth of it being above water. A writer whom its things because he does not know them only makes hollow places in his writing.»
Quindi osservare, scrivere, togliere. Non osservare, scrivere, perdersi (ci si perde consapevolmente, ci si perde fermandosi, o ci si lascia andare quando si ha veramente polso e mano). La scrittura è combattimento e felicità. Tutte queste cose, e molte altre, sono spiegate nel fondamentale Il realismo è l’impossibile di Walter Siti, su cui vorrei scrivere di più senza riuscirci, perché ha toccato una corda profondissima, lasciandomi mezza muta e molto pensosa.

«Perché, avendo a disposizione millenni di storia e decenni di cronaca, un narratore sente il bisogno di inventarsi una storia in più, una storia che non è mai accaduta ma sarebbe potuta accadere? Perché questa storia fittizia, per qualche causa oscura, è più esemplare delle storie vere, contiene più significati in un rapporto più coerente e armonioso; perché può ammaestrare e far capire cose che giacciono nell’universo personale e collettivo; perché la realtà così alterata e messa in forma è più buffa, o più tragica o più commovente di quanto la realtà nuda e cruda non sia stata mai. La narrazione fittizia ci offre un cosmo e non un caos, una realtà controllabile e finita, un facsimile di realtà commisurato a quegli dèi minori che crediamo di essere nei nostri deliri di onnipotenza. L’universo alternativo della narrazione è composto da molti meno elementi dell’universo reale; il mondo rappresentato in un racconto fittizio è sempre il frutto di una selezione.»
Il realismo è l’impossibile – Walter Siti
Nottetempo, 2013
pp.88 , 6,00 euro