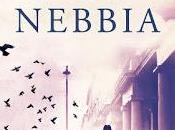Le parole del tempo e la letteratura. Gualberto Alvino. La parola verticale. Pizzuto, Consolo, Bufalino, con una prefazione di Pietro Trifone, Napoli, Loffredo, 2012
Le parole del tempo e la letteratura. Gualberto Alvino. La parola verticale. Pizzuto, Consolo, Bufalino, con una prefazione di Pietro Trifone, Napoli, Loffredo, 2012
_____________________________
di Giuseppe Panella*
.
La poesia e la letteratura è composta della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni e gli stati d’animo. Ma, a parte l’aspetto affettivo e dei sentimenti espressi in ragione di essi, è intrinsecamente costituita di parole. Nell’analisi della scrittura letteraria non si può fare a meno di soffermarsi su di esse, sulla loro natura, sulla loro vita, sulla loro origine, sulla loro specificità. Di conseguenza, i poeti e gli scrittori possono usarle attingendole al parlato quotidiano, all’usuale composto utilizzato per comunicare ogni giorno con gli altri in tutte le situazioni concrete del vivere associato oppure attingere al grande patrimonio lessicale della tradizione culturale cui tutti partecipiamo ma di cui molto spesso ci dimentichiamo invece di usarlo. Gualberto Alvino ha deciso di dedicare la sua operosità erudita e la sua sapienza di studioso alla ricerca delle occorrenze linguistiche presente nelle opere di tre grandi autori meridionali (tutti siciliani, per l’esattezza) e di verificarne la puntualità, l’invenzione e, come dice il titolo della sua raccolta di saggi, la “verticalità”. Ma Alvino non solo ha portato a termine questa sua ricerca nella modalità sua propria di filologo (e cioè di “lettore lento” – come scrive Nietzsche nella sua Prefazione a La nascita della tragedia) ma l’ha anche arricchita con un saggio, un Dialogo tra lo Scettico e il Fautore, in cui giustifica more teoretico l’assunto della sua prospettiva di studi.
«FAUTORE. Lo stile, egregio signore, lo stile è l’unica realtà estetica. Se la letteratura è un fatto di lingua il suo proprium consiste nell’organizzazione formale dei contenuti, non già in questi. Scusi se adopero termini d’antiquariato, ma il vero e solo significato si annida fra le crespe del significante. Ormai dovrebbe essere un dato universalmente acquisito, invece, a quanto pare…
SCETTICO. Non lo nego. Ma un’opera narrativa che si sottrae all’immediata comprensione (anzi, alla comprensione tout court) cos’altro è se non clamoroso controsenso? Lei pone la questione in termini troppo drastici: Pizzuto sì, Pizzuto no. E suppone che io ne sia un detrattore. Non è così, o perlomeno non del tutto. C’è un Pizzuto uno e un Pizzuto due… » (p. 77).
Alvino non sembra convinto della necessaria divisione in due dell’opera dello scrittore palermitano (operazione spesso considerata necessaria da certa critica pizzutiana) e tende a leggerla, sulla scia degli studi magistrali di Contini, come un tutto unico in cui il flusso del reale viene colto attraverso l’uso intensivo del ritmo e della musica e non attraverso la resa concreta delle articolazioni delle storie narrate. In realtà, sia lo Scettico che il Fautore, entrambi formatisi evidentemente ad una scuola di critica letteraria non storicistica, concordano nel definire straordinarie e mirabili certe soluzioni letterarie presenti nell’opera di Pizzuto ma il primo tende a non comprenderne la necessità assoluta nell’ambito della sua poetica mentre il secondo prova a far convergere tutta l’opera dello scrittore in una sorta di dimensione altra rispetto alla tradizione della narrativa italiana. Quello che Alvino vuole mettere in evidenza è la natura specificata della proiezione linguistica utilizzata da Pizzuto per ricostruire i mondi plurimi e personali che vuole esplorare e questo a partire dalla svolta rappresentata dal romanzo Ravenna del 1962. La figuratività presente nelle opere pizzutiane a partire da Paginette del 1964 sembra ad Alvino un punto di non ritorno nella letteratura italiana del Novecento e una confutazione del supposto astrattismo totale dello scrittore:
«FAUTORE. Astrazione? L’esatto contrario. Il suo mondo è popolato di pensionati, casalinghe, muratori, impiegati, caldarrostai, maestrie, vedovelle e lor consolatori, galline, agli, tartufi, veglie, “prosciutti cotti un pochino”, in pacifica convivenza con mostruose elucubrazioni circa i massimi sistemi. Ecco, allora, le galline farsi democratiche, l’aglio trionfatore, romualde le veglie: donde lo spaesamento, la suprema ironia e il conseguente effetto di nebulizzazione informale, di cubistica scomposizione» (p. 86).
Preoccupazioni non dissimili riguardo alla scrittura si porrà Alvino rispetto all’opera di Vincenzo Consolo, anche se nel caso di quest’ultimo la ricerca si addensa maggiormente sul livello espressivo della contaminazione linguistica piuttosto che sulla sua trasformazione figurativa (come avveniva, et pour cause, per Pizzuto).
In Consolo, il critico ritrova, infatti, una lingua, il siciliano usato nei suoi romanzi più riusciti, tutt’altro che proteso verso il realismo di una scrittura impegnata nell’opera di ricostruzione e di “redenzione” della realtà quanto piuttosto inteso ad una resa impressionistica e “decisamente demotica”dello stile utilizzato nei suoi romanzi:
«Fin dalla prima comparsa [in La ferita dell’aprile del 1963] la portata dell’operazione fu d’altronde subito patente: rara perizia nell’amministrazione della cosa linguistica; ripudio dei modelli narrativi tradizionali – segnatamente del genere romanzo –, con la conseguente attivazione d’uno sperimentalismo convulso, non immune da tentazioni eversive; esuberanza dell’elemento retorico con annessa eterogeneità degli ingredienti cromatici; intrepida mescolanza di codici; esaltazione del livello fonosimbolico, esibito come pura virtualità, crudo istituto, citazione culturale; preponderanza dell’interesse formale congiunta al più sfrenato edonismo pluristilistico. Un’olla putrida ribollente di tensioni difformi, talora esorbitanti da una schietta urgenza poetica, su cui incombe costantemente il pericolo del feticismo lessicale, del funambolismo sintattico e, se si potesse dire, della glottolatria» (pp. 96-97).
In Consolo, secondo l’interpretazione di Alvino, dopo un esordio sotto il segno di una ricerca di scrittura che rivelava e correggeva in senso inverso la pur presente tentazione realistica riversando sulla pagina una prorompente verbigerazione che la rovesciava e la riverberava, la dimensione linguistica barocca (e manierista) delle opere successive, a partire da Il sorriso dell’ignoto marinaio del 1976 fino a L’olivo e l’olivastro del 1994, prevale con prepotenza e produce una sorta di superfetazione linguistica che lo porta a utilizzare, modificare, inventare, riproporre e manipolare una grandissima quantità di termini dialettali o di nuovo conio. In ciò simile a Pizzuto, in realtà, Consolo se ne differenzia perché la torsione linguistica in lui presente va più per aggiungere (e mettere) che per “levare” come accade nelle torsioni presenti nell’opera pizzutiana.
Bufalino, invece, utilizza fin dal suo fortunato esordio con Diceria dell’untore del 1981 una lingua fortemente mescidata in cui tutto il patrimonio letterario italiano confluisce in un’ottica di recupero e di riutilizzo inteso a rivalutarne la vitalità e non certo a soli fini antiquari (come pure gli è stato sovente rimproverato nella non numerosissima bibliografia a lui dedicata).
«Comparata al modulo ordinario, è certo che la lingua di Bufalino si connota per una insaziata ricerca d’inattualità, una disperata fuga dal presente posta in essere mediante vistosi sovvertimenti topologici affatto incomprensibili fuori dall’istanza ritmica, tale intendendo non già l’edificante laccatura d’una sonorità additiva e tutta esteriore, ma signoria della misura sull’impulso, equilibrio architettonico e tonale, desiderio di rifondazione d’una civiltà letteraria» (p. 133).
Come in Pizzuto e sovente in Consolo, la ritmicità della parola utilizzata consente la creazione di assonanze e di risonanze nuove e inedite non tanto nelle soluzioni quanto nelle rievocazioni. Schematizzando forse un po’ brutalmente, se la parola in Pizzuto è creativa (soprattutto di altre espressioni), in Consolo è basata su accumulazioni e avvolgimenti (il suo barocco è poi fondamentalmente questo) e in Bufalino è riepilogativa di un passato letterario non soltanto italiano che cerca, attraverso la sintesi operata, di riannodare le fila in vista di una nuova tessitura.
Sulla scia della richiesta di Contini di focalizzare la ricerca su un aspetto “unico” dell’autore studiato ma in modo tale da abbracciarne l’”integrità” dell’opera e provarsi in questo modo, a spiegarla (e in questo il grande critico riprendeva, in parte, il modello proposto da Auerbach in Mimesis), Alvino ha trovato nella ricerca lessicale e nel censimento che ne è risultato lo strumento più adeguato al suo proposito di dare una lettura dei suoi “auttori” nella profondità del testo. Compito improbo e probabilmente in-finito ma necessitato dalle urgenze di un progetto critico che voglia dirsi effettivamente tale.
_____________________________
[Leggi tutti gli articoli di Giuseppe Panella pubblicati su Retroguardia 2.0]
_____________________________
*Il primo sguardo da gettare sul mondo è quello della poesia che coglie i particolari per definire il tutto o individua il tutto per comprenderne i particolari; il secondo sguardo è quello della scrittura in prosa (romanzi, saggi, racconti o diari non importa poi troppo purché avvolgano di parole la vita e la spieghino con dolcezza e dolore); il terzo sguardo, allora, sarà quello delle arti – la pittura e la scultura nella loro accezione tradizionale (ma non solo) così come (e soprattutto) il teatro e il cinema come forme espressive di una rappresentazione della realtà che conceda spazio alle sensazioni oltre che alle emozioni. Quindi: libri sull’arte e sulle arti in relazione alla tradizione critica e all’apprendistato che comportano, esperienze e analisi di oggetti artistici che comportano un modo “terzo” di vedere il mondo … (G.P.)