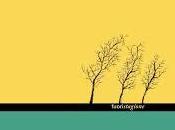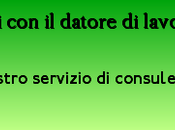Edito da Rubbettino Editore nella collana Cinema. Lo schermo e la storia, il libro In nome della legge. La giustizia nel cinema italiano (2013) presenta, in forma di saggio, un’attenta analisi che trova il suo punto di partenza nella domanda posta da Guido Vitiello, curatore del volume, se sia possibile individuare nella filmografia italiana l’esistenza di un genere courtroom drama sulla scia del cinema americano, un format riproducibile ed adattabile alle diverse sceneggiature, nella ricorrenza ben precisa di ruoli, stili ed iconografia, che metta al centro della narrazione quanto si svolge all’interno dei tribunali.
Edito da Rubbettino Editore nella collana Cinema. Lo schermo e la storia, il libro In nome della legge. La giustizia nel cinema italiano (2013) presenta, in forma di saggio, un’attenta analisi che trova il suo punto di partenza nella domanda posta da Guido Vitiello, curatore del volume, se sia possibile individuare nella filmografia italiana l’esistenza di un genere courtroom drama sulla scia del cinema americano, un format riproducibile ed adattabile alle diverse sceneggiature, nella ricorrenza ben precisa di ruoli, stili ed iconografia, che metta al centro della narrazione quanto si svolge all’interno dei tribunali.
Nelle pagine successive all’introduzione vengono fornite al riguardo diverse risposte, anche da altri autori (Giovanni Damele, Andrea Perrgolari, Andrea Minuz, Anton Giulio Mancino, Giovambattista Fatelli, Isabella Pezzini, Milly Buonanno, Christian Ruggiero e Alessandro Perissinotto), analizzando una serie di pellicole, sino ad arrivare a scandagliare il mondo del piccolo schermo, tra fiction, processi televisivi e criminality show imbastiti intorno ai casi di cronaca nera, offrendo validi spunti di riflessione, che vanno al di là dei film esaminati, acquisendo valore d’approfondimento storico- sociologico.

Proprio da quest’ultimo occorre infatti necessariamente partire, perché il nostro processo, legato alla tradizione inquisitoria (per quanto in forma “mista”, dopo la riforma dell’89), ha un funzionamento difficile da rendere come “spettacolo”, già in fase di sceneggiatura. Il sistema accusatorio proprio dei paesi anglosassoni, ben si presta invece ad un’alta resa drammaturgica, mettendo in scena il classico scontro bene/male, con due parti, rappresentate dai rispettivi avvocati, che lottano per stabilire la loro versione individuale dei fatti, rafforzata in base ai diversi punti di vista legali e alla giurisprudenza consuetudinaria (“i precedenti”), la quale aggiunge un surplus narrativo.
Da non dimenticare poi, l’eventuale possibilità di una condanna a morte dell’imputato, spesso giocata sul filo della suspense, i ruoli del giudice come arbitro, dell’avvocato “eroe” nel difendere la vita del suo assistito ed infine della giuria, che si pone allo stesso livello dello spettatore cinematografico riguardo le emozioni espresse su quanto sta avvenendo in aula (La parola ai giurati, Twelve Angry Men, ’57, Sidney Lumet).

Stilisticamente e visivamente appare strutturato come un classico western, rivisitato sulla base della location siciliana, ma l’eroe giunto in un territorio di frontiera non riesce a soverchiare le antiche consuetudini ed imporre la legge.
Quest’ultima viene vista come un intralcio, un apporto burocratico “importato” dal rappresentante dello Stato centrale, il pretore Guido Schiavi (Massimo Girotti), il quale riuscirà ad applicarla solo nella forma di un patto col suddetto sistema consuetudinario e per di più non nel luogo deputato, ma sulla pubblica piazza, dove nel finale chiamerà a raccolta tutti i cittadini, una volta che gli uomini di Turi Passalacqua (Charles Vanel) hanno fatto fuori un ragazzino che aveva collaborato con lui.



Una curiosa illusione ottica, per cui sotto la luce della legge molti comportamenti comuni possono definirsi criminali, quando la luce si fa fioca o si spegne gli stessi comportamenti sembrano delineare un sistema di relazioni a suo modo funzionante, se non propriamente civile”.
In questa rappresentazione il cinema italiano, nella sua caratteristica capacità d’intuire gli eventi, non sempre esplicata validamente nel raccontarli una volta avvenuti, è stato in grado, con modalità diverse, di raffigurare un dramma, senza attenuante alcuna.