Con l’intervista a Paolo Piccirillo concludiamo il nostro approfondimento su uno dei più promettenti talenti letterari della sua generazione.
Qui la nostra recensione di Zoo col semaforo.
Qui la Copertina.

Paolo Piccirillo
Paolo Piccirillo è nato a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, nel 1987. Dopo aver studiato Filosofia a Firenze si è trasferito a Roma, dove ha cominciato a studiare sceneggiatura cinematografica. Viene selezionato per partecipare al XIII corso di perfezionamento per sceneggiatori Script/Rai. Contemporaneamente pubblica il suo primo romanzo, Zoo col semaforo (Nutrimenti, 2010), entrando nella lista dei migliori scrittori italiani under 40 stilata da «Il sole 24 ore». Il 2013 è l’anno del suo secondo romanzo, La terra del sacerdote (Neri Pozza), una storia durissima e acre, densa di colpe e delitti, sudore e fango, segreti e confessioni. La morte si alterna alla vita, l’abbrutimento dell’ignoranza alla speranza della ragione. Una storia antica che sembra arrivare da un altrove distante, ormai scomparso. Una storia dell’oggi, invece, che ci scorre accanto e ci fa tremare. Una storia di dolore e orrore, di rimorsi e rimpianti. Ma anche di amore. Una storia che aiuta a ripristinare gli equilibri tra desideri, frustrazioni e ambizioni.
Quali aggettivi sceglieresti per descrivere Paolo Piccirillo?
Trovo delle difficoltà a definirmi attraverso aggettivi, diciamo che tendo a farlo solo con i miei personaggi, e a volte neanche ci riesco. Un aggettivo però sento di poterlo scrivere con sicurezza: curioso. Sono estremamente curioso, è quasi una malattia.
Il tuo esordio come scrittore, con il romanzo Zoo col semaforo, è arrivato a soli ventitré anni. Si parla spesso di quale sia l’età giusta per ritirarsi dalla scrittura, invece non ci si chiede mai quale sia l’età giusta per iniziare. Ma è corretto parlare di “età anagrafica” per uno scrittore?
Io credo che un neonato abbia cose interessanti da raccontare quanto quelle di una persona anziana. Voglio dire che tutti noi, a qualsiasi età, abbiamo storie dentro. Qualsiasi vita è traducibile in letteratura, e questo non ha nulla a che fare con gli anni vissuti, né in che modo si sono vissuti. Sono contento di aver pubblicato così presto: sono ambizioso e quindi più anni ho davanti a me e meglio è.
Hai raccontato in altre interviste che da bambino avevi una sola passione, il pallone. Non solo non sei diventato un calciatore, ma nei tuoi libri non se ne trova traccia (ad eccezione dei campi da calcetto di Carmine Schiattamuort’ in Zoo col semaforo). Come nasce quindi la tua passione per la scrittura? Sempre che di passione si tratti.
Non so proprio da dove nasca questa passione. Quello che so è che da ragazzino guardavo tanti film e subito dopo averli visti avevo un gran voglia di farne uno anche io. Mi informai, capì che il primo passo per fare un film era scrivere la sceneggiatura e allora iniziai a scrivere. Avevo quattordici anni e tentavo piccole sceneggiature. Poi arrivarono i primi racconti. Il calcio continua a far parte tanto della mia vita, e nei miei romanzi ci saranno sempre dei piccoli riferimenti visivi al mondo del pallone (anche in La terra del sacerdote: il museo della Mercedes è attorniato da campi di calcio).
In una recente presentazione di La terra del sacerdote i due conduttori si sono prodigati nel citare autori cui si ispirerebbe la tua scrittura, da Giovanni Verga, Carlo Levi, Giovanni Consolo, Cesare Pavese fino a Cormac McCarthy. Nel tuo sorriso un po’ meravigliato si leggeva un “se lo dite voi…”. Invece tu che cosa dici?
Il punto è che io non sono in grado di avere una percezione oggettiva e razionale della mia scrittura. E forse neanche mi interessa, anzi, sicuramente non mi interessa averla. Ti posso dire quali sono, per ora, i fari del mio percorso di crescita: Cortázar, Almodovar, Kusturica, Calvino, e ovviamente Fabrizio De Andrè, che ha contribuito, in tenera età, a farmi capire che non esiste il bene assoluto e il male assoluto: una lezione d’oro per chi nella vita vuole raccontare storie.
Sempre in quell’occasione, per scoraggiare qualsiasi ricerca di autobiografia nei tuoi romanzi, hai detto che scrivi storie che non conosci, è questa la magia della scrittura. Lo scrittore quindi è un artigiano della fantasia, si cimenta con la narrazione dell’immaginazione, è colui che riesce a rendere credibile e reale ciò che non esiste. Per dirla con Elias Canetti: «Una storia ben inventata è comunque una storia, non una bugia». Come definiresti il tuo essere scrittore?
Passo le mie giornate in compagnia di personaggi che esistono solo nella mia testa e molto educatamente mi chiedono un contesto in cui farli vivere. È così il mio essere scrittore, molto semplice e pulito, anche infantile forse. Non ho secondi fini quando scrivo. A me piace inventare, e la scrittura è il modo più semplice e rapido per capire se le mie invenzioni funzionano.
Già il titolo del tuo esordio, Zoo col semaforo, suscita curiosità. Perché questa scelta?
Fu una scelta interna al romanzo. Nel primo capitolo della storia c’è un serpente che si attorciglia a un semaforo. E da lì il titolo.
Nel libro ci si imbatte in una sorta di bestiario contemporaneo dove uomini e animali si alternano sul palcoscenico dell’esistenza, la prospettiva si capovolge. L’anatra che sceglie di vivere in un’officina di automobili, un granchio strabico che riesce a guardare solo in avanti e non vede i pericoli, un cavallo in fuga da una tromba d’aria che corre verso una campagna azzurra (una piscina) dove muore annegato, un polipo che esce dall’acquario per raggiungere invano il mare, una spigola che è attratta dalla luce del sole e decide di ingoiare una sconosciuta “acciuga gialla e rossa”. Animali che compiono una scelta, animali che mostrano una coscienza. Una originale metafora per rappresentare che cosa?
Per raccontare, a modo mio, l’istinto. Gli animali vivono di istinto, ma nell’abitudine del loro istinto, può esistere un istinto dell’istinto, che per me sono i sentimenti, una specie di corto circuito del quotidiano, dell’ordinario. Questo vale per gli animali ma anche per gli esseri umani, secondo me.

Perché nell’immaginario comune il pitbull rappresenta l’istinto più feroce, come se vivesse solo di cattiveria e voglia di sangue. Trasformandolo immediatamente in una vittima, e quindi facendo subito fidelizzare il lettore al pitbull, ho voluto mettere le carte in chiaro: non esiste il male assoluto, esistono solo vite da non giudicare.
Zoo col semaforo non è solo una storia di animali, ma anche e soprattutto una storia di uomini, disperati e spietati, sullo sfondo ci sono i traffici della camorra, l’impossibilità di una vita regolare per chi fugge da una terra ostile e arida di futuro, l’emarginazione fisica e morale delle periferie urbanizzate. Ci sono miseria, dolore, solitudine, una lotta costante per la sopravvivenza. Chi ne esce e come da questa lotta?
È una domanda molto complessa questa. Per risponderti al meglio dovrei essere o un filosofo, o un povero cristo che non ha cosa mettere a tavola la sera. Evidentemente non sono né uno né l’altro. Perciò al massimo ti posso dire la mia da osservatore del circostante. Io credo molto nella volontà. La forza di trovare soluzioni diverse alla sofferenza, che poi diventa abitudine. Ci si abitua a tutto: alla solitudine e allo schifo di certi territori in cui ci si è ritrovati a nascere. Il punto è questo, non accettare l’abitudine come un dato di fatto, non aver paura che il cambiamento sia sinonimo di peggioramento. È la mia opinione, ma io, ripeto, non ne so niente di miseria e sopravvivenza.
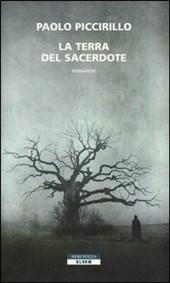
È una ragione puramente narrativa. Ho scelto di raccontare un determinato contesto (il mondo dei contadini molisani nel 2013) e ho dovuto obbedire, come ogni scrittore fa, a delle regole di verosimiglianza. E non mi riferisco solo a determinarti dettagli come quello del contadino che possiede un iPhone. È qualcosa di più profondo, che nasce dall’osservazione di un mondo rurale fotografato nel contrasto tra la sua arcaicità e una globalizzazione crescente. A me interessa molto l’effetto di questo scontro.
Agapito, il protagonista della storia, è un emigrato, un sacerdote spretato con un passato atroce, un contadino che torna alla sua terra senza frutti. La sua vicenda, come quella degli altri personaggi, è una disperata fuga da segreti e rimpianti, dalla solitudine e dall’ignoranza, dal proprio destino. Ma si può sfuggire al proprio destino? Agapito sembra riuscirci. È questa la tua speranza?
Certo che si può sfuggire al proprio destino. È la missione di Agapito. La sua parabola è molto semplice, lui era un uomo felice in Germania (dove aveva trovato anche l’amore) ed è oggi un vecchio signore invece infelice. Le sue radici erano perciò cresciute bene, rigogliose in una terra (la Germania) dove non sono nate naturalmente (il Molise). È questo quindi il senso della storia di Agapito, ritornare in quella terra naturalmente non sua, ma piena di felicità per lui. Piegare la sua vita in maniera forse innaturale, però, nella fatica di piegarla, rendersi conto di avere la forza giusta per essere felici.
Nei due romanzi utilizzi frequentemente il dialetto. Un modo per restare ancorato comunque alle tue origini, alla provincia italiana del sud, alla sua storia di emigrazione e miseria?
No. Non mi interessa essere legato alle mie origini. Uso spesso il dialetto perché è una conseguenza dei personaggi che decido di raccontare. Prima si parlava di verosimiglianza, ecco, questo ne è un ulteriore esempio. Se scelgo di raccontare un contadino molisano è chiaro che questo parlerà molisano, e non un italiano comprensibile. È tutta una questione di verosimiglianza. La bravura dello scrittore poi sta nel farsi seguire dal lettore anche se i suoi personaggi parlano un arabo non tradotto. Io voglio correre il rischio di non essere abbastanza bravo in questo per rispetto ai miei personaggi. Per rispondere quindi alla tua domanda, diciamo che io voglio rimanere ancorato alle origini dei miei personaggi, non alle mie.
In La terra del sacerdote oltre al dialetto utilizzi spesso il tedesco, perché Agapito è legato a quell’altra terra, la Germania, dove tutto ha inizio e fine. A volte nemmeno le “traduci” in italiano, lasciando al lettore l’onere dell’intuizione, dell’interpretazione. La lingua da strumento di identificazione e comunicazione diventa l’esatto contrario. Perché questa scelta?
È una scelta dettata da un motivo preciso, quello di disorientare il lettore come disorientato è Agapito quando da giovane va in Germania e non capisce il tedesco. In realtà poi il tedesco, anche se non è tradotto, non è fondamentale per capire il proseguo della storia. Io volevo che il lettore si disorientasse con il tedesco, ma che allo stesso tempo non perdesse il filo del racconto, che è la cosa più importante di un romanzo.
In alcune recensioni di La terra del sacerdote si mette in evidenza un eccesso di dettagli, di temi, di dialetto, che avrebbero appesantito e confuso il risultato, soffocato la poesia e il lirismo della tua voce. Secondo il “principio dell’iceberg” di Hemingway «tutto quel che conosco è materiale che posso eliminare, lasciare sott’acqua, così il mio iceberg sarà sempre più solido. L’importante è quel che non si vede». Che cosa ne pensi?
Sono d’accordo con Hemingway. È chiaro che uno scrittore centra il suo obiettivo quando dice senza dire, racconta una pesante materia con leggerezza. Ma ci vogliono anni di esperienza per raggiungere questi risultati, una padronanza del proprio stile che è difficile avere dopo solo due romanzi all’attivo.
I tuoi romanzi hanno ricevuto proposte di pubblicazione all’estero? E quali potrebbero essere i lettori non italiani interessati alla tua scrittura, a quello che racconti?
No, per ora ancora nessuna proposta. Credo di avere un modo di raccontare molto vicino alla sensibilità del pubblico spagnolo, o comunque “hispanohablante”, quindi anche sudamericano intendo. Ma è solo una mia sensazione, dovrei essere tradotto in spagnolo per saperlo con certezza.
Tra il primo e il secondo romanzo sono trascorsi circa tre anni. Dobbiamo aspettarne altri tre per il tuo prossimo lavoro?
No. Spero di no.
C’è un libro che non smetteresti mai di leggere? E quello che ancora non hai letto?
Non smetterei mai di leggere Il vecchio e il mare. E vorrei leggere un po’ di letteratura russa, della quale so pochissimo. Vorrei leggere Anna Karenina.
Concludo riportando le ultime parole di La terra del sacerdote: «I due vecchi escono dal bar, vicini. Non si toccano e non si sfiorano, raramente si guardano. Hanno paura di sprecare tutta la vita conservata, l’uno per l’altro. Lenti, con i propri dolori di sempre, s’avviano al funerale del bambino. Eppure attorno non è successo niente, c’è il solo impercettibile affanno dei loro respiri. Il mondo è rimasto uguale». Una rassicurazione o una minaccia?
Una rassicurazione. Il mondo è rimasto uguale è un modo per dire che il mondo ti aspetta, se per un periodo ti concentri solo su te stesso, ti isoli, per cercare il modo migliore di essere felice. L’importante è tornare poi a vivere il mondo e ricominciare da capo.







