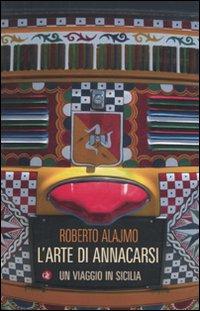 Ultimata la lettura de “L’arte di annacarsi. Un viaggio in Sicilia” (Laterza, 2010) ho pensato: credo che questo sia uno dei migliori libri (se non il migliore) di Roberto Alajmo. E di ottimi libri - tra romanzi e saggi - Alajmo ne ha già scritti parecchi. Ricordo: Un lenzuolo contro la mafia (1993); Repertorio dei pazzi della città di Palermo (1995); Almanacco siciliano delle morti presunte (1997); Notizia del disastro (2001, Premio Mondello); Cuore di madre (2003, Premio Selezione Campiello, finalista al Premio Strega); È stato il figlio (2005, Premio Super Vittorini e Super Comisso); La mossa del matto affogato (2008); Le ceneri di Pirandello (2008) e - sempre per Laterza - 1982, memorie di un giovane vecchio; Palermo è una cipolla.
Ultimata la lettura de “L’arte di annacarsi. Un viaggio in Sicilia” (Laterza, 2010) ho pensato: credo che questo sia uno dei migliori libri (se non il migliore) di Roberto Alajmo. E di ottimi libri - tra romanzi e saggi - Alajmo ne ha già scritti parecchi. Ricordo: Un lenzuolo contro la mafia (1993); Repertorio dei pazzi della città di Palermo (1995); Almanacco siciliano delle morti presunte (1997); Notizia del disastro (2001, Premio Mondello); Cuore di madre (2003, Premio Selezione Campiello, finalista al Premio Strega); È stato il figlio (2005, Premio Super Vittorini e Super Comisso); La mossa del matto affogato (2008); Le ceneri di Pirandello (2008) e - sempre per Laterza - 1982, memorie di un giovane vecchio; Palermo è una cipolla.
Prima di accennare ai contenuti di questo volume, vorrei soffermarmi sul brano scelto come epigrafe. Si tratta di un testo estratto da “La luce e il lutto” di Gesualdo Bufalino, che recita così: «Dicono gli atlanti che la Sicilia è un’isola e sarà vero, gli atlanti sono libri d’onore. Si avrebbe però voglia di dubitarne, quando si pensa che al concetto di isola corrisponde solitamente un grumo compatto di razza e costumi, mentre qui è tutto mischiato, cangiante, contraddittorio, come nel più composito dei continenti. Vero è che le Sicilie sono tante, non finirò di contarle. Vi è la Sicilia verde del carrubo, quella bianca delle saline, quella gialla dello zolfo, quella bionda del miele, quella purpurea della lava. Vi è una Sicilia “babba”, cioè mite, fino a sembrare stupida; una Sicilia “sperta”, cioè furba, dedita alle più utilitarie pratiche della violenza e della frode. Vi è una Sicilia pigra, una frenetica; una che si estenua nell’angoscia della roba, una che recita la vita come un copione di carnevale. Una, infine, che si sporge da un crinale di vento in un accesso di abbagliato delirio…»
La citazione riportata in epigrafe finisce qui, anche se poi – subito dopo – , in “La luce e il lutto”, Bufalino fornisce una sua risposta alla domanda “Tante Sicilie, perché?”
Bufalino risponde così: «Perché la Sicilia ha avuto la sorte di ritrovarsi a far da cerniera nei secoli fra la grande cultura occidentale e le tentazioni del deserto e del sole, tra la ragione e la magia, le temperie del sentimento e le canicole della passione. Soffre, la Sicilia, di un eccesso d’identità, né so se sia un bene o sia un male.»
Un bene o un male, dunque? Chi lo sa? Forse Goethe aveva le idee un po’ più chiare, giacché ebbe modo di sostenere (come è noto): «L’Italia senza la Sicilia non lascia immagine nello spirito: soltanto qui è la chiave di tutto».
Certo, per credere che soltanto in Sicilia ci sia la chiave di tutto ci vuole molta immaginazione. Del resto, come sosteneva Sciascia: « L’intera Sicilia è una dimensione fantastica. Come si fa a viverci senza immaginazione? »
E di immaginazione, a volte, ce ne vuole tanta… come quella che mosse il sommo Dante per la scrittura della sua Commedia:
«E la bella Trinacria, che caliga
tra Pachino e Peloro, sopra ‘l golfo
che riceve da Euro maggior briga,
non per Tifeo ma per nascente solfo… »
(dal Paradiso, canto VIII)
(Magari vi chiederò quale preferite, tra le suddette citazioni… e magari potreste proporne altre).
Ma torniamo a “L’arte di annacarsi”. La prima domanda che il lettore (non siciliano) deve necessariamente porsi nell’affrontarne la lettura, è la seguente: cosa significa annacarsi?
In verità, per trovare la risposta non dovrà faticare molto; basterà girare il volume e leggere quanto scritto in quarta di copertina:
“Annacare/annacarsi = affrettarsi e tergiversare, allo stesso tempo. Un verbo intraducibile che significa una cosa e il suo contrario. Il massimo del movimento col minimo di spostamento”.
Un esempio calzante dell’arte di annacarsi – lo evidenzia lo stesso autore – è fornito nell’ambito delle feste religiose… dove Madonne, santi e canderole vengono portati in processione con un andamento danzante, ondeggiante, non necessariamente (e comunque non solo) in avanti, ma spesso di lato e senza disdegnare piccole retromarce. Forse si potrebbe dire che l’arte di annacarsi (per rimanere nell’ambito della metafora danzesca) è una sorta di sintesi tra una appariscente tarantella e il ballo della mattonella. Insomma, ciò che conta è produrre, appunto, il massimo del movimento, con il minimo di spostamento. In linea, peraltro, con la celebre frase de “Il Gattopardo” di Tomasi di Lampedusa: “Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi”. Ecco: il cambiamento immutevole è un ossimoro che è ben contratto nel termine “annacarsi”.
L’arte di annacarsi, dunque. Un titolo che sintetizza le apparenti contraddizioni e gli immobili mutamenti di una terra multiforme dove però è possibile trovare la chiave di tutto con un po’ di immaginazione: Marsala, Palermo, Ustica, Porto Palo, Favignana, Agrigento, Siracusa, Tindari, Catania, Gela, Taormina, Messina (sono solo alcune delle tappe di Alajmo). Un viaggio che si tramuta in racconto ironico e sferzante, ma che - in fin dei conti - ha sullo sfondo l’amore per questa terra: “un amore che si prova per una canaglia. Tu sai che è una canaglia, ma non puoi farci niente”.
Che il siciliano sia avvezzo all’ironia lo sosteneva anche Cicerone (in Verrem – Actio Secundae – Liber Quartus – De Praetura Siciliensi) : “Numquam est tam male Siculis, qui aliquis facete et commode dicant (Qualunque cosa possa accadere ai Siciliani, essi lo commenteranno con una battuta di spirito).”
Ma l’ironia di Roberto Alajmo non si ferma alle classiche battute di spirito, o ai giochi di parole; essa - viceversa - si espande in ragionamenti volti a evidenziare paradossi, contraddizioni e situazioni ai limiti dell’inverosimile. È un’ironia intelligente e pessimista, quella di Alajmo; precisa e affilata come un bisturi, capace al tempo stesso di stigmatizzare facendo sorridere, lasciando tuttavia spazio alla speranza: “Ma esiste anche una parte di Palermo la cui coscienza non è ancora del tutto anestetizzata. Proprio quando tutto sembra annacquato e perduto, ecco che dal nulla, miracolosamente, la speranza rinasce. E a farla rinascere sono i pazzi. I famosi pazzi di Palermo. Quelli veri e quelli che vengono fatti passare per pazzi. Pazzo è colui che non si adegua allo stato delle cose, che non si lascia trascinare dalla corrente, che si rifiuta di portare coscienza e cervello all’ammasso. I talenti che nascono fuori dai circuiti convenzionali. I giovani che riescono ogni tanto a fare breccia nel deleterio scetticismo cittadino e a creare un movimento di opinione in grado di trasformarsi da un momento all’altro in autentica rivolta morale”. (cfr. pag. 30 – “L’arte di annacarsi” - Palermo. Teoria e tecniche dell’annacamento).
Non mi dilungo ulteriormente e vi rinvio alla bellissima recensione di Simona Lo Iacono (che ho coinvolto in questo post chiedendole di scrivere di questo libro e di darmi una mano a moderare e animare la discussione che ne seguirà). In chiusura del post… la prefazione del libro, gentilmente concessami dall’autore.
Per incentivare la discussione provo a porre qualche domanda:
- Ai siciliani (scrittori e non): vi ritrovate nell’arte di annacarsi? Ovvero… vi annacàte? E tra i due significati del termine, in quale vi ritrovate di più? (Questa domanda è finalizzata a sorridere un po’ insieme)
- Ai non siciliani che non hanno mai visitato l’isola: che percezione avete della Sicilia?
- Ai non siciliani che hanno visitato l’isola: la percezione che avevate della Sicilia, ha trovato riscontro nella vostra visita? Cos’è che vi ha colpito di più?
- La Sicilia rappresentata nei libri, nel cinema, nella televisione è rispondente alla realtà?
- Tra le citazioni sulla Sicilia (riportate sopra), quale vi sembra la più calzante? Ne avete altre da proporre?
Di seguito, l’articolo di Simona Lo Iacono e la prefazione del libro.
Massimo Maugeri
——–
Roberto Alajmo: “L’arte di annacarsi. Un viaggio in Sicilia”
recensione di Simona Lo Iacono

L’aveva vista per la prima volta nell’albo di un viaggiatore, in fotografia. “Fu probabilmente lei che mi decise ad intraprendere il viaggio; parlavo di lei e la sognavo in ogni istante, prima ancora di averla vista. (…) è la donna così com’è, così come la si ama, come la si desidera, come la si vuole stringere. (…). La Venere di Siracusa è una donna, ed è anche il simbolo della carne.”
Anche la Sicilia è donna. Anche la Sicilia è il simbolo della carne.
Affrontare un viaggio in Sicilia, dunque, da straniero o da isolano, da pellegrino o da esule, non è che affondare in quella carne. Percorrerne le cavità, i promontori. I vuoti. Con vista da amante. Con paura d’amante. Con la consapevolezza che prendere la Sicilia è anche lasciarla, o farsene abbandonare. È l’atto finale e disperato dell’amplesso là dove persino la compattezza dell’isola è un’illusione.
E possederla vuol dire frantumarla, farne scaglie. Resti.
Così Roberto Alajmo ne “L’arte di annacarsi. Un viaggio in Sicilia”.
Annacarsi per un siciliano è più che affrettarsi. È anche prendere tempo senza fare realmente qualcosa, vivendo una sospensione mista di perplessità, noia, mancanza reale di voglia. E sembrerebbe forse assurdo a chi crede che la lingua sia un perfetto assioma e che le parole debbano avere un senso (e uno soltanto), che in una locuzione coesistano due significati tanto opposti quanto in “annacarsi”.
Andare, ma anche restare. Volere. Ma anche non volere. Non avere tempo. Ma anche averlo, allungarlo, impigrirlo. Vivere, in sostanza. Ma anche morire.
E tuttavia questa assurdità non stupirebbe mai un siciliano. Non chi – come noi – al tutto, e al contrario di tutto, si abitua fin dall’alzata dello sguardo su questa terra, e all’affioro dei sensi percepisce: no. Ma che vuol dire sì. E il mare. Che vuol dire anche cielo. E l’isolamento. Che vuol dire anche stare al centro del mondo.
Nessuno più del siciliano è triste e contento di esserlo, orgoglioso ostentando pietà, ostile palesando ospitalità, individualista fingendosi indignato di non far parte del tutto.
Contraddizione, o meglio adattamento, al caso, alle circostanze che mutano rotta, ai destini capovolti e poi di nuovo ristabiliti, a un andare della storia al rovescio e poi di nuovo al dritto, ma senza mai veramente sapere cosa è dritto e cosa è rovescio.
Una baldoria dell’uomo e delle sue oscenità, dei suoi vizi e anche delle sue debolezze, o forse solo ostinazione alla sopravvivenza. All’incosciente vivere oggi senza soppesare un futuro. Ché il futuro, alla fine, non è mai dipeso da noi.
Sorrido vedendo che Roberto ne “l’arte di annacarsi” elenca i “luoghi comuni” allumandoli di luce buona, di storia, di spiegazioni. Facendo crollare le certezze di ogni buon turista che approdando qui in cerca di fichi d’india, carretti siciliani, coppole e lupare, più di ogni altra cosa sarà segnato dalla luce e dall’ombra, dalle colature dei tramonti. Dagli scenari di certe città che si aprono come un sipario (Noto) e si svuotano di notte per non vivere che lontano dalle quinte. Che si parano a festa in sontuosi abiti da processione (Trapani), allungando il Venerdì Santo per tutto l’anno. O che edificano stadi del ghiaccio (Catania) a un passo dall’Etna che bolle.
Di Siracusa, non dirò, da buona siracusana, perché assaporo le parole che Roberto ha dedicato a piazza Duomo, alla sua luce bianca, lattea, di una qualità riservata agli dèi e alle creature dell’aria. Mi soffermerò invece su Avola, o su Portopalo, tutti territori facenti parte della giurisdizione del Tribunale che dirigo e da cui mi provengono quelli che io chiamo i “processi del mare”: clandestini ammarati e pescati dalle reti. Pesci con gambe e occhi scuri, sopravvissuti alle onde. Viandanti senza scalo e giunti a me senza nome.
Roberto ne raccoglie le storie riferite ai crocicchi di vie, sulle albe di pescherecci che rientrano. Racconta di quella notte del Natale ‘96 in cui si persero 300 naufraghi che s’inturbinarono tra le correnti. I loro fantasmi si aggirano ancora da queste parti, senza pace e senza sepoltura, forse rigettati in mare una volta ripescati dall’acqua.
Un discorso a parte merita Palermo, dove la decadenza degli edifici viene coltivata come un fasto e dove a ogni sbrecciatura più o meno grave di intonaci, a crepe e lineature del tempo, è facile rimediare con una decisione provvisoria che fa presto a diventare definitiva, o con una panacea adatta a ogni male: la transenna.
E poi l’effigie di madre. Che la Sicilia sa mascherare di reverenza al marito, ma che s’infratta dietro apparenze di remissività. Sorrido davanti alla buffa immagine della “madre ebrea” a cui sono assimilati, nel libro, i siciliani. Che non dice al figlio: se non mangi ti ammazzo. Dirà piuttosto, senza preoccuparsi di dissimulare il ricatto: se non mangi mi ammazzo.
E mi balza dal passato l’immagine di mia nonna, spannata come un’anima e drittissima su gambe che sostenevano una figuretta di nemmeno un metro e venti. Diceva: facite chiddu ca vulite (fate quello che volete). Tanto, poi, si faceva sempre quello che diceva lei.
La mafia, infine. L’unico luogo comune che esiste per davvero. E che ha invece l’abilità di fingersi irreale e fantasioso, più una leggenda eroica da brigante. Con molti ragionevoli motivi, in fondo, per esistere.
Un fumo, più che una mentalità. O piuttosto una ventata di quelle gustose, che portano odore di soffritto e padella, e che segui incantato come da una Circe. Salvo poi a scoprire che non provenivano dalla cucina.
Più che la sua abilità nel nascondersi colpisce la nostra capacità di non vederla, di non farsene toccare come se invece che cosa nostra, fosse sempre cosa d’altri.
Solo quando approda nei tribunali sembra assumere consistenza, materia, sangue.
Fino a che, dalle grate, torna a uscire fuori come un filo di fumo.
Roberto Alajmo non tace responsabilità. Non sorvola sulle ataviche ribaltature di ruoli. Lo stato che manca e lo stato che punisce. Che dà e che ritira la mano. Che non sa amare e che si sente in colpa.
È forse un siciliano verace, uno di quelli che per viaggiare resta al suo posto, e che per inforcare le lenti e guardare sa che non è necessario andare troppo lontano. Di certo, è un siciliano che ama pur sapendo che quell’atto d’amore è morte, discesa agli inferi, eremitaggio.
Se ammanta con ironia le mancanze, è solo perché – in fondo – sa che l’unico modo per sopravvivere, qui, ora è sempre, è svolare con leggerezza di acrobata, o con levità di illusionista.
Un circense, il siciliano. Che transuma di vita in vita, e che cambia solo in apparenza. Che forse è come quella “passiata” sullo stretto. Sempre in bilico tra due mondi. Su una soglia.
E allora meglio l’arte di “annacarsi”, di fare e non fare. Di allungare e accorciare.
A ben pensarci, annacarsi viene da “naca”, che è la culla del neonato che pencola lentamente.
Un buon modo per dire che oscillare è forse l’unico ormeggio alla terra ferma.
————-
LE MANI AVANTI: PREMESSA
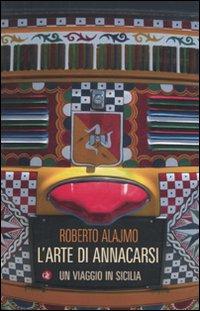
Il viaggio in Sicilia rappresenta allora una indagine sull’identità nazionale. Indagine metaforica, a cannocchiale rovesciato. Se è vero quel che diceva Goethe, che non si può capire l’Italia senza vedere la Sicilia (“è qui la chiave di tutto”), attraversare il continente siciliano significa indagare il collasso di tutta la nazione. In questo senso, il viaggio può rappresentare una discesa agli inferi.
Anche per godere della bellezza più recondita è necessario immergersi in quell’abisso che è la Sicilia. Non si può fare a meno di ravvisare la bruttezza diffusa, il sistematico disprezzo per gli spazi comuni, l’incapacità delle persone anche migliori di fare rete e porre rimedio a queste distorsioni. Viaggiare attraverso la Sicilia significa sporcarsene. E si tratta di uno sporco persistente, di quelli più difficili da trattare.
Per chi in Sicilia ci è nato e ci vive, intraprendere un viaggio attraverso la propria terra è un modo di fare autoanalisi. Di scoprire tutta una serie di cose che già sapeva senza saperlo. Persino il viaggiatore interno ha sentito molto parlare di quest’isola, i luoghi comuni agiscono anche sul suo modo di vedere le cose. Ciò che rivede, in un certo senso, è come se lo rivedesse per la terza volta; le prime due attraverso i propri occhi e attraverso gli occhi del mondo. Si viaggia certe volte con l’intento di essere confermati nelle idee ricevute da altri. Oppure si viaggia per approfondire un viaggio precedente. E però capita pure un’altra cosa: di certi posti non ci si sazia mai. Ci si alza dalla tavola imbandita prima di essersi saziati del tutto, tenendo da parte un po’ di fame per la volta successiva. Oltretutto saziarsi di Sicilia è rischioso; significa un po’ pure sdegnarsene.
Raccontare l’esperienza di un viaggio in Sicilia è una responsabilità che nei secoli si sono assunti in parecchi, ognuno a modo suo, con risultati che ognuno è libero di giudicare in autonomia. Al Idrisi, il geografo. Ibn Giubair, il funzionario. Gregorovius, lo storico. Houel, il pittore. Brydone, lo scienziato. Swinburne, il poeta. Goethe, Maupassant e Dumas, gli scrittori. Questi solo per citare quanti hanno lasciato tracce nelle opere, del loro viaggio nell’estremo lembo meridionale d’Europa. Anche alla luce di questi precedenti, è inutile provare a essere oggettivi; e velleitario risulta provare a essere soggettivi. Bisogna tenere conto dell’occhio di chi legge, che in cambio dell’attenzione si aspetta qualcosa. Giusto. Questo però rende ancora più tormentoso il compito di chi viaggia e racconta la Sicilia essendoci nato. Perché i siciliani hanno la tendenza diventare apprensivi, quando devono rendere conto agli estranei di sé e della propria terra. Sanno che devono misurarsi con una quantità di luoghi comuni che vanno dalla mafia allo scirocco, e molto altro ancora.
Come se non bastasse, ci sono pure i luoghi comuni posticci. Per esempio, quelli che vanno sotto l’etichetta di invenzione della tradizione. È comodo per lo straniero credere, e per i siciliani lasciargli credere, una serie di cose. E la natura dà il suo contributo al consolidamento dei luoghi comuni più infondati: il paesaggio siciliano è ovunque contraddistinto da una pianta, il ficodindia. In ogni angolo, in ogni connessione fra roccia e roccia si trova un ficodindia. Non esiste una pianta più caratteristica. Eppure non è endemica, non è neppure di origini mediterranee, visto che l’importarono gli spagnoli dal centroamerica. E se la natura si permette queste integrazioni della realtà, perché gli uomini non dovrebbero travisare a loro volta? Ecco allora l’astuzia del fotografo che durante la mattanza mafiosa dei primi anni ottanta correva da un posto all’altro per documentare i morti ammazzati nelle strade. Per muoversi più rapidamente si muoveva in vespa, e sul predellino trasportava un vaso con un piccolo ficodindia. Arrivato sul luogo del delitto, disponeva il vaso in modo che almeno una pala della pianta entrasse nell’inquadratura. Sosteneva che i giornali del Nord in quel modo comprassero le foto più volentieri.
Altro equivoco che viene assecondato: il carretto siciliano. Ormai in giro se ne vedono pochissimi, e quelli che si vedono o sono dentro un museo o vengono adoperati come attrazione turistica: una foto sul carretto, sulla piazza di Monreale, vale cinque euro. Modica cifra per qualcosa che siamo portati a immaginare come genericamente antico. Eppure il carretto siciliano, così colorato e impennacchiato è un’invenzione che ha poco più di cento anni. Più che antico, al massimo può essere considerato vecchio. E nemmeno significativo, dato che il temperamento dei siciliani prevede pochi colori e ancor meno impennacchiamenti: quelli estroversi sono i napoletani.
Lo stesso discorso vale per il dolce più siciliano che ci sia, la cassata: un’invenzione pure quella. Ecco come nascono le leggende. C’era un pasticcere palermitano, tale Gulì, che alla fine dell’Ottocento decise di specializzarsi. Nel suo laboratorio di corso Vittorio Emanuele si mise a produrre quasi esclusivamente frutta candita. Come molti siciliani di tenace concetto, aveva deciso di contraddire l’opinione più radicata. Allora come oggi, tutto il mondo nutriva nei confronti della frutta candita un sentimento comune: la ripugnanza. Non la voleva nessuno. Se c’era, veniva scartata accuratamente. Non si conosce il motivo per cui Gulì si convinse del contrario, che ci fosse all’orizzonte un boom di richieste per la frutta candita. Sta di fatto che il suo laboratorio si ritrovò in breve tempo intasato di zuccata e mandarini imbalsamati. Col magazzino pieno e sull’orlo della bancarotta, ebbe un’intuizione che gli consentì di riciclare tutto quel ben di dio. Prese spunto da un dolce di origini molto più antiche, la cassata, quella che oggi viene chiamata cassata al forno: un involucro di pasta frolla ricoperto di cannella e zucchero a velo che custodisce il cuore di ricotta e cioccolato. Su questa base lavorò di fantasia, imbarocchendo il tutto con glassa di zucchero, pasta di mandorle e naturalmente montagnole di frutta candita a fare da guarnizione. Libero ognuno, poi, di scartare la decorazione e assaporare il resto. Il risultato venne prontamente denominato cassata siciliana in modo da sbaragliare anche l’ombra della concorrenza da parte dell’umilissima cassata originale, che si trovò da un momento all’altro privata della propria identità.
La fortuna del nuovo dolce e del suo inventore fu quella di trovare subito un formidabile veicolo promozionale. La facoltosa famiglia dei Florio, che a Palermo ospitava regnanti e aristocratici di tutta Europa, fece della nuova cassata il suo dono di rappresentanza. Questi ospiti partivano da Palermo come altrettanti involontari testimonial, convinti che quel coloratissimo coacervo di zuccheri rappresentasse la Sicilia più vera. E ne incarnava, invece, soltanto la facciata.
Tutta questa premessa sui luoghi comuni serve a introdurre il luogo comune per eccellenza. Meglio affrontarlo subito, però, prima che cominci a impestare l’aria: la mafia. Il resto del mondo tende a credere che in Sicilia i mafiosi se ne vadano in giro col cartellino di riconoscimento o con la lupara a tracolla. Al contrario, quasi sempre tengono un profilo basso, confidando in un genere di riconoscibilità più sottile. Si palesano se questo si rende necessario, confidando che chi deve sapere chi sono, lo sa già. Per il resto, la mafia è un odore. Una puzza. Qualcosa che avverti senza necessariamente sapere da dove proviene. È come la puzza di qualcosa che uno dei tuoi ospiti ha calpestato. Tu non sai esattamente chi, ma sai che qualcuno l’ha calpestata. Magari per discrezione non sollevi il problema, perché pare scortese. Ma dovresti, invece, perché altrimenti sarai costretto a subire quell’odore per tutto il tempo che i tuoi ospiti si tratterranno. Quel che succede nella realtà di tutti i giorni.
Se si sforza un po’, tuttavia, anche l’osservatore più superficiale in certe situazioni può riconoscere la puzza che a zaffate ogni tanto gli capiterà di avvertire. È l’odore di un’apocalisse che è italiana e siciliana al tempo stesso. Quello che si profila come il Grande Collasso Nazionale è destinato a cominciare dal sud. O forse è già cominciato. Rimane da stabilire se sarà un’apocalisse climatica o sanitaria, un’ondata anomala di spazzatura o un’escalation criminale. E rimane da stabilire pure esattamente da dove comincerà: Campania o Sicilia. Le due regioni guardano alle rispettive piaghe con una torva, reciproca forma di consolazione, che confina con l’insidiosa formula del tanto peggio, tanto meglio. Tempo fa successe che a Napoli le casalinghe presero a pietrate i poliziotti che tentavano di arrestare alcuni rapinatori, e il questore commentò: Scene del genere non le ho viste nemmeno a Palermo. Questo smosse un bel po’ di suscettibilità fra la popolazione isolana, dove pure circostanze del genere si ripetono di frequente: come si permette questo signore di adoperare la Sicilia come parametro del peggio? Ma il questore aveva ragione: fra Napoli e Palermo si disputa una corsa al male maggiore.
Se anzi in tutto il meridione scene come quella delle pietrate ai poliziotti avvengono di rado, è solo perché lo Stato ha rinunciato a esercitare il proprio controllo su zone di territorio sempre più vaste, dove la polizia non prova manco a intervenire. In Sicilia se viene rubato un ciclomotore ci si fa una croce sopra, oppure si paga il riscatto per averlo restituito dalla stessa persona che l’ha rubato. La denuncia viene considerata un’usanza desueta perché c’è stata, nel corso del tempo, una tacita cernita dei reati perseguibili. La fase repressiva viene esercitata quasi solo se è destinata a ottenere il consenso generalizzato della popolazione. Quando in passato si sono fatte spettacolari retate di posteggiatori abusivi di colore, lavavetri o di prostitute extracomunitarie, è successo che la gente abbia persino applaudito allo spiegamento delle forze dell’ordine. Diverso è se si tratta di uno spacciatore indigeno. In questo caso scatta, per la morale comune, l’attenuante generica di sempre: Mischino, è patrifamigghia.
In fondo Sicilia e Campania sono figlie entrambe dello stesso Stato assistenziale, caratterizzato dall’essere allo stesso tempo troppo e troppo poco presente. Lo Stato si comporta col meridione come quei genitori che per farsi perdonare le proprie assenze compra un sacco di regali al figlio. In questo modo pensa di essersi lavato la coscienza, e si sorprende quando poi scopre che il figlio è cresciuto male, diventando un delinquente. Allora gli dà uno schiaffo, e si sorprende ancora di più quando il figlio glielo restituisce, lo schiaffo. Ecco, Palermo e Napoli sono figli dello stesso padre. Solo che questo padre ormai ha rinunciato a provarci, coi ceffoni. Un trattamento che riserva solo ai figli degli altri.
Non molto tempo fa i giornali si sono occupati di una ricerchina universitaria condotta nelle scuole di Palermo, un sondaggio dal quale risultava che per la maggior parte degli alunni, interrogati in forma anonima, la mafia era tutto sommato un male se non necessario, almeno accettabile. L’opinione diffusa che veniva fuori era un luogo comune più radicato di quanto si creda, almeno in Sicilia: la mafia dà lavoro. Non appena i dati vennero resi noti, si scatenò una tempesta di indignazione. Si andava dall’accusa di poca significatività del campione sondato, a un’altra più generica di scarsa sensibilità antimafia. In sostanza: gli autori della ricerca erano colpevoli quantomeno di aver lasciato agli studenti la possibilità di esprimere un’opinione del genere senza dar loro nemmeno una sculacciata. I titolari dell’indignazione erano intellettuali, magistrati, deputati, parenti di vittime della criminalità organizzata, e il risultato fu che il sondaggio venne seppellito dallo sdegno generale.
Era stato toccato un nervo scoperto. La coscienza delle persone perbene si rifiutava di accettare un’opinione tanto politicamente scorretta. Fu l’occasione mancata per avviare una discussione su questo semplicissimo argomento: oltre che spiacevole, è anche vero o no, che la mafia dà lavoro? Forse era l’occasione per ammettere che l’opinione maggioritaria emersa da quel sondaggio non era poi tanto inverosimile. Per chi in Sicilia ci vive, basta guardare alla realtà con disincanto per accorgersi che è proprio vero: è la mafia che distribuisce il poco lavoro che c’è. Durante le conversazioni in Sicilia capita di sentirselo dire nelle più svariate circostanze, soprattutto dalle persone culturalmente meno avvertite, che di questa affermazione non colgono anche la grossolanità e la superficialità. Il riflesso condizionato è di liquidare chi esprime un’opinione del genere con una dose di civile insofferenza. Ma a pensarci bene, non hanno torto. Anche quando materialmente è lo Stato a praticare un’assunzione, paramafioso è il sistema di reclutamento: a meno che non si creda che la mafia sia solo il braccio affiliato della mafia stessa. La condizione in cui l’aspirante lavoratore viene tenuto è di oppressione mafiosa. E la diffusione delle forme di lavoro a garanzia diminuita, con il lavoratore tenuto sulla corda praticamente in eterno, non fa altro che incrementare lo spirito di sudditanza: ciò che maggiormente fa il gioco della mafia, trasformando in favori quelli che veramente dovrebbero essere diritti. Applicate in terra di Sicilia - in assenza di una cultura d’impresa che sia veramente radicata, e veramente cultura - le regole del liberismo attengono sì alla sfera economica, ma vengono alterate da quella antropologica.
In Sicilia e nelle regioni del meridione d’Italia lo Stato ha deciso, più o meno consapevolmente, di delegare la funzione dell’ufficio di collocamento. Cercare un lavoro significa chiederlo agli amici, e tenerselo stretto significa tenersi cari gli amici. Per questo il precariato è un’arma nelle mani di chi altera il mercato del lavoro: rappresenta una garanzia di fedeltà. Gli amici contano. È sempre un amico quello che si cerca quando un parente viene ricoverato in ospedale, quando si vuole comprare un’automobile, quando si cerca un prestito e in cento altre occasioni quotidiane, dalle più innocenti in giù.
Anziché spiegare alle scolaresche che la mafia è brutta e cattiva, allora, sarebbe il caso di spiegare come davvero stanno le cose: la mafia dà lavoro, sì, ma lo fa pagare a un prezzo estremamente alto. Il prezzo da pagare è il sottosviluppo. Bisognerebbe spiegare una volta per tutte che l’arretratezza del meridione d’Italia è un’arretratezza creata artificialmente, che si nutre della secolare pioggia di finanziamenti regionali, statali ed europei. Spieghiamo che la mafia dà lavoro dopo aver personalmente creato la mancanza di lavoro. Spieghiamo che senza spezzare questo circolo vizioso la mafia continuerà a detenere il monopolio del mercato dell’occupazione. Spieghiamo che la mafia, ai siciliani, in un certo senso piace. Piace ai commercianti e agli imprenditori, che in cambio del pizzo ottengono dal racket servizi migliori di quelli dello Stato, e inoltre temono i costi e i tempi lunghi di un’insurrezione morale. Piace a tutti i siciliani, che assuefatti ai favori concessi alla loro sudditanza, sono disposti a rinunciare ai diritti della cittadinanza, ne hanno anzi persino dimenticato l’esistenza. Spieghiamo, infine, perché mai lo Stato ha ritenuto di cedere alla mafia la gestione del diritto al lavoro. E chiediamoci se per caso ha voglia di riprenderselo, prima o poi, questo famoso diritto.
Che la mafia dia lavoro è, in Sicilia, un luogo comune. Ma di una sottospecie particolarmente insidiosa: un luogo comune fondato. E di una sotto-sottospecie ancora più insidiosa: un luogo comune fondato su convinzioni superficiali. Nelle vignette del disegnatore Gianni Allegra, l’idea-immagine più forte è rappresentata da un omino appeso a un filo. È una specie di acrobata disperato: forse c’è stato un tempo in cui camminava sul filo, anziché aggrapparcisi. Magari in passato quell’omino è stato un’attrazione circense, capace di arrivare da un capo all’altro del suo filo con brillantezza e spavalderia. Ora l’omino a quel filo rimane appeso con una sola mano, a stento riesce a restare immobile senza precipitare di sotto.
L’omino appeso al filo è uno dei simboli più azzeccati della condizione di chi vive in Sicilia. L’omino si sforza di rimanere aggrappato al filo, di arrivare da un capo all’altro della sua esistenza, ma di nulla può essere certo. Deve stare attento pure alle risposte che dà al suo interlocutore, il grosso topo che nelle vignette rimane sul ciglio del burrone. L’omino si quartìa, come si dice: tende a tutelarsi. Istintivamente si sarebbe indotti a parteggiare per lui, se non altro per ripulsa nei confronti del topone. Ma colui che osserva farebbe bene a non scegliere, fra i due antagonisti. Di certo non può piacergli il topone, ma anche la condiscendenza nei confronti dell’omino appeso al filo non ha una vera ragion d’essere.
Anzi, sarebbe bello se una volta o l’altra quel filo si spezzasse, e che l’omino precipitasse. Che si schiantasse. Che per una volta il suo quartiarsi non fosse premiato con una forma di stentata sussistenza. Chi osserva, se non è un politico, non deve rispondere a un elettorato quartiandosi a sua volta, per cui è libero di rifiutare la solidarietà al più debole solo perché è il più debole. Dal più debole è giusto pretendere che aiuti se stesso in una maniera che vada oltre il semplice quartiamento. Troppe volte si sono visti omini che dopo essere rimasti più o meno a lungo a dondolare appesi a un filo, finivano per accettare l’aiuto del topone. Il quale topone, poi, non li salvava nemmeno: li rimetteva magari sopra il filo, ossia in una condizione di precarietà appena migliore di chi sta sotto. Quella condizione di precaria stabilità che ai toponi serve per guadagnarsi la gratitudine e il consenso.
Ecco, per questo sarebbe bello che una volta per tutte il filo si spezzasse, o che le forze abbandonassero l’omino lasciandolo precipitare. Perché ciò che nelle vignette di Allegra non si vede è quanto veramente sia profondo il baratro che si trova sotto ai suoi piedi. Potrebbe pure trattarsi solo di un piccolo salto, un saltello dopo il quale l’omino sarebbe in grado di camminare da solo, grazie alle sue gambe. Senza doversi quartiare di fronte a nessun topone.
Tutta questa desolazione non sarebbe poi tanto grave se riguardasse solo il nostro presente. Ma in realtà è il futuro che stiamo ipotecando. Ossia il tempo che lasciamo ai nostri figli. L’incubo delle persone perbene, in Sicilia è che il proprio figlio possa decidere di fare il negoziante, o l’imprenditore. Dovere di un buon padre è quello di educare il proprio figlio a non cacciarsi nei guai, ma una volta che c’è finito, cercare in ogni modo di tirarlo fuori. Al proprio figlio non si può raccontare la favoletta tutta teorica dell’antimafia e prescrivergli il coraggio di non pagare. Specialmente perché è nostro figlio e specialmente perché si tratta di questo Paese e di questo momento storico. A parte il fatto che il coraggio non è un medicinale che si possa prescrivere.
Se un ministro dichiara che con la mafia bisogna convivere, è facile che altrove la cosa venga classificata come l’ennesima boutade governativa e, nella confusione generale, presto liquidata. Ma a questo serve sparare molte cazzate: che poi qualche cazzata importante rischia di passare inosservata. A chi vive in Sicilia, la semplice frasetta pronunciata dal ministro un sacco di tempo fa è arrivata come arriva a valle, in forma di valanga, una palla di neve che qualcuno a monte ha lanciato per malignità o anche semplice noia. E vale più del lavoro di centinaia di insegnanti che per anni e anni si sforzano di inculcare agli alunni il senso della legalità. È facile che il dubbio se lo faccia venire un ragazzo che si appresta a entrare nella vita produttiva: è più giusto ascoltare uno sfigato insegnante sottopagato, teorico astratto dell’antimafia, oppure un autorevole ministro?
Il dubbio nasce pure dal fatto che le istituzioni hanno un atteggiamento schizofrenico, nella lotta alla mafia. Da un lato la fase repressiva: se non puntualissima, almeno volenterosa. Dall’altro un lavoro capillare nelle scuole, come educazione alla legalità. In mezzo, per quanto riguarda la fase propositiva, se si esclude l’antimafia da parata: zero assoluto. Anzi, tutta una serie di segnali in controtendenza, ostentati perché intenda chi ha orecchie per intendere.
In fondo anche in Sicilia vale la legge del mercato: il cittadino si rivolge a chi gli offre la miglior qualità di servizi. E moltissimi servizi istituzionali sono stati in quest’isola più o meno esplicitamente privatizzati e delegati a Cosa Nostra. Questo ottiene il negoziante in cambio del pizzo: servizi. Protezione, licenze annonarie, gestione controllata della concorrenza, prestiti agevolati, allacciamenti abusivi di luce, acqua e gas. Nemmeno tanto poco.
Che poi siano servizi illegali, regole distorte, e che illegale e distorto sia il metodo di applicazione, è un altro discorso. Così come è un altro discorso che a trovare molto comodo pagare il racket sia la grande maggioranza dei negozianti. Si fanno affari, col racket. Ci si marcia.
Bisogna purtroppo ammettere che lo Stato non rappresenta un’alternativa credibile. Non in Sicilia, dove Stato e Cosa Nostra si sovrappongono in continuazione. Per capire la frustrazione dei siciliani meglio intenzionati bisogna pensare al personaggio di Giancarlo Giannini in Mimì Metallurgico. Per non sottostare alle vessazioni del capomafia locale, che è Turi Ferro, caratterizzato da un triangolo di nei sulla guancia, Mimì si rivolge al maresciallo dei carabinieri, che però è impersonato sempre da Turi Ferro, sempre con i tre nei sulla guancia. Allora scappa al nord, ma anche qui il procacciatore di lavoro è Turi Ferro coi tre nei. Allora va al sindacato, ma persino lì c’è Turi Ferro con i suoi nei. E così via.
La mafia è come l’acqua, prende la forma del contenitore che la accoglie. E se il contenitore della mafia sono le istituzioni, anche ammettendo che un livello fisiologico di inquinamento sia inevitabile, mai in tempi storici si ricorda una capienza di questa portata. La forma dell’acqua mafiosa oggi è un grande lago tranquillo, talmente fermo da risultare stagnante.
Malgrado qualche segnale in controtendenza, il negoziante onesto viene messo nelle condizioni di chi esce dalla trincea e si lancia nel territorio avverso impugnando la bandiera della legalità, ma una volta in campo aperto si ritrova solo. Solo, malgrado tutte le rassicurazioni e i telefoni antiracket di questo mondo. Per cui la sensazione è che vada crescendo il numero di coloro che pensano, a torto o a ragione: né con questo Stato, né con Cosa Nostra.
Certo, i siciliani, tramite elezioni, hanno abbondantemente contribuito alla deriva di questo Stato e di queste Istituzioni. E altrettanto certo: ci sono i segnali di una prossima, nuova ondata antimafia, che arriva soprattutto dai giovani che hanno riempito i muri di Palermo di adesivi contro il racket e poi hanno fondato Addiopizzo, ricordando che proprio sul fatalismo, sul pessimismo è fondato il sottosviluppo che strangola la Sicilia.
Ma il dovere delle persone perbene è andare oltre la retorica e affrontare i nodi strutturali. È comprensibile che la mafia abbia interesse a tenere nascosta alla pubblica opinione la realtà del mercato del lavoro e quella delle estorsioni: la detenzione del potere passa attraverso la gestione di un profilo basso, senza ostentazioni. Meno comprensibile è che tante persone di provata militanza antimafia non accettino di ammettere quello che è uno stato di fatto. Nessuna persona perbene, se conosce le cose di Sicilia dovrebbe scandalizzarsi a sentir dire che la mafia dà lavoro, o che in certi ambienti pagare il pizzo risulta conveniente. Prendere atto della realtà è il passo preliminare verso qualsiasi ipotesi di soluzione del problema. Per riuscire efficacemente a spremersi un brufolo, bisogna prima procurarsi uno specchio e avere il coraggio di guardarci dentro.
Il viaggio più difficile è quello che si inoltra fin dentro lo specchio.
© Roberto Alajmo – Laterza
Diritti riservati

