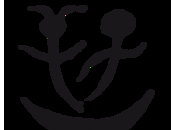Chi vive senza interrogare i propri sogni vive solo a metà (Tobie Nathan)
Un sogno che non viene spiegato è come una lettera non letta(Talmud). Esso ti permette anche di ricevere dei messaggi che non si trovano in questo mondo, che sfuggono alla piattezza della quotidianità. Il tuo sogno può rivelarsi utile, soprattutto in quei momenti di grande difficoltà che a ciascuno capita di attraversare. Può metterti in guardia nei confronti di pericoli ai quali non hai pensato durante la veglia. Così spesso si comporta l’incubo, che non è un errore nato dal timore , ma la percezione dei particolari nascosti di una aggressione. Un sogno perché porti a termine il suo compito deve essere interpretato. Ma, bada bene, nessun sogno può essere interpretato dal suo stesso autore: egli riuscirebbe soltanto a produrre un nuovo sogno, che a maggior ragione richiederebbe l’intervento di un interprete. L’interpretazione è quella parte del sogno che gli consente di realizzarsi nel mondo. Essa è sempre un comando di esistenza. Dunque, un interprete di sogni è un ostetrico dell’indomani. Sii esigente! Non raccontare il tuo sogno ad uno sconosciuto; non lasciare che qualcuno di cui ignori le intenzioni esponga delle verità su di te basandosi su quello che hai sognato. Perché il sogno si realizzerà prendendo il via proprio dalle parole dell’interprete. L’interpretazione è sempre una predizione. Con un unico gesto, descrive e intesse un destino. Essa si proietta sempre nel futuro, lo progetta e lo crea. Sappi che il sogno può diventare, per colui che lo sa interrogare, la luce delle sue notti, una guida nella quotidianità e una difesa contro oscuri pericoli. Le interpretazioni che possono essere fornite al sognatore sono molteplici, facendo risaltare contesti referenziali differenti a seconda dell’identità, della culture d’origine , della lingua e della formazione dell’interprete. Tuttavia, il numero dei quadri di riferimento non è illimitato, anche se le loro forme si declinano all’infinito. Il sogno non è solo una richiesta di interpretazione, è anche la presentificazione di un terzo, un personaggio invisibile con il quale è stato avviato un insospettabile dialogo, all’insaputa dell’io. Tutte le interpretazioni del sogno, compresa quella psicoanalitica, implicano che il sogno sia un dialogo con un interlocutore di natura radicalmente diversa da quella del sognatore.
I neurofisiologi sostengono che il sogno è il risultato di un’attività automatica e istintuale. Si potrebbe dire che il dormiente attraverso il sogno stabilisce una relazione con la sua stessa natura istintuale, con il suo nucleo biologico. Un’altra lettura che proviene da una tradizione molto antica, probabilmente originaria dalla parte più antica del Medio Oriente, della Mesopotamia, dell’Egitto, della Grecia antica e consiste nell’evocare nel proprio sogno una divinità dalla quale si attendono dei benefici.
Sono state confutate teorie che affermano che il sogno è un modo di ricostruire la memoria, sia inserendovi i nuovi avvenimenti della giornata , sia dimenticandone altri dei quali il cervello ha deciso di liberarsi. Il sonno si svolge seguendo un ciclo identico in tutti gli esseri umani. E’ stato possibile stabilire 5 stadi del sonno della durata di 90 minuti ciascuno, che arrivano alla quinta fase chiamata sonno paradosso. Durante la prima fase del sonno, dell’addormentamento, è possibile osservare le visioni dette “immagini ipnagogiche”. Alcuni incubi fanno la loro comparsa in questa fase. Il sonno paradosso è caratterizzato da una totale scomparsa del tono muscolare accompagnata da una’attività cerebrale intensa che vede comparire in maniera ciclica due fenomeni tipici, dei movimenti oculari rapidi e dell’erezione. Il sogno/sonno paradosso, secondo Michel Jouvet consentirebbe al cervello di riprogrammarsi conformemente allo schema iniziale incluso nel suo codice genetico. Secondo questa teoria il sogno è un meccanismo biologico che permette agli individui di ristrutturarsi ogni notte secondo la loro originaria programmazione e dunque di inizializzarsi nuovamente come soggetti geneticamente unici, nonostante la loro massima socializzazione. Il tempo dedicato al sogno non è rivolto verso il passato dell’individuo, bensì verso il suo avvenire. Esso prepara la giornata a venire in modo che sia lui, quel soggetto biologicamente unico, a viverla e nessun altro. Una funzione psichica del sogno sarebbe “un meccanismo biologico destinato a fare in modo che , domani, si sia la stessa persona di oggi”.
La specie umana si è evoluta verso una intensificazione della vita sociale, sempre più complessa in seno a raggruppamenti sempre più vasti . La pressione che queste modalità di vita esercitano sugli schemi di comportamento di derivazione biologica s’accresce man mano che si sviluppano immense società umane sempre più strutturate, sempre più organizzate, sempre più controllate. Il sonno paradosso è dunque indispensabile per ristabilire l’unicità genetica di ogni essere umano. Se nelle società postmoderne il culto dell’”uomo qualunque” tende a cancellare l’individualità delle persone , la funzione psicologica del sogno consiste invece nel restaurare la persona nella sua unicità.
Pertanto il sogno è un fenomeno strettamente personale. Esso è l’equivalente della persona stessa considerata nella sua unicità specifica. Ne consegue che non esistono sogni uguali. Il sogno è un processo che si origina nella notte ma che prosegue per tutta la giornata, poiché esso avrebbe la funzione di fare in modo che essa sia quella di quel determinato individuo.
Il sogno è interattivo, è nella sua natura esserlo. Proprio come il sonno paradosso permette alle cellule nervose di riconnettersi al proprio patrimonio genetico, il sogno stabilisce dei collegamenti con i tratti costitutivi della persona. Le principali funzioni del sogno si realizzano in modi differente a seconda dell’ambiente culturale ed è quindi anche un fattore di socializzazione quotidiana.
Il sogno è vita. A dire il vero è più della vita stessa, poiché prende atto di ciò che abbiamo visto e sentito, tenuto a mente, organizzato. Chi è attento ai propri sogni noterà come la creatività del sogno procede a tentoni. Il sogno esita, tenta una costruzione, la propone ad un ipotetico spettatore, fa un’altra prova, mostra anche questa, ricomincia da capo e continua fino al punto in cui possa avere luogo un racconto. E di tutte le versioni proposte, quella che viene raccontata è generalmente l’ultimo sogno della nottata, il più lungo. I sogni producono dunque delle nuove combinazioni fra le quali si trova necessariamente quella che prenderà forma nella vita del sognatore in un futuro più o meno prossimo. Gli avvenimenti della sua vita andranno ad agglomerarsi in un insieme che costituirà, giorno dopo giorno, la storia di quella persona. Sarà proprio l’interpretazione che lo libererà dal suo carattere potenziale, che lo trasformerà in occasione o in avventura, che lo rivestirà di umanità, gli conferirà la sua plausibilità storica. Principio del quale si erano accorti gli antichi, che nei loro scritti hanno lasciato intendere che l’interpretazione è indispensabile al sogno, che essa ne è la meta nascosta. Le interpretazioni sono, le gambe dei sogni, che affrancheranno dal sonno per inviarli nel mondo. L’interpretazione è quella parte del sogno che gli consente di realizzarsi. Per questo motivo nessuna interpretazione dovrebbe essere formulata in maniera diversa da una predizione. Il sogno offre una nuova visione del mondo, progettando avvenimenti che il giorno prima non erano prevedibili.
Vi è una categoria di sogni manifestamente differenti dagli altri: gli incubi. I neurofisiologi fanno una distinzione fra quelli che avvengono durante il sonno paradosso, che sarebbero dei sogni veri e propri, e gli incubi prodotti nel sonno lento profondo, caratterizzati da una forte carica ansiosa che può arrivare fino ai terrori notturni. Tali incubi,”terrori notturni”, per i moderni si differenziano dai sogni per il fatto che la loro tonalità emozionale è immediatamente comprensibile. Il sognatore la percepisce, svegliandosi all’improvviso, affannato, in un bagno di sudore, non riuscendo a ricollegare i suoi sensi alla realtà di un mondo che in quel momento gli appare meno reale, o comunque meno urgente , di quella in cui si è imbattuto durante il sonno. Ecco, l’incubo agisce come un segnale arcaico per prevenire un pericolo mortale. L’incubo, in un certo senso, è si un sogno, ma più semplice, certo più accessibile e, anche più facile da decodificare. L’incubo come il sogno, è anche uno spazio pubblico, un luogo d’incontro dove l’uomo può a volte imbattersi in non-umani, ma, secondo gli antichi, in questo caso si tratta di demoni piuttosto che di divinità, che non hanno messaggi da consegnargli, bensì lo braccano come una preda. L’incubo è soprattutto lo spazio in cui l’uomo è messo a confronto con le strategie nascoste di altri esseri umani, quelle che la vita sociale, le buone maniere, il senso comune gli hanno impedito di intravedere durante la veglia. L’incubo, a condizione di essere correttamente interpretato, può rivelarsi particolarmente utile al sognatore poiché gli invia un segnale premonitore di un pericolo che egli dovrà affrontare al suo risveglio.
La paralisi è un tema ricorrente in alcuni descrizioni di incubi. Il sognatore è inseguito ma non riesce ad avanzare, i suoi piedi sprofondano nel suolo, oppure le sue gambe sono paralizzate o, ancora tutto il suo corpo rifiuta di fare qualsiasi movimento e nessun suono riesce ad uscire dalla sua bocca. L’incubo, nel quale il dormiente percepisce il bisogno di agire e se ne sente impedito, allude a situazioni sociali minacciose delle quali la persona non ha pienamente preso coscienza durante la veglia.
La perdita d’appoggio, sia che il sognatore si trovi sul bordo di un precipizio senza parapetto, o che il muro di un appartamento situato ad un piano troppo elevato sia crollato, oppure che si ritrovi senza saperlo, nel punto di rottura di un ponte..sono innumerevoli le situazioni nelle quali ci si trovi di fronte al vuoto. Anche i sogni in cui ci si confronta con il nulla sono interpretazioni della vita sociale che fanno riferimento a un abbandono avvenuto in precedenza. E’ come se l’incubo suggerisse alla persona: Proprio come la tua balia, una volta ti ha lasciato cadere quando invece avrebbe dovuto sorreggerti saldamente per farti il bagno, qualcuno sta per tradirti.
L’incontro con i mostri. Questi sogni si riferiscono generalmente alle caratteristiche nascoste di personaggi appartenenti alla vita reale del sognatore. Una persona del suo contesto sociale, che si comporta con lui nel modo più cortese, è in verità animata da intenzioni malvagie; un’altra, con la quale in ufficio egli collabora tutti i giorni, nutre nei suoi confronti una profonda passione amorosa che non può rivelargli ect.
In moltissime tradizioni culturali, il sogno è un dispositivo divinatorio. Ci si aspetta che esso annunci gli avvenimenti futuri per il sognatore, ma anche per i membri della sua famiglia, per coloro di cui egli è responsabile, o anche per la collettività alla quale appartiene. Pronunciare una divinazione consiste sicuramente nell’esprimere un pronostico della persona, ma, contemporaneamente, corrisponde a raggiungerla alle sue radici culturali, alle sue divinità, ai suoi santi e ai suoi diavoli. Per interpretare il sogno di una data persona, bisogna disporre di un corpus mitologico di riferimento da cui attingere personaggi e miti.
Chiudo questo scritto rimandando alla lettura completa del testo di Tobie Nathan,
“Una nuova interpretazione dei sogni” e alle ultime righe del libro . L’interpretazione, quella che annuncia l’avvenire, atto di coraggio di colui che l’ha formulata, è garanzia della libertà del sognatore.