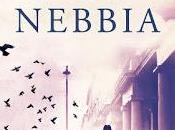Quanti libri, magari meritevoli, giacciono abbandonati dopo poche righe sui comodini di ogni lettore? E quanti altri invece sono stati divorati in poche ore perché già dalle prime righe non siamo più riusciti a staccare gli occhi dalle pagine?
Anche questo mese vogliamo condividere con voi gli incipit dei libri che stiamo leggendo, perché alcuni di voi possano trarre ispirazione per le loro future letture e perché altri possano di nuovo perdersi nel ricordo di personaggi e atmosfere che già una volta li avevano rapiti...Lo staff della Stamberga










***
«Una busta è un enigma che racchiude altri enigmi. Quella era grande, gonfia, di carta di Manila, con il timbro del laboratorio impresso nell’angolo inferiore sinistro. E mentre la soppesava tra le mani cercando contemporaneamente un tagliacarte tra pennelli e barattoli di colori e vernici, Julia era molto lontana dall’immaginare fino a che punto aprirla avrebbe cambiato la sua vita.»La tavola fiamminga, di Arturo Pérez-Reverte - Antonio
«On the second day of December in a year when a Georgia peanut farmer was doing business in the White House, one of Colorado's great resort hotels burned to the ground. The Overlook was declared a total loss. After an investigation, the fire marshal of Jicarilla ruled the cause had been a defective boiler. The hotel was closed for the winter when the accident occurred, and only four people were present. Three survived. The hotel's off-season caretaker, Jack Torrance, was killed during an unsuccessful (and heroic) effort to dump the boiler's steam pressure, which had mounted to disastrously high levels due an inoperative relief valve.Doctor Sleep, di Stephen King - Sakura
Two of the survivors were the caretaker's wife and young son. The third was the Overlook's chef, Richard Hallorann, who had left his seasonal job in Florida and come to check on the Torrances because of what he called "a powerful hunch" that the family was in trouble. Both surviving adults were quite badly injured in the explosion. Only the child was unhurt.
Physically, at last.»
«Sulla bella costa della riviera francese, a mezza strada tra Marsiglia e il confine italiano, sorge un albergo rosa, grande e orgoglioso. Palme deferenti ne rinfrescano la facciata rosata, e davanti a esso si stende una breve spiaggia abbagliante. Recentemente è diventato un ritrovo estivo di gente importante e alla moda; dieci anni fa, quando in aprile la clientela inglese andava verso il Nord, era quasi deserto. Ora molte villette vi si raggruppano intorno; ma quando questa storia incomincia, soltanto i tetti di una dozzina di vecchie ville marcivano come ninfee in mezzo ai pini ammassati tra l'Hotel des Etrangers di Gausse e Cannes, otto chilometri più in là.»Tenera è la notte, di Francis Scott Fitzgerald - Valeria Pinna
«Il sentiero che, scendendo dalla collina, conduce dalla maestosa Volterra al piccolo borgo della Chiostra serpeggia nell’orizzonte toscano – rosso magenta alla fine della giornata – lungo un antico affioramento lavico levigato dal tempo. La vista è mozzafiato a ogni ora e in ogni stagione: da una parte, la bellezza dei colori della natura e dei campi e, dall’altra, un eterno paesaggio lunare dalla geologia insolita, dove le sensuali ondulazioni delle colline sono crudamente sostituite dalle Balze originate da un millennio di frane. Chi nutre interessi classici o storici può individuare il punto in cui la più antica delle necropoli etrusche fu distrutta dall’erosione; oppure può lasciarsi incuriosire dalla badia in rovina dell’undicesimo secolo, o dalle prime chiese cristiane inghiottite dall’ambiente circostante secoli fa. Chi ha, invece, un animo romantico o ama gli enigmi dovrebbe forse recarsi in un luogo indistinto a un paio di chilometri lungo la strada, in qualche punto tra la villa moderna con cani che abbaiano e il vecchio podere con filari di viti e girasoli. Non ci sono cartelli, per cui il viaggiatore non informato potrebbe passarci davanti inconsapevole del mistero.Il giardino delle erbe proibite, di Titania Hardie - Pythia
Qui, cercando bene, c’è sul crinale il rudere di una casa, che da una posizione perfetta volge lo sguardo verso l’imponente città etrusca. La leggenda dice che è tutto quel che rimane di una piccola tenuta della fine del tredicesimo o dell’inizio del quattordicesimo secolo, che un tempo fu la dimora di una famiglia benestante e signorile e della loro incantevole figlia. Del nome della fanciulla dobbiamo fare a meno, perché su di lei è fiorita una messe di leggende e la verità del suo nome fa parte dell’arcano. Basti dire che, in epoca cristiana, era una discepola della Natura, preferiva la compagnia di animali e uccelli e venerava Diana, dea della luna e patrona di uno degli antichi templi che avevano dominato Velathri, come la città di Volterra era anticamente chiamata.»
««Far le valigie Tutto quel che ho lo porto con me.L'altalena del respiro, di Herta Müller - Daniele
Oppure: Tutto quel che è mio me lo porto appresso.
L’ho portato tutto, quello che avevo. Cose mie non erano. Cose nate con un’altra funzione, o appartenenti a qualcun altro. La valigia di pelle di maiale era la custodia di un grammofono. Lo spolverino era di mio padre. Il cappotto da città con il colletto di velluto era del nonno. I calzoni alla zuava, quelli di mio zio Edwin. I gambali di cuoio erano del vicino, il signor Carp. I guanti di lana verde, quelli di mia zia Fini. Solo la sciarpa di seta bordeaux e il nécessaire erano miei, regali degli ultimi Natali.
C’era ancora la guerra, nel gennaio del 1945. Nel terrore che in pieno inverno dovessi andarmene chissà dove dai russi, ciascuno volle darmi qualcosa che potesse essere utile, quando ormai non c’è più niente che serve. Visto che nulla al mondo poteva servire. Visto che stavo sulle liste dei russi, irrevocabilmente, e ognuno mi dava qualcosa e aveva la sua idea nella testa. Io lo prendevo e a diciassette anni pensavo che questo andarmene stesse arrivando al momento giusto. Non doveva essere per forza la lista dei russi, ma bastava che non finisse troppo male che per me era persino un bene. Volevo andarmene via da quella cittadina angusta come un ditale, dove tutti i sassi hanno occhi. Anziché paura avevo quell’impazienza nascosta. E una cattiva coscienza, perché la lista che faceva disperare i miei era una situazione accettabile per me. Avevano paura che mi succedesse qualcosa, in terra straniera. Io volevo andare in un posto che non mi conoscesse.»
«Nell’ospedale dell’orfanotrofio – reparto maschi a St. Cloud’s, nel Maine – due infermiere erano incaricate di dar un nome ai neonati e controllare che il loro piccolo pene guarisse bene, dopo la circoncisione obbligatoria. A quei tempi (nel 192...) tutti i maschi nati a St. Cloud’s venivano circoncisi perché il medico dell’ orfanotrofio aveva incontrato difficoltà di vario genere nel curare i soldati incirconcisi durante la Grande Guerra. Questo dottore, che era anche il direttore del reparto maschi, non era una persona religiosa: la circoncisione non era un rito, per lui, bensì un atto strettamente sanitario, da eseguirsi per motivi igienici. Il suo nome era Wilbur Larch e ciò, nonostante il lieve sentore di etere che sempre l’accompagnava, a una delle due infermiere rammentava il legno, duro e duraturo, di quell’albero delle conifere che si chiama, appunto, larice. Odiava però il nome Wilbur, che trovava ridicolo; e l’offendeva come cosa stolta l’abbinamento di una parola come Wilbur con qualcosa di tanto concreto quanto un albero.Le regole della casa del sidro,di John Irving - Patrizia
L’altra infermiera s’immaginava di essere innamorata del dottor Larch e, quand’era il suo turno di metter il nome a un bambino, spesso lo chiamava John Larch, oppure John Wilbur (suo padre si chiamava John, appunto) oppure Wilbur Walsh (tale era il cognome di sua madre da giovane). Nonostante il suo amore per il dottor Larch, ella non si figurava Larch altro che come un cognome: quando pensava a lui, non pensava mai a un albero. Il nome Wilbur invece le era simpatico per la sua flessibilità: poteva infatti servire sia da primo nome sia da cognome. E quand’era stufa di usare John, o quando la collega la criticava perché ne abusava, raramente riusciva a tirar fuori qualcosa di più originale di un Robert Larch o un Jack Wilbur (pare non sapesse che Jack è, spesso, un nomignolo di John).
Se il nome gliel’avesse messo questa sciapa infermiera innamorata, probabilmente sarebbe stato un Larch o un Wilbur qualsiasi, nonché un John, un Jack o un Robert, tanto per rendere la cosa ancora più sciapa. Ma siccome quella volta toccava all’altra infermiera, fu chiamato Homer Wells.
Il padre della seconda infermiera era uno che scavava pozzi (wells). Un mestiere duro, assillante, onesto e preciso. Per lei, suo padre aveva queste stesse qualità. E ciò donava alla parola wells un nonsoché di profondamente genuino e terragno. "Homer" era il nome di uno dei tanti gatti di casa sua.
Questa seconda infermiera – Nurse Angela, la chiamavano quasi tutti – non ripeteva mai un nome dei suoi bambini, laddove la povera Nurse Edna aveva al suo attivo tre John Wilbur e due John Larch. Nurse Angela conosceva un numero inesauribile di sostantivi seri, che diligentemente (e una volta soltanto) adoprava come cognomi – Maple o Acero, Fields o Campi, Stone o Pietra, Hill o Collina, Knot o Nodo, Day o Giorno, Waters o Acque, per citarne solo alcuni – e disponeva di una lista, un po’ meno impressionante, di primi nomi presi in prestito da una sfilza di animali domestici, defunti ma diletti (Felix, Fuzzy, Smoky, Sam, Snowy, Joe, Curly, Ed e così via).
Per la maggior parte degli orfanelli, questi nomi dati dalle infermiere erano provvisori. Il reparto maschi riusciva in genere più facilmente del reparto femmine ad affidare gli orfanelli in tenera età a qualche famiglia. Quindi erano troppo piccoli per conoscere il nome loro imposto dalle buone infermiere; anzi, perlopiù non ricordavano neanche Nurse Angela e Nurse Edna, le prime donne al mondo che si eran curate di loro. Era ferma politica del dottor Larch che le famiglie adottive degli orfani non venissero informate dei nomi dati, con tanto zelo, dalle due infermiere. A St. Cloud’s si riteneva che un bambino, lasciato l’orfanotrofio, dovesse provar il piacere di un nuovo inizio. Ma (specie per quelli di difficile affido che restavano a lungo al St. Cloud’s) era quasi impensabile, per Nurse Angela e Nurse Edna, e persino per il dottor Larch, che i loro vari John Wilbur e John Larch – i loro Felix Hill, Curly Maple, Joe Knot, Smoky Waters – non serbassero per sempre quei nomi messi loro dalle infermiere.
La ragione per cui Homer Wells conservò questo nome è che fece ritorno a St. Cloud’s tante di quelle volte, dopo tante adozioni fallite, che l’orfanotrofio fu costretto a riconoscere che era intenzione di Homer Wells fare del St. Cloud’s la sua casa. Non era facile per nessuno accettare una cosa del genere. Ma Nurse Angela e Nurse Edna e, alla fine, anche il dottor Larch furon costretti ad ammettere che Homer Wells era di casa al St. Cloud’s. Quel caparbio ragazzo non venne più proposto in adozione. Nurse Angela, tutta amore per i gatti – e per gli orfanelli – una volta ebbe a dire di Homer Wells che questo ragazzo doveva adorare il nome che gli aveva messo perché si era strenuamente battuto per non perderlo.»
«Gabri e Michette Bragance se ne stavano impalate nel bel mezzo del Bois de Boulogne e cercavano la madre tra la folla. Ma in quel limpido mattino d'inverno, gelido e pieno di sole, il viale era nero di gente: le bambine giravano inutilmente la testa in tutte le direzioni ma non vedevano niente. Ricominciarono a camminare piano verso la Porte Dauphine. La neve caduta durante la notte brillava ancora in parte lungo i cancelli, sottolineando il puro disegno dei grandi alberi spogli. L'aria era fresca e frizzante. Gabri e Michette urtavano i passanti con grandi gomitate; le donne correvano sui tacchi alti, la gonna scorciata fino al ginocchio e la vita smisuratamente allungata secondo la moda di quel mese di dicembre 1919. Alcuni giovani vestiti troppo bene, stretti fino a soffocare nei loro cappotti con la martingala, con la testa scoperta come gli adolescenti inglesi e il naso chiuso per il freddo, procedevano a gruppi, sbarrando il marciapiede con l'ampio mulinello dei loro bastoni. Alcuni cavalieri attraversavno il viale al galoppo; la gente li guardava con una specie di sorpresa. In compenso, più curate che se fossero bestie di lusso, le automobili percorrevano la carreggiata. Il quadro era grazioso e affascinante, delimitato da una parte dagli alberi argentati del Bois e dall'altra dalla mole tarchiata dell'Arco di Trionfo, grigio e rosa nel sole.»La nemica, di Irene Némirovsky - Polyfilo
«Non potevo vedere la strada né gran parte del complesso abitativo. Eravamo circondati da palazzoni color sporco dalle cui finestre si affacciavano uomini e donne in maglietta con i capelli del mattino e tazzone di bevande, che facevano colazione e ci osservavano.La città e la città, di China Miéville - Valetta
Un tempo questo spazio aperto fra i palazzi era stato scolpito. Si allungava come un campo da golf... una geografia scimmiottata da un bambino. Magari ci avevano piantato degli alberi e messo dentro anche un laghetto.
C’era un boschetto, ma gli alberelli erano morti. L’erba era gialla e incolta, segnata dai sentieri pedonali che si snodavano in mezzo alla sporcizia, e scavata dai solchi delle ruote. C’erano dei poliziotti impegnati in diverse mansioni. Non ero il primo detective a trovarsi lì – vidi Bardo Naustin e un paio di altri – ma ero il più anziano in grado. Seguii il sergente fino al punto in cui facevano capannello quasi tutti i miei colleghi, fra una torre bassa e malmessa e una pista di pattinaggio cinta da una fila di grossi bidoni della spazzatura a forma di tamburo. Subito al di là si poteva sentire il brusio dell’area portuale. Un gruppetto di ragazzini se ne stava seduto su un muretto di fronte ai poliziotti in piedi. I gabbiani volavano a spirale sopra l’assembramento.
«Ispettore.» Accennai col capo un saluto alla voce, di chiunque fosse. Qualcuno mi offrì un caffè, ma io scossi la testa e rivolsi lo sguardo alla donna che ero venuto a vedere. »
«Incidente.Dai un bacio a chi vuoi tu, di Giusy Marchetta - Stefano di Stasio
Con una mano stringe ancora il manubrio, come se non fosse troppo tardi per frenare. Fa caldo e le mosche sono già arrivate: si posano sulla faccia e poi direttamente sulla pozzanghera di sangue vicino al naso. Volano via con le zampette bagnate e ovunque vanno, è inevitabile, un po’ di sangue se lo portano appresso.»
«Entrò nella mia vita nel febbraio del 1932 per non uscirne più. Da allora è passato più di un quarto di secolo, più di novemila giorni tediosi e senza scopo, che l'assenza della speranza ha reso tutti ugualmente vuoti – giorni e anni, molti dei quali morti come le foglie secche su un albero inaridito.L'amico ritrovato, di Fred Uhlman - Tancredi
Ricordo il giorno e l'ora in cui il mio sguardo si posò per la prima volta sul ragazzo che doveva diventare la fonte della mia più grande felicità e della mia più totale disperazione.»