L'incipit in un libro è tutto. In pochi capoversi l'autore cattura l'attenzione del lettore e lo risucchia nel vortice della storia. Oppure con poche banali parole lo perde per sempre...
Quanti libri, magari meritevoli, giacciono abbandonati dopo poche righe sui comodini di ogni lettore? E quanti altri invece sono stati divorati in poche ore perché già dalle prime righe non siamo più riusciti a staccare gli occhi dalle pagine? Anche questo mese vogliamo condividere con voi gli incipit dei libri che stiamo leggendo, perché alcuni di voi possano trarre ispirazione per le loro future letture e perché altri possano di nuovo perdersi nel ricordo di personaggi e atmosfere che già una volta li avevano rapiti...
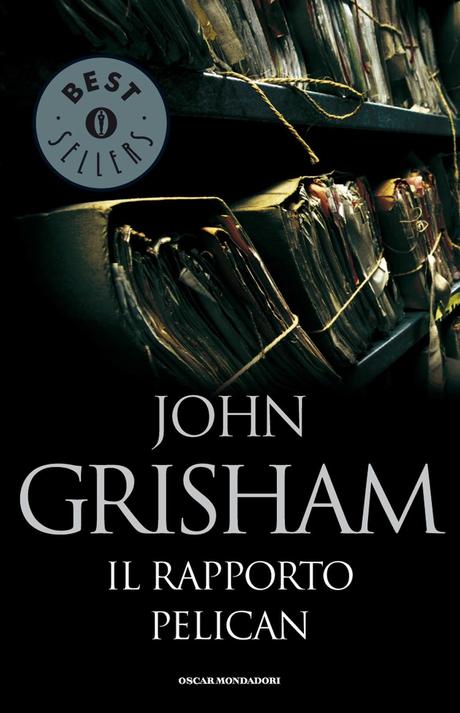


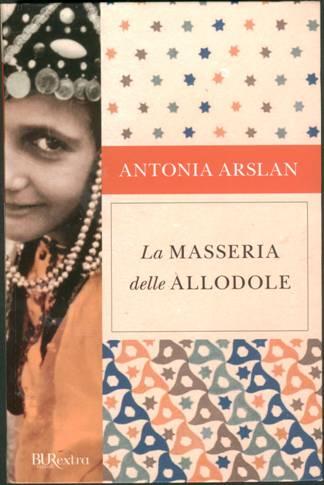

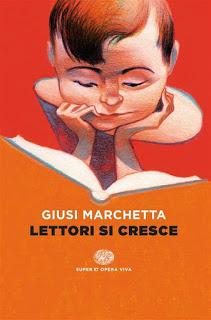
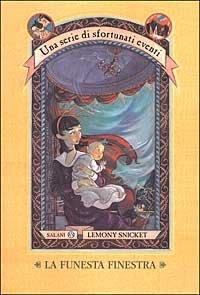
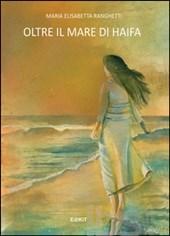

***
«A guardarlo non si sarebbe certo detto che fosse capace di causare un tale trambusto, ma quello che vedeva là sotto era in gran parte imputabile a lui. E andava bene così. Aveva novantun anni, era paralizzato, inchiodato su una sedia a rotelle e collegato a una bombola di ossigeno. Il secondo ictus, sette anni prima, aveva rischiato di ucciderlo, ma Abraham Rosenberg era ancora vivo, e perfino con i tubicini nel naso la sua autorevolezza in campo legale era superiore a quella degli altri otto giudici. Era l’unica leggenda che restava alla Corte, e il fatto che respirasse ancora esasperava gran parte della folle in tumulto.»
«La giornata cominciò alle sette meno cinque: la sveglia (sua madre gliel’aveva regalata quando era andata a servizio) si mise a suonare e continuò imperterrita finché Phyllis non la ridusse al silenzio. Sul cigolante letto di ferro sopra il suo, Edna gemette e si girò, annicchiandosi contro la parete; perfino d’estate odiava alzarsi, e d’inverno capitava che Phyllis dovesse strapparle di dosso le lenzuola. Si mise seduta, si sciolse la retina e cominciò a togliersi i bigodini. Quel giorno aveva il pomeriggio libero, si sarebbe lavata i capelli. Scese dal letto, raccolse la trapunta che era finita in terra durante la notte e aprì le tende. La luce del sole ingentilì di colpo la stanza, trasformando il linoleum in caramello e donando una tonalità blu ardesia alle scheggiature del catino lavamani di smalto bianco. Si sbottonò la camicia da notte di flanella leggera e si lavò alla maniera che le aveva insegnato sua madre: il viso, le mani e poi – ma con circospezione – le ascelle, con un panno imbevuto d’acqua fredda. «Muoviti», disse a Edna. »
«Fu la signorina Lemon, l'efficiente segretaria di Poirot, a prendere la telefonata. Posato il taccuino stenografico, sollevò il ricevitore e senza troppa enfasi rispose: "Trafalgar 8137".
Hercule Poirot si appoggiò allo schienale della poltrona e chiuse gli occhi. Mentre tamburellava le dita sul bordo del tavolo con tocco lieve e riflessivo, l'investigatore continuava in silenzio a cesellare l'elegante periodo della lettera che stava dettando. Coprendo il ricevitore con la mano, la signorina Lemon chiese sottovoce: "Accetta una chiamata da Lapton, Devon?"
Poirot corrugò la fronte. Quel nome non gli diceva niente.
"Chi mi cerca?" domandò circospetto.
La signorina Lemon tolse la mano e riprese a parlare.
"A Riyad?" fece dubbiosa. "Oh, ma certo. E il cognome, prego?"
Di nuovo si rivolse a Poirot.
"La signora Ariadne Oliver".
Poirot inarcò le sopracciglia all'istante. Un ricordo gli affiorò alla mente: capelli grigi, scompigliati dal vento... profilo aquilino... Si alzò e prese il posto della signorina Lemon.»
«Prendemmo la strada sotto i portici per andare al Santo. Era il 13 di giugno, il giorno del mio onomastico.
Pioveva, e io non volevo muovermi, ma il nonno Yerwant, il patriarca a cui nessuno disobbediva, aveva detto: "È ora che la bambina conosca il suo santo. È già quasi troppo tardi, ha cinque anni. Non sta bene far aspettare i santi. E dovete portarcela a piedi". Lui ci avrebbe raggiunto con la sua automobile Lancia, e con Antonio, l'autista.
Così, percorsi con la zia le due lunghe strade porticate che conducono alla basilica, con la zia Henriette, piccola piccola, dal gran naso armeno e dai lucidi capelli neri a caschetto, che aveva molti segreti e se li teneva stretti, non portava mai tacchi bassi e non permetteva che aprissi la sua borsetta. Neppure lei era contenta dell'ordine del nonno: aveva caldo, aveva "quasi" mal di testa, pensava che andare alla basilica nel giorno del Santo fosse poco fine, cosa da provinciali e da turisti, temeva di perdermi, si angosciava per nulla, come sempre.
Zia Henriette era una sopravvissuta al genocidio del 1915. Creatura della diaspora, non aveva più una lingua madre. Parlava molte lingue, compresa la sua, l'armeno, in modo legnoso, innaturale: come una straniera.
In tutte faceva patetici sbagli, e non volle mai raccontare la storia della sua sopravvivenza. Aveva dimenticato anche la sua età (in Italia, quando sbarcò, era così minuta e patita che le tolsero due o tre anni) Ma ogni sera, a casa nostra, veniva a cena portando vassoi di biscotti alla moda austriaca, enormi vasi di yogurt fatto in casa, paklavà colmo di noci e di miele: e la sua presenza riempiva la casa di memorie oscure. Io l'amavo moltissimo, e mi facevo viziare. A casa sua i dischi di Edith Piaf andavano tutto il giorno, e si poteva ballare con le scarpette di panno. Sicché mi facevo trascinare verso il Santo con pigra curiosità, sperando in un gelato, o in una medaglietta, o in un libro colorato, chissà. Per me, ero aperta a tutti i doni - e mi aspettavo un dono, fiduciosamente.
E quando arrivammo allo sbocco della via del Santo nella immensa piazza, ebbi il mio dono. La pioggia era cessata da qualche minuto, e improvvisamente le nuvole si spostarono, come un sipario, e un raggio caldo di luce e di sole fece della piazza un teatro, dove innumerevoli figurine colorate cominciarono a sgrullarsi e a chiudere gli ombrelli, affrettandosi verso l'ingresso.
Tante Aide, Nives, Esterine, Gigie si chiamavano allegre e urgenti, accompagnate da bambini compunti vestiti da piccoli frati, e da uomini atticciati, seri, addobbati di nero; nel centro, un gruppo solenne e ieratico si faceva notare per i chiassosi costumi, le gonne lunghe e i fieri capelli delle donne, i mustacchi erti degli uomini. Fermi, fissavano concentrati il grande portone socchiuso della basilica.
"Vedi? Ci sono anche gli zingari" disse preoccupata la zia. "Tienimi stretta la mano." Io non pensavo a sciogliermi. Mi bastavano gli occhi. Ero incantata e confusa. Erano quelli, gli zingari? Quelli che andavano sempre, e non si fermavano in nessun luogo; quelli che abitavano i carrozzoni sgargianti, che erano come case piccolissime, con dentro tutto quello che serve? Anche noi armeni siamo andati in tutti i paesi ma, giunti in un posto, ci fermiamo; e così abbiamo parenti in tutte le parti del mondo. E cominciai a ripetermi l'elenco delle città dove avevamo parenti, e i loro nomi, rigirandomeli in bocca come una caramella.
La zia lo ripeteva sempre: "Quando sarò proprio stanca di stare con voi, quando sarete stati troppo cattivi, io me ne andrò. A Beirut da Arussiag, ad Aleppo da zio Zareh, a Boston da Philip e Mildred, a Fresno da mia sorella Nevart, a New York da Ani,1 o anche a Copacabana dal cugino Michel. Lui però per ultimo, perché ha sposato un'assira". Io ero affascinata dalla signora zia assira. Avevo visto in un libro illustrato i costumi degli antichi assiri e le loro barbe, mi avevano raccontato la storia di Nabucodonosor e delle grandi città di Babilonia e di Ninive, e mi figuravo questa zia incedere, avvolta in stoffe sontuose, su e giù per i giardini pensili di Babilonia (che suonava abbastanza simile a Copacabana) Altro che lasciarli per ultimi, come voleva zia Henriette; lo splendore di questa parentela brasiliana a mio parere doveva avere il primo posto. Ma nessuno in verità chiedeva il mio parere…»
«Jeeves posò le sfrigolanti uova al prosciutto sul tavolo della colazione a Reginald ("Filetto") Herring e io, leccandoci le labbra, sistemammo i gomiti e ci demmo sotto. Un amico mio da sempre, questo Herring, a me legato da quelli che vengono definiti ricordi imperituri. Anni prima, da ragazzetti, eravamo stati in galera insieme alla Malvern House di Bramley-on-Sea, la scuola preparatoria diretta da quell'emerito fetente di Aubrey Upjohn, e molto spesso ci eravamo trovati fianco a fianco nello studio di Upjohn in attesa di riceverne sei delle più gagliarde da una di quelle canne che mordono come serpenti e pungono come scorpioni, secondo la definizione di quel tale. Sicché si potrebbe anche dire che eravamo un po' come due vecchi soldatacci che avessero combattuto spalla a spalla il giorno di Crispino, se ho capito bene il nome.»
«Non voglio annoiarti Polito, lo giuro. Ma l’hai voluto tu, è colpa tua. Sei un quindicenne sano, robusto, italiano, di famiglia media. Hai perso un anno di scuola quindi vai in prima superiore.(Può succedere, la vita ha le sue scosse, non preoccuparti non ci riguarda).
Giochi a calcio, alla playstation, esci con gli amici, desideri ragazze che non ti considerano. Hai un taglio di capelli che offende il mio gusto estetico, ma fartelo notare mi invecchierebbe di vent’anni perciò me ne guardo bene. Del resto, taglio e colore dei capelli non c’entrano con la tua preparazione scolastica o col fatto che non leggi.
Perché tu non leggi, Polito, mai. Né libri, né fumetti, né giornali, né riviste.
Ti ho visto accartocciare volantini prima ancora di capire cosa reclamizzassero, premere compulsivamente la X sul tuo joypad per saltare l’introduzione scritta a un videogioco.Ti ho visto piegato sul banco, inconsapevole rivisitazione scolastica della Pietà, incapace di arrivare in fondo alla pagina senza boccheggiare, controllare l’effettiva presenza di pagine successive, infliggere a me, la tua insegnante, lamentosi tentativi di opporre resistenza.»
«Non conoscendo gli orfani Baudelaire, e vedendoli seduti sulle loro valigie all'estremità di un imbarcadero, avreste potuto pensare che per loro stava per cominciare un'avventura emozionante. E come no? Erano appena sbarcati dal Traghetto Trabiccolo, col quale avevano attraversato il Lago Lacrimoso, e dove andavano? Andavano a stare a casa della zia Josephine, e stare a casa di una zia è quasi sempre una cosa divertente, emozionante, memorabile, un tempo di spassi.
Be', ragazzi, doverlo dire spiace più a me che a voi, ma non è così. Intanto, divertimenti e spassi dimenticateli subito. E poi, è vero che a Violet, Klaus e Sunny stavano per succedere cose emozionanti e memorabili, ma non emozionanti e memorabili come farsi dire la fortuna da una zingara o andare a un rodeo, semmai piuttosto come essere inseguiti da un lupo mannaro attraverso un campo brullo, sparso di arbusti con spine lunghe mezzo dito, e nessuno in giro capace di dare un briciolo di aiuto.
Se quello che volete è una storia allegra, dove succedono tante belle cose e tutto finisce bene, diciamo subito che avete sbagliato libro. Perché agli orfani Baudelaire di bello non succede quasi mai niente, anzi la loro vita è triste, cupa e miserabile. Vi dirò la verità: la loro vita è così tremenda che se potessi farei a meno di scriverla. Quindi vi avverto: se non volete sentir raccontare storie di tragedia e tristezza, posate subito questo libro. È la vostra ultima possibilità, perché le nuove disgrazie dei Baudelaire cominciano appena abbiamo fatto punto e a capo. »
«L'acqua è una benedizione:ebrei, mussulmani e cristiani pregano perché possa irrorare la loro terra e renderla fertile, perché ci possano essere scorte sufficienti per superare le torride estati. Quando scende bagna i campi, le colline, le città e il deserto che, nei primi mesi della primavera, come per magia, fiorisce costellandosi di tanti fiori colorati e diversi. L'acqua scende anche sul mare e va a posarsi sulla sua superficie, rimbalzando prima su di essa per poi unirsi e fondersi in un'unica distesa di cui si fatica a vedere la fine. Quel giorno Hassan era sulla spiaggia, sotto una pioggia delicata che lo bagnava, a guardare l'orizzonte; fissava la linea piatta che segna la fine del mare e l'inizio di un mondo che non gli era dato vedere. »
«Fratelli umani, lasciate che vi racconti com’è andata. Non siamo tuoi fratelli, ribatterete voi, e non vogliamo saperlo. Ed è ben vero che si tratta di una storia cupa, ma anche edificante, un vero racconto morale, ve l’assicuro. Rischia di essere un po’ lungo, in fondo sono successe tante cose, ma se per caso non andate troppo di fretta, con un po’ di fortuna troverete il tempo. E poi vi riguarda: vedrete che vi riguarda. Non dovete credere che cerchi di convincervi di qualcosa; in fondo, come la pensate è affar vostro. Se mi sono deciso a scrivere, dopo tutti questi anni, è per mettere in chiaro le cose per me stesso, non per voi. A lungo uno striscia su questa terra come un bruco, nell’ attesa della diafana e splendida farfalla che porta in sé. E poi il tempo passa, la ninfosi non arriva, rimani larva, desolante constatazione, ma che farci? Certo, il suicidio resta un’ opzione. Ma per la verità, il suicidio mi tenta poco. Ci ho pensato molto, ovviamente; e se dovessi ricorrervi, ecco come farei: mi piazzerei una bomba a mano proprio sul cuore e me ne andrei in un violento scoppio di gioia. Una piccola bomba a mano rotonda a cui toglierei con delicatezza la sicura prima di rilasciare la linguetta, sorridendo al lieve rumore metallico della molla, l’ultimo che sentirei, oltre ai battiti del mio cuore nelle orecchie. E poi, finalmente, la felicità, o perlomeno la pace, e le pareti dello studio addobbate di brandelli di carne. Toccherà alle domestiche pulire, sono pagate per questo, affari loro. Ma come ho detto, il suicidio non mi tenta. Non so perché, del resto, un vecchio residuo di morale filosofica, forse, che mi fa dire che in fondo non siamo qui per divertirci. Per far che, allora? Non ne ho idea, per durare, probabilmente, per ammazzare il tempo prima che lui ammazzi noi. E in tal caso, come occupazione, a tempo perso, scrivere vale come qualsiasi altra »

