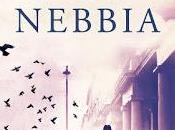Maria d’Enghien
29 dicembre 2014 di Dino Licci

Maria d’Enghien, particolare del suo ritratto, Basilica di S. Caterina a Galatina, XIV-XV sec, foto di Daniela Bacca
“ Non me ne curo, ché se moro, moro da regina”
In questa breve ma significativa frase, è racchiusa tutta la personalità di Maria d’Enghien, che potremmo definire sposa devota, madre affettuosa, o piuttosto contessa, regina, guerriera, mecenate e oculata amministratrice della giustizia e della cultura salentina. Un modello femminile di straordinaria vitalità dotata di un carisma tale da consentirle di essere amata e ammirata anche fuori dei propri feudi quando, divenuta sposa di Ladislao, come fra poco vedremo, si trasferì a Napoli dove riuscì, ad onta di quanti la descrivono schiava e succuba del marito, a godere di una certa libertà ed avere anche una certa influenza sulla politica partenopea, almeno finché Ladislao visse.
Figlia di Giovanni d’Enghien, Conte di Lecce, e Sancia del Balzo, Maria d’Enghien divenne Contessa di Lecce (comitissa Licii ), ancora giovinetta, alla morte del fratello Pietro. La sua nascita che si può datare intorno al 1367, avvenne a Lecce in un periodo politicamente e militarmente burrascoso laddove il Regno di Napoli era sconvolto da una spaventosa guerra civile tra due opposte fazioni: da una parte il Papa Urbano VI e Carlo III d’Angiò Durazzo, Re di Napoli, dall’altra l’Antipapa Clemente VII e Luigi I d’Angiò Re di Francia, che avanzava pretese sul feudo partenopeo.
Memore delle origini francesi del suo casato, Maria si schierò affianco del suo sovrano Luigi I d’Angiò, che, a garanzia della sua lealtà, volle darla sposa ad un guerriero potentissimo di cui si fidava ciecamente: Raimondo Orsini del Balzo. Le nozze furono celebrate a Lecce nella seconda metà d’agosto del 1385, ma non fu solo un matrimonio d’interesse e calcolo politico, ma anche un matrimonio d’amore. Maria, pienamente ricambiata, fu sposa amorevole di quest’uomo tanto valoroso quanto ambizioso, sostenendolo nelle sue battaglie politiche e militari e gli donò quattro figli; Maria, Caterina, Giovanni Antonio e Gabriele. Raimondino, come affettuosamente veniva chiamato il principe, ad onor del vero, usò una tattica doppiogiochista schierandosi alternativamente al fianco di una delle due fazioni che si contendevano il potere sulle città salentine, salendo sempre, come suol dirsi, sul carro del vincitore, ma questo discutibile comportamento gli valse l’investitura a Principe di Taranto nel 1399. Titolo di cui poté godere solo pochi anni perché, nel 1406, egli improvvisamente morì e sulle spalle di Maria si riversò la responsabilità di difendere Taranto dagli attacchi di Ladislao, discendente di Carlo III e divenuto re di Napoli a soli undici anni di età. Quest’ultimo marciava verso la Puglia a capo di un potentissimo esercito e non esitò ad usare la nuova arma, il cannone, contro una Taranto che strenuamente si difendeva dai suoi assalitori con Maria stessa a capo di un manipolo di guerrieri, che eroicamente difendevano la loro città.
La contessa combatteva al loro fianco indossando un’armatura che nascondeva una donna ambiziosa e molto determinata a raggiungere i suoi fini. Quando Maria capì che i soccorsi degli Angiò cui aveva chiesto aiuto, non sarebbero arrivati in tempo ad evitare un grande spargimento di sangue, accettò la proposta della parte avversa anch’essa sfiancata dall’interminabile contesa.
Ladislao le proponeva di accettare, sposandolo, il titolo di regina. I consiglieri della contessa la sconsigliarono in verità di accettare, stante le morti misteriose delle due precedenti mogli di Ladislao, ma l’ambizione o forse l’amore per l’avvenire dei figli, contribuirono a rinforzare la sua decisione ed è in questa circostanza che l’ormai futura regina pronunciò la famosa frase:
“ non me ne curo, ché se moro, moro da regina”.
Così Maria si trasferì a Napoli dove fu bene accolta dai suoi sudditi ma, seppure riuscì a condizionare in parte la politica di Ladislao, detto il Magnanimo, i rapporti con il marito non furono sempre serafici, tanto che ella si trovò presto costretta a convivere con le amanti di lui.
Morto Ladislao nel 1414, il regno passò nelle mani di sua sorella Giovanna II, donna ambiziosa e tanto crudele che non esitò ad imprigionare la nostra Maria che solo un anno dopo poté essere liberata ad opera di Giacomo della Marca, tornando così in possesso della contea di Lecce ed ottenendo nel 1420 il principato di Taranto per il figlio Giovanni Antonio.
Ed è in questi ultimi anni che dimostrò ancor più le sue capacità di amministratrice ed è a lei che si deve l’emanazione degli
“Statuta et capitula florentissimae civitatis Licii”
Ma fu anche amante delle arti, oltre che fervente cattolica ed amante del popolo della sua città d’origine. Fu lei, fra l’altro a commissionare a Francesco d’Arezzo i magnifici affreschi che abbelliscono la basilica di Santa Caterina d’Alessandria in Galatina. Tale basilica fu eretta per volontà del marito Raimondo, folgorato da un suo pellegrinaggio compiuto sul monte Sinai dove sorge il celebre convento di Santa Caterina appunto e la Grotta di Mosè, dove si suppone che Mosè avesse sostato per ricevere le tavole dei Dieci Comandamenti.
Proprio a Galatina si può ammirare un ritratto di Maria che, alla sua morte, fu sepolta nel vecchio monastero di Santa Croce in un catafalco con un’ arca mortuaria che secondava le fattezze del suo corpo e che contornava l’immagine della bella contessa con i simboli delle quattro virtù cardinali e le tre virtù teologali quasi a tramandare ai posteri non solo l’immagine del suo piacevole aspetto fisico, ma anche e soprattuto le sue doti di instancabile propugnatrice di fede e carità cristiane.
In seguito il vecchio monastero fu distrutto per volontà di Carlo V che edificò, sulle sue rovine, il possente castello che ancora oggi possiamo ammirare, ma ciò che mai nessuno dovrà distruggere, è il ricordo che ogni leccese, ogni buon salentino, deve avere di questa donna coraggiosa e capace, che, con l’amore per l’ambiente e per la cultura, ha abbellito tutto il Salento di degne opere d’arte, propugnando anche il rispetto per la nostra terra come neanche oggi si riesce più a fare.