Mr. Ciak: Rudderless, Fantastic 4, Dark Places, Aloha, Tutto può accadere a Broadway, Return to Sender
Creato il 14 settembre 2015 da Mik_94
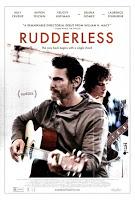 Rudderless
parte schiacciando il solito tasto. Quello, a orecchio, dolente: la morte di un figlio, la voglia di disperarsi.
Eppure la vicenda che ti racconta non è di quelle che che sperano di
condurti sull'orlo del pianto. La storia di questo padre straziato
dalla perdita – un figlio ucciso in una sparatoria in un
campus universitario – si perde, qualche volta, in una bottiglia di
birra scura, ma per fortuna si ritrova nella musica. Basta beccare
l'accordo o trovare il coraggio di mettere il naso in una stanza che
spaventa. Sam – che ha abbandonato
tutto, per vivere da spiantato su una barca: per fuggire – un giorno trova i
dischi che suo figlio ha inciso prima dell'inizio della fine. Così,
in sua memoria, li fa suoi e canta qualche canzone per locali: i
testi di Josh sono il mezzo più efficace per essergli vicino. Quel lupo di mare di mezza età,
perennemente alticcio e su di giri, stringe amicizia con un
ventunenne che cela la timidezza cronica dietro una parlantina a
raffica: con lui e due coetanei sfigatelli forma un improbabile gruppo che fa bella musica. Rudderless
racconta l'ascesa di una band e
il lento risalire la china; dramma – anche un po' commedia però –
in musica, sul perdono e il correlato perdonarsi. A sorprendere dell'esordio di William H. Macy – ma sì, il Frank di Shameless
– è la leggerezza di cui, nonostante un fatto bruttissimo, è
padrone e la presenza di pezzi già riascoltati, personalmente curati
da un cast che non ti aspetti. Un magnifico Billy
Crudup regala così una prova vocalmente ineccepibile e emotivamente ricca: il suo papà a pezzi un po' clochard è uno di quelli che quando si sbronzano sono
patetici ma allegri. Anton Yelchin, come il prezzemolo ma in gamba, intonato, suona
con convinzione e non si riconosce quasi con il viso emaciato e i capelloni
ricci. E l'amicizia strana tra un padre senza
figlio e un figlio senza padre, un vecchio e un giovane, ha effetti
ora tragicomici e ora miracolosi, senza retorica alcuna – tra i due, inoltre, la fidanzata
a lutto Selenza Gomez e la mamma
recalcitrante Felicity Hoffman. Oltre a una colonna sonora originale e a un'aria trasandata nelle mie corde (e quando mai
il Sundance sbaglia, poi?), c'è una simpatica parte teen – il
ragazzo impresentabile che ha il talento ma non la faccia tosta – e un
colpo di scena da pelle d'oca. Se non ti commuove all'inizio,
Rudderless ti commuove quando meno te lo aspetti, con un'intensa ballad di chiusura che è una benedizione; un pugno forte, ma necessario: delicato. Quando il peggio sembra passato, eccolo che riaffiora
– con la sua faccia segreta, con la vergogna – e lo si
affronta, con la chitarra in braccio e le spiegazioni nel prossimo
ritornello. Rudderless –
tra Begin Again e La
stanza del figlio – non è mai una scontata, stonata, canzone triste. Mi ha rubato cuore e mp3. (8)
Rudderless
parte schiacciando il solito tasto. Quello, a orecchio, dolente: la morte di un figlio, la voglia di disperarsi.
Eppure la vicenda che ti racconta non è di quelle che che sperano di
condurti sull'orlo del pianto. La storia di questo padre straziato
dalla perdita – un figlio ucciso in una sparatoria in un
campus universitario – si perde, qualche volta, in una bottiglia di
birra scura, ma per fortuna si ritrova nella musica. Basta beccare
l'accordo o trovare il coraggio di mettere il naso in una stanza che
spaventa. Sam – che ha abbandonato
tutto, per vivere da spiantato su una barca: per fuggire – un giorno trova i
dischi che suo figlio ha inciso prima dell'inizio della fine. Così,
in sua memoria, li fa suoi e canta qualche canzone per locali: i
testi di Josh sono il mezzo più efficace per essergli vicino. Quel lupo di mare di mezza età,
perennemente alticcio e su di giri, stringe amicizia con un
ventunenne che cela la timidezza cronica dietro una parlantina a
raffica: con lui e due coetanei sfigatelli forma un improbabile gruppo che fa bella musica. Rudderless
racconta l'ascesa di una band e
il lento risalire la china; dramma – anche un po' commedia però –
in musica, sul perdono e il correlato perdonarsi. A sorprendere dell'esordio di William H. Macy – ma sì, il Frank di Shameless
– è la leggerezza di cui, nonostante un fatto bruttissimo, è
padrone e la presenza di pezzi già riascoltati, personalmente curati
da un cast che non ti aspetti. Un magnifico Billy
Crudup regala così una prova vocalmente ineccepibile e emotivamente ricca: il suo papà a pezzi un po' clochard è uno di quelli che quando si sbronzano sono
patetici ma allegri. Anton Yelchin, come il prezzemolo ma in gamba, intonato, suona
con convinzione e non si riconosce quasi con il viso emaciato e i capelloni
ricci. E l'amicizia strana tra un padre senza
figlio e un figlio senza padre, un vecchio e un giovane, ha effetti
ora tragicomici e ora miracolosi, senza retorica alcuna – tra i due, inoltre, la fidanzata
a lutto Selenza Gomez e la mamma
recalcitrante Felicity Hoffman. Oltre a una colonna sonora originale e a un'aria trasandata nelle mie corde (e quando mai
il Sundance sbaglia, poi?), c'è una simpatica parte teen – il
ragazzo impresentabile che ha il talento ma non la faccia tosta – e un
colpo di scena da pelle d'oca. Se non ti commuove all'inizio,
Rudderless ti commuove quando meno te lo aspetti, con un'intensa ballad di chiusura che è una benedizione; un pugno forte, ma necessario: delicato. Quando il peggio sembra passato, eccolo che riaffiora
– con la sua faccia segreta, con la vergogna – e lo si
affronta, con la chitarra in braccio e le spiegazioni nel prossimo
ritornello. Rudderless –
tra Begin Again e La
stanza del figlio – non è mai una scontata, stonata, canzone triste. Mi ha rubato cuore e mp3. (8)
 Io
odio il cinecomic. Così, quest'anno, era cominciato un post in cui –
tra posizioni finto snob e ricordi – mi ero per metà
ricreduto. Non odiavo il fumetto quando era come il Daredevil
Netflix, ad esempio. Per il
resto sì. Neanche quando il
film è amatissimo io riesco ad apprezzarlo; figuratevi quante
probabilità ci siano che mi piaccia, invece, il disastro annunciato
che neanche gli appassionati salvano.
Fantastic 4 – flop
clamoroso, rinnegato perfino da chi l'ha diretto e interpretato – a sorpresa non mi è dispiaciuto. Alla
sufficienza piena non arriva, e facile sarebbe fare ironia con
l'aggettivo fantastico, mai così fuori luogo qui, e con il numero
nel titolo che, per magia, va a richiamare il quattro secco della
valutazione finale. Prima di vederlo, e viva il pregiudizio, avevo
un'idea per un bel commento negativo. Ma poi, pronto al
peggio, mi sono mediamente goduto quest'ora e mezza, vista solo per
una curiosità di quelle brutte: quando mai di mia spontanea volontà
guarderei un prodotto Marvel? Vista a
suo tempo la saga originale, che mi aveva diverto e poco più, non mi
ha turbato l'idea di un reboot. Il cast, inoltre, vanta alcuni tra gli attori più promettenti della nuova
generazione: la rivelazione di
Whiplash, la sorella
meno impegnata di Rooney Mara, il Billy Elliot cresciuto
con Von Trier e Vinterberg, il protagonista del premiato Fruitvale
Station. Questa riscrittura in
chiave giovanile, per me,
parte bene: un cenno a un'infanzia da nerd e a una lunga amicizia, la coesione non messa in gioco da nessun amore, salvare il mondo come fosse un progetto del liceo.
Spensierata, la prima ora vede un quinto membro di passaggio – un
giovane Dottor Destino non ancora cattivo – e la scoperta di un
mondo parallelo. Non ci sono momenti seriosi né la simpatia per
forza; New York non sarà nuovamente distrutta. Da qui in poi,
la situazione precipita: qualcuno schiaccia "avanti veloce". Un'ellissi narrativa buttata lì, un anno è passato: sviluppi che nessuno ti ha spiegato, uno scontro finale
di pochi minuti, un epilogo aperto. Quello c'è di negativo – non
la Torcia Umana di colore che tanto ha fatto strepitare (momento ironia: la
fiamma l'avrà scurito un po' troppo?), né il mondo alternativo che
ricorda preoccupantemente i wallpaper dozzinali del mio portatile: ossia, il sembrare
il pilot introduttivo di un telefilm senza un to be continued.
(5,5)
Io
odio il cinecomic. Così, quest'anno, era cominciato un post in cui –
tra posizioni finto snob e ricordi – mi ero per metà
ricreduto. Non odiavo il fumetto quando era come il Daredevil
Netflix, ad esempio. Per il
resto sì. Neanche quando il
film è amatissimo io riesco ad apprezzarlo; figuratevi quante
probabilità ci siano che mi piaccia, invece, il disastro annunciato
che neanche gli appassionati salvano.
Fantastic 4 – flop
clamoroso, rinnegato perfino da chi l'ha diretto e interpretato – a sorpresa non mi è dispiaciuto. Alla
sufficienza piena non arriva, e facile sarebbe fare ironia con
l'aggettivo fantastico, mai così fuori luogo qui, e con il numero
nel titolo che, per magia, va a richiamare il quattro secco della
valutazione finale. Prima di vederlo, e viva il pregiudizio, avevo
un'idea per un bel commento negativo. Ma poi, pronto al
peggio, mi sono mediamente goduto quest'ora e mezza, vista solo per
una curiosità di quelle brutte: quando mai di mia spontanea volontà
guarderei un prodotto Marvel? Vista a
suo tempo la saga originale, che mi aveva diverto e poco più, non mi
ha turbato l'idea di un reboot. Il cast, inoltre, vanta alcuni tra gli attori più promettenti della nuova
generazione: la rivelazione di
Whiplash, la sorella
meno impegnata di Rooney Mara, il Billy Elliot cresciuto
con Von Trier e Vinterberg, il protagonista del premiato Fruitvale
Station. Questa riscrittura in
chiave giovanile, per me,
parte bene: un cenno a un'infanzia da nerd e a una lunga amicizia, la coesione non messa in gioco da nessun amore, salvare il mondo come fosse un progetto del liceo.
Spensierata, la prima ora vede un quinto membro di passaggio – un
giovane Dottor Destino non ancora cattivo – e la scoperta di un
mondo parallelo. Non ci sono momenti seriosi né la simpatia per
forza; New York non sarà nuovamente distrutta. Da qui in poi,
la situazione precipita: qualcuno schiaccia "avanti veloce". Un'ellissi narrativa buttata lì, un anno è passato: sviluppi che nessuno ti ha spiegato, uno scontro finale
di pochi minuti, un epilogo aperto. Quello c'è di negativo – non
la Torcia Umana di colore che tanto ha fatto strepitare (momento ironia: la
fiamma l'avrà scurito un po' troppo?), né il mondo alternativo che
ricorda preoccupantemente i wallpaper dozzinali del mio portatile: ossia, il sembrare
il pilot introduttivo di un telefilm senza un to be continued.
(5,5)
 Gillian
Flynn – dopo il fenomeno Gone Girl – non
ci ha messo molto a tornare al cinema. Presta la sua penna al francese
Gilles Paquet-Brenner. Dark Places è poliziesco non particolarmente piaciuto in rete, di cui mi sono concesso
direttamente il film, senza prima passare per il romanzo. Come saprà qualche lettore, parla di un caso di cronaca
riportato alla luce dopo trent'anni: Libby Day – unica
sopravvissuta al massacro di famiglia di cui è stato dichiarato
colpevole il fratello maggiore –
adesso è una donna che ha bisogno di soldi e pace. Non indaga per
sete di giustizia, ma per conto di uno strano club finanziato da appassionati di crimini irrisolti: torna
ad aprire la porta al passato, e scopre che forse il mostro in galera aveva avuto un ruolo marginale in quella notte
di sangue. Cos'è successo davvero? Nelle zone d'ombra del titolo,
una storia tra passato e presente, ambientata in una America rurale,
dura e polverosa: le fattorie pignorate, le bettole che attirano i
papà alcolizzati, i ragazzini precoci che adorano il Demonio. I paragoni scattano e
non sembrano tenere in considerazione lo spirito
diverso delle due storie: quella proposta da Fincher, cinica e
all'insegna del colpo di scena; questa a cura del modesto regista di
La chiave di Sara – capace, anche in quell'occasione, di
districarsi con fluidità tra diversi piani temporali – verosimile
e lineare. Davanti a una svolta non perevista ma poco incisiva,
ho però avuto l'impressione che sin dall'inizio Dark Places fosse
una piccola storia; ma il risultato – nonostante le imperfezioni e
i limiti – è più che sufficiente. Merito di una confezione classica e di un ritmo lento, che ti lascia apprezzare più il dramma ambientato in quei sonnacchiosi
anni ottanta che il giallo contemporaneo. Ottima la scelta dei
comprimari – una sexy Chloe Moretz, una Christina Hendricks dimessa, un Nicholas Hoult che ha fatto di
meglio altrove – e prevedibilmente in parte la Theron, camaleontica e dello
stile androgino; il viso tirato per tutta la durata del film. (7)
Gillian
Flynn – dopo il fenomeno Gone Girl – non
ci ha messo molto a tornare al cinema. Presta la sua penna al francese
Gilles Paquet-Brenner. Dark Places è poliziesco non particolarmente piaciuto in rete, di cui mi sono concesso
direttamente il film, senza prima passare per il romanzo. Come saprà qualche lettore, parla di un caso di cronaca
riportato alla luce dopo trent'anni: Libby Day – unica
sopravvissuta al massacro di famiglia di cui è stato dichiarato
colpevole il fratello maggiore –
adesso è una donna che ha bisogno di soldi e pace. Non indaga per
sete di giustizia, ma per conto di uno strano club finanziato da appassionati di crimini irrisolti: torna
ad aprire la porta al passato, e scopre che forse il mostro in galera aveva avuto un ruolo marginale in quella notte
di sangue. Cos'è successo davvero? Nelle zone d'ombra del titolo,
una storia tra passato e presente, ambientata in una America rurale,
dura e polverosa: le fattorie pignorate, le bettole che attirano i
papà alcolizzati, i ragazzini precoci che adorano il Demonio. I paragoni scattano e
non sembrano tenere in considerazione lo spirito
diverso delle due storie: quella proposta da Fincher, cinica e
all'insegna del colpo di scena; questa a cura del modesto regista di
La chiave di Sara – capace, anche in quell'occasione, di
districarsi con fluidità tra diversi piani temporali – verosimile
e lineare. Davanti a una svolta non perevista ma poco incisiva,
ho però avuto l'impressione che sin dall'inizio Dark Places fosse
una piccola storia; ma il risultato – nonostante le imperfezioni e
i limiti – è più che sufficiente. Merito di una confezione classica e di un ritmo lento, che ti lascia apprezzare più il dramma ambientato in quei sonnacchiosi
anni ottanta che il giallo contemporaneo. Ottima la scelta dei
comprimari – una sexy Chloe Moretz, una Christina Hendricks dimessa, un Nicholas Hoult che ha fatto di
meglio altrove – e prevedibilmente in parte la Theron, camaleontica e dello
stile androgino; il viso tirato per tutta la durata del film. (7)
 Bradley
Cooper è un eroe in congedo – traumi di guerra dopo American
Sniper? - che arriva alle
Hawaii con un gamba dolorante e piani confusi. Riallaccia rapporti
con una Rachel McAdams mai scordata; si innamora di un rigido
caporale con gli occhi di Emma Stone; finanziato da un
esagerato Bill Murray che vuole comprarsi il cielo, fa da paciere tra
americani e indigeni. Questo e qualcos'altro, con illustri comparse
che non vi sto a elencare e un intreccio a metà tra la
commedia sentimentale e la spy story, capita in Aloha, ultimo
film del buon Cameron Crowe – nel mio cuore a vita per Quasi
Famosi e Vanilla Sky – su cui, in Patria, hanno detto
peste e corna. Se ingiustamente, guardate, non saprei: la stampa
criticava posizioni politiche che non ho colto e un razzismo di fondo nel descrivere le tribù locali;
non la sceneggiatura – disimpegnata, ma estremamente gradevole –
e il lavoro dei protagonisti – rilassati e bene amalgamati.
Glissando perciò su questi elementi – forse dolenti per gli
yankee, ma noi siamo italiani, quindi chissene – resta il fatto che Aloha, film di puro
intrattenimento sorretto da un ottimo cast e da più di qualche scena
brillante – il dialogo muto tra Cooper e un laconico Krasinski, il
ballo a Natale tra la Stone e Murray -, diverte e intrattiene con
intelligenza. Dovrebbe sorprenderici la cosa? Direi di no, con un
Crowe che ci mancava, i suoi classici personaggi combattuti e dai
lavori inconsueti, la profondità e l'acume, gli epiloghi non
scontati. Se la surreale parentesi spionistica non si segue con molta
convinzione, è anche perché si è impegnati a vedere il protagonista
alle prese con due delle donne della mia vita, su uno sfondo esotico
che non fa da cornice
folkloristica. Per una volta il titolo italiano non sbaglia, in
ballo infatti c'è il cielo, ma preferisco quello internazionale,
che significa “ciao” e “arrivederci”. L'unico termine che conosco insieme a ohana,
direttamente da Lilo & Sitch:
“famiglia”. Altra parola che può andare tanto bene, per
riassumere questa storia di salvataggi sopra le righe, nidi, sogni di
secondo taglio. (7)
Bradley
Cooper è un eroe in congedo – traumi di guerra dopo American
Sniper? - che arriva alle
Hawaii con un gamba dolorante e piani confusi. Riallaccia rapporti
con una Rachel McAdams mai scordata; si innamora di un rigido
caporale con gli occhi di Emma Stone; finanziato da un
esagerato Bill Murray che vuole comprarsi il cielo, fa da paciere tra
americani e indigeni. Questo e qualcos'altro, con illustri comparse
che non vi sto a elencare e un intreccio a metà tra la
commedia sentimentale e la spy story, capita in Aloha, ultimo
film del buon Cameron Crowe – nel mio cuore a vita per Quasi
Famosi e Vanilla Sky – su cui, in Patria, hanno detto
peste e corna. Se ingiustamente, guardate, non saprei: la stampa
criticava posizioni politiche che non ho colto e un razzismo di fondo nel descrivere le tribù locali;
non la sceneggiatura – disimpegnata, ma estremamente gradevole –
e il lavoro dei protagonisti – rilassati e bene amalgamati.
Glissando perciò su questi elementi – forse dolenti per gli
yankee, ma noi siamo italiani, quindi chissene – resta il fatto che Aloha, film di puro
intrattenimento sorretto da un ottimo cast e da più di qualche scena
brillante – il dialogo muto tra Cooper e un laconico Krasinski, il
ballo a Natale tra la Stone e Murray -, diverte e intrattiene con
intelligenza. Dovrebbe sorprenderici la cosa? Direi di no, con un
Crowe che ci mancava, i suoi classici personaggi combattuti e dai
lavori inconsueti, la profondità e l'acume, gli epiloghi non
scontati. Se la surreale parentesi spionistica non si segue con molta
convinzione, è anche perché si è impegnati a vedere il protagonista
alle prese con due delle donne della mia vita, su uno sfondo esotico
che non fa da cornice
folkloristica. Per una volta il titolo italiano non sbaglia, in
ballo infatti c'è il cielo, ma preferisco quello internazionale,
che significa “ciao” e “arrivederci”. L'unico termine che conosco insieme a ohana,
direttamente da Lilo & Sitch:
“famiglia”. Altra parola che può andare tanto bene, per
riassumere questa storia di salvataggi sopra le righe, nidi, sogni di
secondo taglio. (7)
 Una
stella in ascesa racconta a una giornalista l'incarico con
una compagnia in cui – suo malgrado – ha seminato zizzania.
Quella nuova diva, infatti, un tempo lavorava come squillo in attesa
della grande svolta: uno dei suoi amanti – un regista filantropo o
puttaniere – aveva finanzato generosamente i suoi sogni e, per pura
coincidenza, si era ritrovata a recitare proprio nello spettacolo di
quest'ultimo. Ma con una moglie sospettosa, un attore inaffidabile
che sa tutti i dettagli del tradimento, uno scrittore pazzo d'amore, lo spettacolo con la bella Isabella – ingenua, nonostante
la professione più antica del mondo – sarà stato allestito senza
divorzi o, per un crimine d'amore, reputazioni rovinate? Tutto può
accadere a Broadway – in inverno da noi – è il
ritorno al cinema di Peter Bogdanovich, settantaseienne che – come
sapranno i cinefili doc, dunque non troppo io – è un'istituzione
quando si parla di commedia. Qui, tutti in un colpo, il Wilson
cascamorto, l'Ifans istrione, una Aniston pazza; soprattutto, una
Imogen Poots – se sia più bella o simpatica non si sa, con il suo
personaggio alla Audrey, di gran classe – da cui portano tutte le
strade. Newyorkese con orgoglio, Bogdanovich cita sé stesso,
Lubitsch e l'Allen più brillante, in un film dalla comicità
sofisticata, in cui una scrittura pimpante, un cast all stars e
colori retrò trovano l'approvazione di un pubblico che stravede facilmente per le cose
così. Luccicanti, parlatissime, d'altre epoche. Non un attore fuori
forma o un momento di silenzio, quando tutti si affidano a un'anziana
leggenda e fraintendimenti e battute fulminanti – in cui si parla
di sentimenti, show business e dintorni – ti sommergono come
un'onda e ti intontiscono di chiacchiere. Ma giusto un po'. (6,5)
Una
stella in ascesa racconta a una giornalista l'incarico con
una compagnia in cui – suo malgrado – ha seminato zizzania.
Quella nuova diva, infatti, un tempo lavorava come squillo in attesa
della grande svolta: uno dei suoi amanti – un regista filantropo o
puttaniere – aveva finanzato generosamente i suoi sogni e, per pura
coincidenza, si era ritrovata a recitare proprio nello spettacolo di
quest'ultimo. Ma con una moglie sospettosa, un attore inaffidabile
che sa tutti i dettagli del tradimento, uno scrittore pazzo d'amore, lo spettacolo con la bella Isabella – ingenua, nonostante
la professione più antica del mondo – sarà stato allestito senza
divorzi o, per un crimine d'amore, reputazioni rovinate? Tutto può
accadere a Broadway – in inverno da noi – è il
ritorno al cinema di Peter Bogdanovich, settantaseienne che – come
sapranno i cinefili doc, dunque non troppo io – è un'istituzione
quando si parla di commedia. Qui, tutti in un colpo, il Wilson
cascamorto, l'Ifans istrione, una Aniston pazza; soprattutto, una
Imogen Poots – se sia più bella o simpatica non si sa, con il suo
personaggio alla Audrey, di gran classe – da cui portano tutte le
strade. Newyorkese con orgoglio, Bogdanovich cita sé stesso,
Lubitsch e l'Allen più brillante, in un film dalla comicità
sofisticata, in cui una scrittura pimpante, un cast all stars e
colori retrò trovano l'approvazione di un pubblico che stravede facilmente per le cose
così. Luccicanti, parlatissime, d'altre epoche. Non un attore fuori
forma o un momento di silenzio, quando tutti si affidano a un'anziana
leggenda e fraintendimenti e battute fulminanti – in cui si parla
di sentimenti, show business e dintorni – ti sommergono come
un'onda e ti intontiscono di chiacchiere. Ma giusto un po'. (6,5)
 L'ultimo
Fincher aveva lasciato scoprire ai più il potenziale di una grande attrice. Dopo Gone
Girl, si attendevano riconferme dalla Pike; collaborazioni
importanti e nuovi progetti, anche se, cronologicamente, si ha la
sfortuna di imbattersi prima in Return to sender. Il
lavoro direttamente successivo a quello che la portò a un passo così
dall'Oscar: scivolone imperdonabile. Perché è un thriller scialbo e
inconcludente; perché il personaggio di Miranda – algida,
perfetta, impenetrabile – è la fotocopia in bianco e nero di Amy. Un anno dopo, con un'altra vendetta e un'altra regina di
ghiaccio? Scelta sbagliata e ingiustificata, dato uno script inconsistente e l'idea vecchia. La
storia della perfetta infermiera che, in pieno giorno, viene stuprata
da un fattorino (no, non lo mandava Zalando - "urla di piacere") e medita punizioni poco
esemplari, infatti, regala un'unica sorpresa: la vendetta ci sarà,
ma rimandata di un'ora. Se la violenza manca, si nega all'appello anche una degna caratterizzazione
dei personaggi – incomprensibili – e il minimo sindacabile di
coinvolgimento. Lei ha la vecchia maschera, Nick Nolte è il papà
burbero e premuroso che sempre gli riesce; nota positiva, Shiloh Fernandez: giovane antagonista che intriga. Il resto: il
trauma e la nascita di disturbi ossessivi, le cure miracolose della legge del taglione, innumerevoli
cambi d'abito tollarabili unicamente per il fisico statuario della
Pike. Bellissima sempre, ma qui tornata alla leziosità e al rigore
di quando nessuno la conosceva. Rosamunde mia, perché?
(4)
L'ultimo
Fincher aveva lasciato scoprire ai più il potenziale di una grande attrice. Dopo Gone
Girl, si attendevano riconferme dalla Pike; collaborazioni
importanti e nuovi progetti, anche se, cronologicamente, si ha la
sfortuna di imbattersi prima in Return to sender. Il
lavoro direttamente successivo a quello che la portò a un passo così
dall'Oscar: scivolone imperdonabile. Perché è un thriller scialbo e
inconcludente; perché il personaggio di Miranda – algida,
perfetta, impenetrabile – è la fotocopia in bianco e nero di Amy. Un anno dopo, con un'altra vendetta e un'altra regina di
ghiaccio? Scelta sbagliata e ingiustificata, dato uno script inconsistente e l'idea vecchia. La
storia della perfetta infermiera che, in pieno giorno, viene stuprata
da un fattorino (no, non lo mandava Zalando - "urla di piacere") e medita punizioni poco
esemplari, infatti, regala un'unica sorpresa: la vendetta ci sarà,
ma rimandata di un'ora. Se la violenza manca, si nega all'appello anche una degna caratterizzazione
dei personaggi – incomprensibili – e il minimo sindacabile di
coinvolgimento. Lei ha la vecchia maschera, Nick Nolte è il papà
burbero e premuroso che sempre gli riesce; nota positiva, Shiloh Fernandez: giovane antagonista che intriga. Il resto: il
trauma e la nascita di disturbi ossessivi, le cure miracolose della legge del taglione, innumerevoli
cambi d'abito tollarabili unicamente per il fisico statuario della
Pike. Bellissima sempre, ma qui tornata alla leziosità e al rigore
di quando nessuno la conosceva. Rosamunde mia, perché?
(4)
Potrebbero interessarti anche :
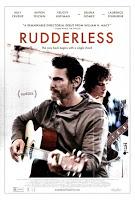 Rudderless
parte schiacciando il solito tasto. Quello, a orecchio, dolente: la morte di un figlio, la voglia di disperarsi.
Eppure la vicenda che ti racconta non è di quelle che che sperano di
condurti sull'orlo del pianto. La storia di questo padre straziato
dalla perdita – un figlio ucciso in una sparatoria in un
campus universitario – si perde, qualche volta, in una bottiglia di
birra scura, ma per fortuna si ritrova nella musica. Basta beccare
l'accordo o trovare il coraggio di mettere il naso in una stanza che
spaventa. Sam – che ha abbandonato
tutto, per vivere da spiantato su una barca: per fuggire – un giorno trova i
dischi che suo figlio ha inciso prima dell'inizio della fine. Così,
in sua memoria, li fa suoi e canta qualche canzone per locali: i
testi di Josh sono il mezzo più efficace per essergli vicino. Quel lupo di mare di mezza età,
perennemente alticcio e su di giri, stringe amicizia con un
ventunenne che cela la timidezza cronica dietro una parlantina a
raffica: con lui e due coetanei sfigatelli forma un improbabile gruppo che fa bella musica. Rudderless
racconta l'ascesa di una band e
il lento risalire la china; dramma – anche un po' commedia però –
in musica, sul perdono e il correlato perdonarsi. A sorprendere dell'esordio di William H. Macy – ma sì, il Frank di Shameless
– è la leggerezza di cui, nonostante un fatto bruttissimo, è
padrone e la presenza di pezzi già riascoltati, personalmente curati
da un cast che non ti aspetti. Un magnifico Billy
Crudup regala così una prova vocalmente ineccepibile e emotivamente ricca: il suo papà a pezzi un po' clochard è uno di quelli che quando si sbronzano sono
patetici ma allegri. Anton Yelchin, come il prezzemolo ma in gamba, intonato, suona
con convinzione e non si riconosce quasi con il viso emaciato e i capelloni
ricci. E l'amicizia strana tra un padre senza
figlio e un figlio senza padre, un vecchio e un giovane, ha effetti
ora tragicomici e ora miracolosi, senza retorica alcuna – tra i due, inoltre, la fidanzata
a lutto Selenza Gomez e la mamma
recalcitrante Felicity Hoffman. Oltre a una colonna sonora originale e a un'aria trasandata nelle mie corde (e quando mai
il Sundance sbaglia, poi?), c'è una simpatica parte teen – il
ragazzo impresentabile che ha il talento ma non la faccia tosta – e un
colpo di scena da pelle d'oca. Se non ti commuove all'inizio,
Rudderless ti commuove quando meno te lo aspetti, con un'intensa ballad di chiusura che è una benedizione; un pugno forte, ma necessario: delicato. Quando il peggio sembra passato, eccolo che riaffiora
– con la sua faccia segreta, con la vergogna – e lo si
affronta, con la chitarra in braccio e le spiegazioni nel prossimo
ritornello. Rudderless –
tra Begin Again e La
stanza del figlio – non è mai una scontata, stonata, canzone triste. Mi ha rubato cuore e mp3. (8)
Rudderless
parte schiacciando il solito tasto. Quello, a orecchio, dolente: la morte di un figlio, la voglia di disperarsi.
Eppure la vicenda che ti racconta non è di quelle che che sperano di
condurti sull'orlo del pianto. La storia di questo padre straziato
dalla perdita – un figlio ucciso in una sparatoria in un
campus universitario – si perde, qualche volta, in una bottiglia di
birra scura, ma per fortuna si ritrova nella musica. Basta beccare
l'accordo o trovare il coraggio di mettere il naso in una stanza che
spaventa. Sam – che ha abbandonato
tutto, per vivere da spiantato su una barca: per fuggire – un giorno trova i
dischi che suo figlio ha inciso prima dell'inizio della fine. Così,
in sua memoria, li fa suoi e canta qualche canzone per locali: i
testi di Josh sono il mezzo più efficace per essergli vicino. Quel lupo di mare di mezza età,
perennemente alticcio e su di giri, stringe amicizia con un
ventunenne che cela la timidezza cronica dietro una parlantina a
raffica: con lui e due coetanei sfigatelli forma un improbabile gruppo che fa bella musica. Rudderless
racconta l'ascesa di una band e
il lento risalire la china; dramma – anche un po' commedia però –
in musica, sul perdono e il correlato perdonarsi. A sorprendere dell'esordio di William H. Macy – ma sì, il Frank di Shameless
– è la leggerezza di cui, nonostante un fatto bruttissimo, è
padrone e la presenza di pezzi già riascoltati, personalmente curati
da un cast che non ti aspetti. Un magnifico Billy
Crudup regala così una prova vocalmente ineccepibile e emotivamente ricca: il suo papà a pezzi un po' clochard è uno di quelli che quando si sbronzano sono
patetici ma allegri. Anton Yelchin, come il prezzemolo ma in gamba, intonato, suona
con convinzione e non si riconosce quasi con il viso emaciato e i capelloni
ricci. E l'amicizia strana tra un padre senza
figlio e un figlio senza padre, un vecchio e un giovane, ha effetti
ora tragicomici e ora miracolosi, senza retorica alcuna – tra i due, inoltre, la fidanzata
a lutto Selenza Gomez e la mamma
recalcitrante Felicity Hoffman. Oltre a una colonna sonora originale e a un'aria trasandata nelle mie corde (e quando mai
il Sundance sbaglia, poi?), c'è una simpatica parte teen – il
ragazzo impresentabile che ha il talento ma non la faccia tosta – e un
colpo di scena da pelle d'oca. Se non ti commuove all'inizio,
Rudderless ti commuove quando meno te lo aspetti, con un'intensa ballad di chiusura che è una benedizione; un pugno forte, ma necessario: delicato. Quando il peggio sembra passato, eccolo che riaffiora
– con la sua faccia segreta, con la vergogna – e lo si
affronta, con la chitarra in braccio e le spiegazioni nel prossimo
ritornello. Rudderless –
tra Begin Again e La
stanza del figlio – non è mai una scontata, stonata, canzone triste. Mi ha rubato cuore e mp3. (8) Io
odio il cinecomic. Così, quest'anno, era cominciato un post in cui –
tra posizioni finto snob e ricordi – mi ero per metà
ricreduto. Non odiavo il fumetto quando era come il Daredevil
Netflix, ad esempio. Per il
resto sì. Neanche quando il
film è amatissimo io riesco ad apprezzarlo; figuratevi quante
probabilità ci siano che mi piaccia, invece, il disastro annunciato
che neanche gli appassionati salvano.
Fantastic 4 – flop
clamoroso, rinnegato perfino da chi l'ha diretto e interpretato – a sorpresa non mi è dispiaciuto. Alla
sufficienza piena non arriva, e facile sarebbe fare ironia con
l'aggettivo fantastico, mai così fuori luogo qui, e con il numero
nel titolo che, per magia, va a richiamare il quattro secco della
valutazione finale. Prima di vederlo, e viva il pregiudizio, avevo
un'idea per un bel commento negativo. Ma poi, pronto al
peggio, mi sono mediamente goduto quest'ora e mezza, vista solo per
una curiosità di quelle brutte: quando mai di mia spontanea volontà
guarderei un prodotto Marvel? Vista a
suo tempo la saga originale, che mi aveva diverto e poco più, non mi
ha turbato l'idea di un reboot. Il cast, inoltre, vanta alcuni tra gli attori più promettenti della nuova
generazione: la rivelazione di
Whiplash, la sorella
meno impegnata di Rooney Mara, il Billy Elliot cresciuto
con Von Trier e Vinterberg, il protagonista del premiato Fruitvale
Station. Questa riscrittura in
chiave giovanile, per me,
parte bene: un cenno a un'infanzia da nerd e a una lunga amicizia, la coesione non messa in gioco da nessun amore, salvare il mondo come fosse un progetto del liceo.
Spensierata, la prima ora vede un quinto membro di passaggio – un
giovane Dottor Destino non ancora cattivo – e la scoperta di un
mondo parallelo. Non ci sono momenti seriosi né la simpatia per
forza; New York non sarà nuovamente distrutta. Da qui in poi,
la situazione precipita: qualcuno schiaccia "avanti veloce". Un'ellissi narrativa buttata lì, un anno è passato: sviluppi che nessuno ti ha spiegato, uno scontro finale
di pochi minuti, un epilogo aperto. Quello c'è di negativo – non
la Torcia Umana di colore che tanto ha fatto strepitare (momento ironia: la
fiamma l'avrà scurito un po' troppo?), né il mondo alternativo che
ricorda preoccupantemente i wallpaper dozzinali del mio portatile: ossia, il sembrare
il pilot introduttivo di un telefilm senza un to be continued.
(5,5)
Io
odio il cinecomic. Così, quest'anno, era cominciato un post in cui –
tra posizioni finto snob e ricordi – mi ero per metà
ricreduto. Non odiavo il fumetto quando era come il Daredevil
Netflix, ad esempio. Per il
resto sì. Neanche quando il
film è amatissimo io riesco ad apprezzarlo; figuratevi quante
probabilità ci siano che mi piaccia, invece, il disastro annunciato
che neanche gli appassionati salvano.
Fantastic 4 – flop
clamoroso, rinnegato perfino da chi l'ha diretto e interpretato – a sorpresa non mi è dispiaciuto. Alla
sufficienza piena non arriva, e facile sarebbe fare ironia con
l'aggettivo fantastico, mai così fuori luogo qui, e con il numero
nel titolo che, per magia, va a richiamare il quattro secco della
valutazione finale. Prima di vederlo, e viva il pregiudizio, avevo
un'idea per un bel commento negativo. Ma poi, pronto al
peggio, mi sono mediamente goduto quest'ora e mezza, vista solo per
una curiosità di quelle brutte: quando mai di mia spontanea volontà
guarderei un prodotto Marvel? Vista a
suo tempo la saga originale, che mi aveva diverto e poco più, non mi
ha turbato l'idea di un reboot. Il cast, inoltre, vanta alcuni tra gli attori più promettenti della nuova
generazione: la rivelazione di
Whiplash, la sorella
meno impegnata di Rooney Mara, il Billy Elliot cresciuto
con Von Trier e Vinterberg, il protagonista del premiato Fruitvale
Station. Questa riscrittura in
chiave giovanile, per me,
parte bene: un cenno a un'infanzia da nerd e a una lunga amicizia, la coesione non messa in gioco da nessun amore, salvare il mondo come fosse un progetto del liceo.
Spensierata, la prima ora vede un quinto membro di passaggio – un
giovane Dottor Destino non ancora cattivo – e la scoperta di un
mondo parallelo. Non ci sono momenti seriosi né la simpatia per
forza; New York non sarà nuovamente distrutta. Da qui in poi,
la situazione precipita: qualcuno schiaccia "avanti veloce". Un'ellissi narrativa buttata lì, un anno è passato: sviluppi che nessuno ti ha spiegato, uno scontro finale
di pochi minuti, un epilogo aperto. Quello c'è di negativo – non
la Torcia Umana di colore che tanto ha fatto strepitare (momento ironia: la
fiamma l'avrà scurito un po' troppo?), né il mondo alternativo che
ricorda preoccupantemente i wallpaper dozzinali del mio portatile: ossia, il sembrare
il pilot introduttivo di un telefilm senza un to be continued.
(5,5)
 Gillian
Flynn – dopo il fenomeno Gone Girl – non
ci ha messo molto a tornare al cinema. Presta la sua penna al francese
Gilles Paquet-Brenner. Dark Places è poliziesco non particolarmente piaciuto in rete, di cui mi sono concesso
direttamente il film, senza prima passare per il romanzo. Come saprà qualche lettore, parla di un caso di cronaca
riportato alla luce dopo trent'anni: Libby Day – unica
sopravvissuta al massacro di famiglia di cui è stato dichiarato
colpevole il fratello maggiore –
adesso è una donna che ha bisogno di soldi e pace. Non indaga per
sete di giustizia, ma per conto di uno strano club finanziato da appassionati di crimini irrisolti: torna
ad aprire la porta al passato, e scopre che forse il mostro in galera aveva avuto un ruolo marginale in quella notte
di sangue. Cos'è successo davvero? Nelle zone d'ombra del titolo,
una storia tra passato e presente, ambientata in una America rurale,
dura e polverosa: le fattorie pignorate, le bettole che attirano i
papà alcolizzati, i ragazzini precoci che adorano il Demonio. I paragoni scattano e
non sembrano tenere in considerazione lo spirito
diverso delle due storie: quella proposta da Fincher, cinica e
all'insegna del colpo di scena; questa a cura del modesto regista di
La chiave di Sara – capace, anche in quell'occasione, di
districarsi con fluidità tra diversi piani temporali – verosimile
e lineare. Davanti a una svolta non perevista ma poco incisiva,
ho però avuto l'impressione che sin dall'inizio Dark Places fosse
una piccola storia; ma il risultato – nonostante le imperfezioni e
i limiti – è più che sufficiente. Merito di una confezione classica e di un ritmo lento, che ti lascia apprezzare più il dramma ambientato in quei sonnacchiosi
anni ottanta che il giallo contemporaneo. Ottima la scelta dei
comprimari – una sexy Chloe Moretz, una Christina Hendricks dimessa, un Nicholas Hoult che ha fatto di
meglio altrove – e prevedibilmente in parte la Theron, camaleontica e dello
stile androgino; il viso tirato per tutta la durata del film. (7)
Gillian
Flynn – dopo il fenomeno Gone Girl – non
ci ha messo molto a tornare al cinema. Presta la sua penna al francese
Gilles Paquet-Brenner. Dark Places è poliziesco non particolarmente piaciuto in rete, di cui mi sono concesso
direttamente il film, senza prima passare per il romanzo. Come saprà qualche lettore, parla di un caso di cronaca
riportato alla luce dopo trent'anni: Libby Day – unica
sopravvissuta al massacro di famiglia di cui è stato dichiarato
colpevole il fratello maggiore –
adesso è una donna che ha bisogno di soldi e pace. Non indaga per
sete di giustizia, ma per conto di uno strano club finanziato da appassionati di crimini irrisolti: torna
ad aprire la porta al passato, e scopre che forse il mostro in galera aveva avuto un ruolo marginale in quella notte
di sangue. Cos'è successo davvero? Nelle zone d'ombra del titolo,
una storia tra passato e presente, ambientata in una America rurale,
dura e polverosa: le fattorie pignorate, le bettole che attirano i
papà alcolizzati, i ragazzini precoci che adorano il Demonio. I paragoni scattano e
non sembrano tenere in considerazione lo spirito
diverso delle due storie: quella proposta da Fincher, cinica e
all'insegna del colpo di scena; questa a cura del modesto regista di
La chiave di Sara – capace, anche in quell'occasione, di
districarsi con fluidità tra diversi piani temporali – verosimile
e lineare. Davanti a una svolta non perevista ma poco incisiva,
ho però avuto l'impressione che sin dall'inizio Dark Places fosse
una piccola storia; ma il risultato – nonostante le imperfezioni e
i limiti – è più che sufficiente. Merito di una confezione classica e di un ritmo lento, che ti lascia apprezzare più il dramma ambientato in quei sonnacchiosi
anni ottanta che il giallo contemporaneo. Ottima la scelta dei
comprimari – una sexy Chloe Moretz, una Christina Hendricks dimessa, un Nicholas Hoult che ha fatto di
meglio altrove – e prevedibilmente in parte la Theron, camaleontica e dello
stile androgino; il viso tirato per tutta la durata del film. (7)
 Bradley
Cooper è un eroe in congedo – traumi di guerra dopo American
Sniper? - che arriva alle
Hawaii con un gamba dolorante e piani confusi. Riallaccia rapporti
con una Rachel McAdams mai scordata; si innamora di un rigido
caporale con gli occhi di Emma Stone; finanziato da un
esagerato Bill Murray che vuole comprarsi il cielo, fa da paciere tra
americani e indigeni. Questo e qualcos'altro, con illustri comparse
che non vi sto a elencare e un intreccio a metà tra la
commedia sentimentale e la spy story, capita in Aloha, ultimo
film del buon Cameron Crowe – nel mio cuore a vita per Quasi
Famosi e Vanilla Sky – su cui, in Patria, hanno detto
peste e corna. Se ingiustamente, guardate, non saprei: la stampa
criticava posizioni politiche che non ho colto e un razzismo di fondo nel descrivere le tribù locali;
non la sceneggiatura – disimpegnata, ma estremamente gradevole –
e il lavoro dei protagonisti – rilassati e bene amalgamati.
Glissando perciò su questi elementi – forse dolenti per gli
yankee, ma noi siamo italiani, quindi chissene – resta il fatto che Aloha, film di puro
intrattenimento sorretto da un ottimo cast e da più di qualche scena
brillante – il dialogo muto tra Cooper e un laconico Krasinski, il
ballo a Natale tra la Stone e Murray -, diverte e intrattiene con
intelligenza. Dovrebbe sorprenderici la cosa? Direi di no, con un
Crowe che ci mancava, i suoi classici personaggi combattuti e dai
lavori inconsueti, la profondità e l'acume, gli epiloghi non
scontati. Se la surreale parentesi spionistica non si segue con molta
convinzione, è anche perché si è impegnati a vedere il protagonista
alle prese con due delle donne della mia vita, su uno sfondo esotico
che non fa da cornice
folkloristica. Per una volta il titolo italiano non sbaglia, in
ballo infatti c'è il cielo, ma preferisco quello internazionale,
che significa “ciao” e “arrivederci”. L'unico termine che conosco insieme a ohana,
direttamente da Lilo & Sitch:
“famiglia”. Altra parola che può andare tanto bene, per
riassumere questa storia di salvataggi sopra le righe, nidi, sogni di
secondo taglio. (7)
Bradley
Cooper è un eroe in congedo – traumi di guerra dopo American
Sniper? - che arriva alle
Hawaii con un gamba dolorante e piani confusi. Riallaccia rapporti
con una Rachel McAdams mai scordata; si innamora di un rigido
caporale con gli occhi di Emma Stone; finanziato da un
esagerato Bill Murray che vuole comprarsi il cielo, fa da paciere tra
americani e indigeni. Questo e qualcos'altro, con illustri comparse
che non vi sto a elencare e un intreccio a metà tra la
commedia sentimentale e la spy story, capita in Aloha, ultimo
film del buon Cameron Crowe – nel mio cuore a vita per Quasi
Famosi e Vanilla Sky – su cui, in Patria, hanno detto
peste e corna. Se ingiustamente, guardate, non saprei: la stampa
criticava posizioni politiche che non ho colto e un razzismo di fondo nel descrivere le tribù locali;
non la sceneggiatura – disimpegnata, ma estremamente gradevole –
e il lavoro dei protagonisti – rilassati e bene amalgamati.
Glissando perciò su questi elementi – forse dolenti per gli
yankee, ma noi siamo italiani, quindi chissene – resta il fatto che Aloha, film di puro
intrattenimento sorretto da un ottimo cast e da più di qualche scena
brillante – il dialogo muto tra Cooper e un laconico Krasinski, il
ballo a Natale tra la Stone e Murray -, diverte e intrattiene con
intelligenza. Dovrebbe sorprenderici la cosa? Direi di no, con un
Crowe che ci mancava, i suoi classici personaggi combattuti e dai
lavori inconsueti, la profondità e l'acume, gli epiloghi non
scontati. Se la surreale parentesi spionistica non si segue con molta
convinzione, è anche perché si è impegnati a vedere il protagonista
alle prese con due delle donne della mia vita, su uno sfondo esotico
che non fa da cornice
folkloristica. Per una volta il titolo italiano non sbaglia, in
ballo infatti c'è il cielo, ma preferisco quello internazionale,
che significa “ciao” e “arrivederci”. L'unico termine che conosco insieme a ohana,
direttamente da Lilo & Sitch:
“famiglia”. Altra parola che può andare tanto bene, per
riassumere questa storia di salvataggi sopra le righe, nidi, sogni di
secondo taglio. (7)
 Una
stella in ascesa racconta a una giornalista l'incarico con
una compagnia in cui – suo malgrado – ha seminato zizzania.
Quella nuova diva, infatti, un tempo lavorava come squillo in attesa
della grande svolta: uno dei suoi amanti – un regista filantropo o
puttaniere – aveva finanzato generosamente i suoi sogni e, per pura
coincidenza, si era ritrovata a recitare proprio nello spettacolo di
quest'ultimo. Ma con una moglie sospettosa, un attore inaffidabile
che sa tutti i dettagli del tradimento, uno scrittore pazzo d'amore, lo spettacolo con la bella Isabella – ingenua, nonostante
la professione più antica del mondo – sarà stato allestito senza
divorzi o, per un crimine d'amore, reputazioni rovinate? Tutto può
accadere a Broadway – in inverno da noi – è il
ritorno al cinema di Peter Bogdanovich, settantaseienne che – come
sapranno i cinefili doc, dunque non troppo io – è un'istituzione
quando si parla di commedia. Qui, tutti in un colpo, il Wilson
cascamorto, l'Ifans istrione, una Aniston pazza; soprattutto, una
Imogen Poots – se sia più bella o simpatica non si sa, con il suo
personaggio alla Audrey, di gran classe – da cui portano tutte le
strade. Newyorkese con orgoglio, Bogdanovich cita sé stesso,
Lubitsch e l'Allen più brillante, in un film dalla comicità
sofisticata, in cui una scrittura pimpante, un cast all stars e
colori retrò trovano l'approvazione di un pubblico che stravede facilmente per le cose
così. Luccicanti, parlatissime, d'altre epoche. Non un attore fuori
forma o un momento di silenzio, quando tutti si affidano a un'anziana
leggenda e fraintendimenti e battute fulminanti – in cui si parla
di sentimenti, show business e dintorni – ti sommergono come
un'onda e ti intontiscono di chiacchiere. Ma giusto un po'. (6,5)
Una
stella in ascesa racconta a una giornalista l'incarico con
una compagnia in cui – suo malgrado – ha seminato zizzania.
Quella nuova diva, infatti, un tempo lavorava come squillo in attesa
della grande svolta: uno dei suoi amanti – un regista filantropo o
puttaniere – aveva finanzato generosamente i suoi sogni e, per pura
coincidenza, si era ritrovata a recitare proprio nello spettacolo di
quest'ultimo. Ma con una moglie sospettosa, un attore inaffidabile
che sa tutti i dettagli del tradimento, uno scrittore pazzo d'amore, lo spettacolo con la bella Isabella – ingenua, nonostante
la professione più antica del mondo – sarà stato allestito senza
divorzi o, per un crimine d'amore, reputazioni rovinate? Tutto può
accadere a Broadway – in inverno da noi – è il
ritorno al cinema di Peter Bogdanovich, settantaseienne che – come
sapranno i cinefili doc, dunque non troppo io – è un'istituzione
quando si parla di commedia. Qui, tutti in un colpo, il Wilson
cascamorto, l'Ifans istrione, una Aniston pazza; soprattutto, una
Imogen Poots – se sia più bella o simpatica non si sa, con il suo
personaggio alla Audrey, di gran classe – da cui portano tutte le
strade. Newyorkese con orgoglio, Bogdanovich cita sé stesso,
Lubitsch e l'Allen più brillante, in un film dalla comicità
sofisticata, in cui una scrittura pimpante, un cast all stars e
colori retrò trovano l'approvazione di un pubblico che stravede facilmente per le cose
così. Luccicanti, parlatissime, d'altre epoche. Non un attore fuori
forma o un momento di silenzio, quando tutti si affidano a un'anziana
leggenda e fraintendimenti e battute fulminanti – in cui si parla
di sentimenti, show business e dintorni – ti sommergono come
un'onda e ti intontiscono di chiacchiere. Ma giusto un po'. (6,5) L'ultimo
Fincher aveva lasciato scoprire ai più il potenziale di una grande attrice. Dopo Gone
Girl, si attendevano riconferme dalla Pike; collaborazioni
importanti e nuovi progetti, anche se, cronologicamente, si ha la
sfortuna di imbattersi prima in Return to sender. Il
lavoro direttamente successivo a quello che la portò a un passo così
dall'Oscar: scivolone imperdonabile. Perché è un thriller scialbo e
inconcludente; perché il personaggio di Miranda – algida,
perfetta, impenetrabile – è la fotocopia in bianco e nero di Amy. Un anno dopo, con un'altra vendetta e un'altra regina di
ghiaccio? Scelta sbagliata e ingiustificata, dato uno script inconsistente e l'idea vecchia. La
storia della perfetta infermiera che, in pieno giorno, viene stuprata
da un fattorino (no, non lo mandava Zalando - "urla di piacere") e medita punizioni poco
esemplari, infatti, regala un'unica sorpresa: la vendetta ci sarà,
ma rimandata di un'ora. Se la violenza manca, si nega all'appello anche una degna caratterizzazione
dei personaggi – incomprensibili – e il minimo sindacabile di
coinvolgimento. Lei ha la vecchia maschera, Nick Nolte è il papà
burbero e premuroso che sempre gli riesce; nota positiva, Shiloh Fernandez: giovane antagonista che intriga. Il resto: il
trauma e la nascita di disturbi ossessivi, le cure miracolose della legge del taglione, innumerevoli
cambi d'abito tollarabili unicamente per il fisico statuario della
Pike. Bellissima sempre, ma qui tornata alla leziosità e al rigore
di quando nessuno la conosceva. Rosamunde mia, perché?
(4)
L'ultimo
Fincher aveva lasciato scoprire ai più il potenziale di una grande attrice. Dopo Gone
Girl, si attendevano riconferme dalla Pike; collaborazioni
importanti e nuovi progetti, anche se, cronologicamente, si ha la
sfortuna di imbattersi prima in Return to sender. Il
lavoro direttamente successivo a quello che la portò a un passo così
dall'Oscar: scivolone imperdonabile. Perché è un thriller scialbo e
inconcludente; perché il personaggio di Miranda – algida,
perfetta, impenetrabile – è la fotocopia in bianco e nero di Amy. Un anno dopo, con un'altra vendetta e un'altra regina di
ghiaccio? Scelta sbagliata e ingiustificata, dato uno script inconsistente e l'idea vecchia. La
storia della perfetta infermiera che, in pieno giorno, viene stuprata
da un fattorino (no, non lo mandava Zalando - "urla di piacere") e medita punizioni poco
esemplari, infatti, regala un'unica sorpresa: la vendetta ci sarà,
ma rimandata di un'ora. Se la violenza manca, si nega all'appello anche una degna caratterizzazione
dei personaggi – incomprensibili – e il minimo sindacabile di
coinvolgimento. Lei ha la vecchia maschera, Nick Nolte è il papà
burbero e premuroso che sempre gli riesce; nota positiva, Shiloh Fernandez: giovane antagonista che intriga. Il resto: il
trauma e la nascita di disturbi ossessivi, le cure miracolose della legge del taglione, innumerevoli
cambi d'abito tollarabili unicamente per il fisico statuario della
Pike. Bellissima sempre, ma qui tornata alla leziosità e al rigore
di quando nessuno la conosceva. Rosamunde mia, perché?
(4)

