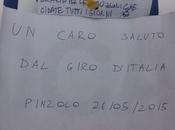“Prendi uno sport, togli tutta l’ipocrisia e otterrai qualcosa di simile al rugby”. È sin troppo gaudente, con i tempi che corrono e che, impietosamente, marcano le distanze fra un popolo in boccheggiamento economico ed eroi sportivi strampompati (economicamente e fisicamente parlando, s’intende), leggere una testimonianza di autenticità come quella racchiusa in “Andare avanti guardando indietro”. Il libello pretende molto da se stesso. Lo pretende la Ponte alle Grazie. Lo pretendono le sei mani e tre cervelli che ci hanno lavorato: Mauro e Mirco Bergamasco (i fratellissimi icone del rugby tricolore) con Matteo Rampin. Rampin che gli stessi Bergamaschi sbeffeggiano con l’appellativo di “strizzacervelli”. In effetti, medico psicologo ed assistente personale di molti atleti professionisti. Una pretesa soddisfatta. “Andare avanti guardando indietro” pretende per fissare una meta, per puntare un paletto, per gettare l’obiettivo. Sarà per questo motivo che non racchiude inutilità ovvie e facciate inutili. Sarà per questo che ostracizza da sé, mediante atto di ripulsa, una vanità vacua, non pratica.
Si diceva, è oltremodo consolante leggere e sentir raccontare di un mondo che, spesso, la poca poeticità televisiva ha sconvolto, seppellito sotto cumuli di macerie spettacolaristiche. È rassicurante tornare a scorrere l’intera gamma di dolore, sangue, agonismo, rivalità che s’arresta dirimpetto al rispetto. E quelle immagini cautamente ricomposte di avversari che non sono nemici, di maglie scambiate in campo e sugli spalti, di terzi tempi venerati come l’essenza stessa della contesa, di muscoli tesi e spalle lussate, corse liberatore e storie di squadra. Una birra, un posto a tavola, fiumi di offese scherzose e bonarie. Mostrare l’altra faccia di sé all’altro. Per denudarsi, uomo di fronte a uomo, in una contesa che è con-tatto. Che si manifesta attraverso un’insistenza violazione degli spazi altri, lo sfregamento di arti contro arti, membra contro membra, spalle contro menti, polsi contro nasi, orecchie contro capelli, sangue contro sangue. Un amalgama indistinto che mette tiene insieme tutto. Che forgia un essere che ha tutti gli odori di fatica e tutte le ferite dello scontro fisico. Ma anche tutta la delicatezza di un gesto vagamente paterno, come quel pallone stretto nel concavo che si crea fra braccio e petto.
Mirco e Mauro, con Matteo, fanno delle regole del rugby, degli elementi che ne contraddistinguono la vita, una filosofia. E, di conseguenza, del testo un piccolo manuale. Un libro che, volontariamente, assume i connotati di un cammino di crescita. E il cammino, come ogni iter di maturazione, sottende sforzi umani e sovrumani, il desiderio e la capacità di voler andare oltre se stessi, scherzare con i propri limiti, irretire i dubbi, vincere le paure sapendo che gli uni e le altre sono comunque confinate in un punto periferico dei pensieri, in un angolo ristretto dell’emozione. E lì restano, zittiti dalla cascata di adrenalina sprigionata dal verde del campo dal bianco delle linee, dalla cromia della propria maglia, dal numero sulle spalle. Numero che è appartenenza, esemplificazione di una missione, concretizzazione di un obbligo. Verso la propria persona e verso tutto il gruppo. La dedizione alla squadra è elemento totalizzante, esteriorizzata in quella piccola grande apparentemente inspiegabile regola dell’avanzare passando palla a chi sta dietro. Da cui, appunto, la titolazione del libro. Nei fatti, si tratta dello schieramento del rugby a tutto titolo fra le discipline sportive di squadra. Una regola che è forma mentis e che “ci ricorda che quando si è forti si è potenzialmente deboli”. In quanto è esattamente nell’istante preciso in cui si è soli contro l’avversario, tensioni contro, corpi nella protesa dello scontro, dolori potenziali che si fanno prossimi, rivi alla fase della convergenza, ebbene è proprio in quell’attimo “in cui abbiamo la situazione in mano” che ci rende conto che “per portare a termine il compito può essere etile effettuare un dietro front, una battuta d’arresto, effettuale una diversione dalla traiettoria, mettere in salvo quanto è già stato conquistato”. È la certezza che s’impone, il riconoscimento della forza propulsiva del collettivo, il trionfo opportuno ed anche opportunistico dell’umiltà quale “virtù strategica”.
Eccola schiudersi la potenza racchiusa in questo testo. Una potenza che è più di mente che di muscolo, che sa supplire al rigonfiamento del bicipite con l’immediatezza della sinapsi. Equilibrio, controllo, dosaggio. Una linea sottile, un varco delicato, uno sforzo stentoreo. Tendere alla disciplina significa non soltanto accettare le regole, significa interiorizzarle, trasformarle in proprio bagaglio, in idem sentire. In questo sforzo, i due omaccioni li immagini mutati in clowneschi funamboli del’ovale, sospesi su una corda a destreggiarsi per non cadere. Da lissù ululano sicuri che “non c’è forza più grande di quella di chi riesce ad esprimere in modo misurato e gentile il proprio potere, limitandone l’uso allo stretto indispensabile, senza mai oltrepassare il segno”. Segno che è la tacca tracciata in terra dalla decenza sportiva, che è decenza umana. Perché “chi è forte non ha bisogno di ostentarlo”. Perché “essere forte con i deboli e debole con i forti è un’abitudine che spesso deriva dalla cattiva coscienza riguardo la propria (presunta) potenza fisica”.

Ed allora viene sul serio da domandarsi con tanto di arrovellamento encefalico se si tratti sul serio di filosofia. Se sia finalmente giunta l’ora di resettare le banche dati delle nostre storiche convinzioni collettive per abbracciare, in una mischia etica, una nuova regola che suona sinceramente democratica. Intimamente democratica. Sentitamente democratica. Eppure non è filosofia. “È solo rugby”.