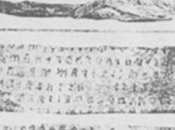Nei giorni scorsi mi sono imbattuto, tra le pagine ariostesche (link), in una delle scenette “comiche” meglio riuscite al Poeta:
Qual istordito e stupido aratore,
poi ch’è passato il fulmine, si leva
di là dove l’altissimo fragore
appresso ai morti buoi steso l’aveva;
che mira senza fronde e senza onore
il pin che di lontan veder soleva:
tal si levò il pagano a piè rimaso,
Angelica presente al duro caso.
È il verso sessantacinquesimo del Primo Canto, colto nel momento in cui Bradamante (ancora non conosciuta per tale, soprattutto nel genere sessuale) umilia il fieramente goffo Sacripante. Quest’ultimo è stordito come se un fulmine a ciel sereno l’abbia colpito. Ora, vero è che Stupido deriva da “Stupeo”, ossia “stupefatto”, tuttavia non c’è dubbio che l’Ariosto voglia un po’ giocar sul termine e sull’interpretazione. D’altronde ciò che resta dell’immagine creata non è dissimile (non aliter) da qualche scena di fantozzesca memoria, con l’aggravante che qui era persino presente Angelica. Quindi riesce difficile individuare subito i riferimenti colti. In primo luogo l’Iliade, al Libro XIV:
Con quel fragore
che dal foco di Giove fulminata
giù ruina una quercia, e grave intorno
del grave zolfo si diffonde il puzzo:
l’arator, che cadersi accanto vede
la folgore tremenda, imbianca e trema:
così stramazza Ettòr…
L’eroe di Ilio – l’eroe per eccellenza – è stato colpito da un macigno scagliato da Aiace, così stramazza al suolo privo di sensi, come fosse stato una quercia colpita da un fulmine. Il momento è altamente drammatico. Non diversamente (Non Aliter) nel secondo richiamo colto implicito nel Furioso:
Non aliter stupui, quam qui Iovis ignibus ictus
vivit et est vitae nescius ipse suae.
Ovidio (Tristia, Libro Primo) parla della sua disgrazia, l’esser stato mandato in esilio da Roma. Altro momento drammatico, lo “stupui” è veramente la sensazione di stupore di chi è frastornato, dopo esser stato centrato dalla folgore, e non capisce se è in vita o meno.
In altre parole, Ludovico Ariosto ha messo in scena una parodia. Non aliter – per l’ennesima volta – ritengo si possa definire l’intenzione di chi, nell’ambito di una attività ricettiva situata geograficamente nel sud-est siciliano, vuol offrire a pagamento l’opportunità di bere un Nero d’Avola abilmente imbottigliato dalle parti di Lecco. Ci s’intenda, sto parlando di una struttura prestigiosa, e spesso associata a quel buon “chilometro zero” che tanto di questi tempi è perseguito ai fini di un livello qualitativo accettabile o alla buona digestione. Uno di quei posti dove di sottofondo si diffondono note di ud, tra palmizi e contestuali spazi storicamente falsi rievocanti la bellezza del patio. Luoghi ove le cibarie offerte a pagamento sono strettamente riconducibili alla Cultura gastronomica locale. Ovvio che a queste condizioni, al sommelier, non si potrà cercare un Sangiovese. Il Nero d’Avola è d’obbligo, come l’abito scuro ad una occasione di gala. Se l’etichetta, l’icona (eikon, platonicamente rievocante una sorta di compartecipazione tra il mondo sensibile e quello delle idee), riporta la dicitura “Nero d’Avola”, e in secondo piano Typical Geographical Indication (I.G.T. ?), non si può che pensare – con bonomia – di esser (non aliter) in presenza di una Parodia. Forse ai nostri danni? Forse siamo noi gli “stupefatti” colpiti dal fulmine?
Concludendo, volete sapere alla fine com’era il vino?
Non buono…
Gaetano Celestre