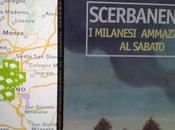La Malinconia
Malinconia
la vita mia
struggi terribilmente;
e non v’è al mondo, non c’è al mondo niente
che mi divaghi.
Niente, o una sola
casa. Figliola,
quella per me saresti.
S’apre una porta; in tue succinte vesti
entri, e mi smaghi.
Piccola tanto,
fugace incanto
di primavera. I biondi
riccioli molti nel berretto ascondi,
altri ne ostenti.
Ma giovinezza,
torbida ebbrezza,
passa, passa l’amore.
Restan sì tristi nel dolente cuore,
presentimenti.
Malinconia,
la vita mia
amò lieta una cosa,
sempre: la Morte. Or quasi è dolorosa,
ch’altro non spero.
Quando non s’ama
più, non si chiama
lei la liberatrice;
e nel dolore non fa più felice
il suo pensiero.
Io non sapevo
questo; ora bevo
l’ultimo sorso amaro
dell’esperienza. Oh quanto è mai più caro
il pensier della morte,
al giovanetto,
che a un primo affetto
cangia colore e trema.
Non ama il vecchio la tomba: suprema
crudeltà della sorte.
***
Fanciulle
Maria ti guarda con gli occhi un poco
come Venere loschi.
Cielo par che s’infoschi
quello sguardo, il suo accento è quasi roco.
Non è bella, né in donna ha quei gentili
atti, cari agli umani;
belle ha solo le mani,
mani da baci, mani signorili.
Dove veste, sue vesti son richiami
per il maschio, un’asprezza
strana di tinte. È mezza
bambina e mezza bestia. Eppure l’ami.
Sai ch’è ladra e bugiarda, una nemica
dei tuoi intimi pregi;
ma quanto più la spregi
più la vorresti alle tue voglie amica.
***
A mia moglie
Tu sei come una giovane
una bianca pollastra.
Le si arruffano al vento
le piume, il collo china
per bere, e in terra raspa;
ma, nell’andare, ha il lento
tuo passo di regina,
ed incede sull’erba
pettoruta e superba.
È migliore del maschio.
È come sono tutte
le femmine di tutti
i sereni animali
che avvicinano a Dio,
Così, se l’occhio, se il giudizio mio
non m’inganna, fra queste hai le tue uguali,
e in nessun’altra donna.
Quando la sera assonna
le gallinelle,
mettono voci che ricordan quelle,
dolcissime, onde a volte dei tuoi mali
ti quereli, e non sai
che la tua voce ha la soave e triste
musica dei pollai.
Tu sei come una gravida
giovenca;
libera ancora e senza
gravezza, anzi festosa;
che, se la lisci, il collo
volge, ove tinge un rosa
tenero la tua carne.
se l’incontri e muggire
l’odi, tanto è quel suono
lamentoso, che l’erba
strappi, per farle un dono.
È così che il mio dono
t’offro quando sei triste.
Tu sei come una lunga
cagna, che sempre tanta
dolcezza ha negli occhi,
e ferocia nel cuore.
Ai tuoi piedi una santa
sembra, che d’un fervore
indomabile arda,
e così ti riguarda
come il suo Dio e Signore.
Quando in casa o per via
segue, a chi solo tenti
avvicinarsi, i denti
candidissimi scopre.
Ed il suo amore soffre
di gelosia.
Tu sei come la pavida
coniglia. Entro l’angusta
gabbia ritta al vederti
s’alza,
e verso te gli orecchi
alti protende e fermi;
che la crusca e i radicchi
tu le porti, di cui
priva in sé si rannicchia,
cerca gli angoli bui.
Chi potrebbe quel cibo
ritoglierle? chi il pelo
che si strappa di dosso,
per aggiungerlo al nido
dove poi partorire?
Chi mai farti soffrire?
Tu sei come la rondine
che torna in primavera.
Ma in autunno riparte;
e tu non hai quest’arte.
Tu questo hai della rondine:
le movenze leggere:
questo che a me, che mi sentiva ed era
vecchio, annunciavi un’altra primavera.
Tu sei come la provvida
formica. Di lei, quando
escono alla campagna,
parla al bimbo la nonna
che l’accompagna.
E così nella pecchia
ti ritrovo, ed in tutte
le femmine di tutti
i sereni animali
che avvicinano a Dio;
e in nessun’altra donna.
***
La capra
Ho parlato a una capra.
Era sola sul prato, era legata.
Sazia d’erba, bagnata
dalla pioggia, belava.
Quell’uguale belato era fraterno
al mio dolore. Ed io risposi, prima
per celia, poi perché il dolore è eterno,
ha una voce e non varia.
Questa voce sentiva
gemere in una capra solitaria.
In una capra dal viso semita
sentiva querelarsi ogni altro male,
ogni altra vita.
***
Squadra paesana
Anch’io tra i molti vi saluto, rosso-
alabardati,
sputati
dalla terra natia, da tutto un popolo
amati.
Trepido seguo il vostro gioco.
Ignari
esprimete con quello antiche cose
meravigliose
sopra il verde tappeto, all’aria, ai chiari
soli d’inverno.
Le angoscie
che imbiancano i capelli all’improvviso,
sono da voi così lontane! La gloria
vi dà un sorriso
fugace: il meglio onde disponga. Abbracci
corrono tra di voi, gesti giulivi.
Giovani siete, per la madre vivi;
vi porta il vento a sua difesa. V’ama
anche per questo il poeta, dagli altri
diversamente – ugualmente commosso.
***
Il Borgo
Fu nelle vie di questo
Borgo che nuova cosa
m’avvenne.
Fu come un vano
sospiro
il desiderio improvviso d’uscire
di me stesso, di vivere la vita
di tutti,
d’essere come tutti
gli uomini di tutti
i giorni.
Non ebbi io mai sì grande
gioia, né averla dalla vita spero.
Vent’anni avevo quella volta, ed ero
malato. Per le nuove
strade del Borgo il desiderio vano
come un sospiro
mi fece suo.
Dove nel dolce tempo
d’infanzia
poche vedevo sperse
arrampicate casette sul nudo
della collina,
sorgeva un Borgo fervente d’umano
lavoro. In lui la prima
volta soffersi il desiderio dolce
e vano
d’immettere la mia dentro la calda
vita di tutti,
d’essere come tutti
gli uomini di tutti
i giorni.
La fede avere
di tutti, dire
parole, fare
cose che poi ciascuno intende, e sono,
come il vino ed il pane,
come i bimbi e le donne,
valori
di tutti. Ma un cantuccio,
ahimé, lasciavo al desiderio, azzurro
spiraglio,
per contemplarmi da quello, godere
l’alta gioia ottenuta
di non esser più io,
d’essere questo soltanto: fra gli uomini
un uomo.
Nato d’oscure
vicende,
poco fu il desiderio, appena un breve
sospiro. Lo ritrovo
- eco perduta
di giovinezza – per le vie del Borgo
mutate
più che mutato non sia io. Sui muri
dell’alte case,
sugli uomini e i lavori, su ogni cosa,
è sceso il velo che avvolge le cose
finite.
La chiesa è ancora
gialla, se il prato
che la circonda è meno verde. Il mare,
che scorgo al basso, ha un solo bastimento,
enorme,
che, fermo, piega da un parte. Forme,
colori,
vita onde nacque il mio sospiro dolce
e vile, un mondo
finito. Forme,
colori,
altri ho creati, rimanendo io stesso,
solo con il mio duro
patire. E morte
m’aspetta.
Ritorneranno,
o a questo
Borgo, o sia a un altro come questo, i giorni
del fiore. Un altro
rivivrà la mia vita,
che in un travaglio estremo
di giovinezza, avrà per egli chiesto,
sperato,
d’immettere la sua dentro la vita
di tutti,
d’essere come tutti
gli appariranno gli uomini di un giorno
d’allora.
(Dal Canzoniere, Milano, Garzanti, 1951)
***
Tre momenti
Di corsa usciti a mezzo il campo, date
prima il saluto alle tribune. Poi,
quello che nasce poi,
che all’altra parte rivolgete, a quella
che più nera si accalca, non è cosa
da dirsi, non è cosa ch’abbia un nome.
Il portiere su e giù cammina come
sentinella. Il pericolo
lontano è ancora.
Ma se in un nembo s’avvicina, oh allora
una giovane fiera si accovaccia
e all’erta spia.
Festa è nell’aria, festa in ogni via.
Se per poco, che importa?
Nessun’offesa varcava la porta,
s’incrociavano grida ch’eran razzi.
La vostra gloria, undici ragazzi,
come un fiume d’amore orna Trieste.
(Dal Canzoniere, cit.)
***
L’ora nostra
Sai un’ora del giorno che più bella
sia della sera? tanto
più bella e meno amata? È quella
che di poco i suoi sacri ozi precede;
l’ora che intensa è l’opera, e si vede
la gente mareggiare nelle strade;
sulle mole quadrate delle case
una luna sfumata, una che appena
discerni nell’aria serena.
È l’ora che lasciavi la campagna
per goderti la tua cara città,
dal golfo luminoso alla montagna
varia d’aspetti in sua bella unità;
l’ora che la mia vita in piena va
come un fiume al suo mare;
e il mio pensiero, il lesto camminare
della folla, gli artieri in cima all’alta
scala, il fanciullo che correndo salta
sul carro fragoroso, tutto appare
fermo nell’atto, tutto questo andare
ha una parvenza d’immobilità.
È l’ora grande, l’ora che accompagna
meglio la nostra vendemmiante età.
(Dal Canzoniere, cit.)
***
Teatro degli Artigianelli
Falce martello e la stella d’Italia
ornano nuovi la sala. Ma quanto
dolore per quel segno su quel muro!
Esce, sorretto dalle grucce, il Prologo.
Saluta al pugno; dice sue parole
perché le donne ridano e i fanciulli
che affollano la povera platea.
Dice, timido ancora, dell’idea
che gli animi affratella; chiude: “E adesso
faccio come i tedeschi: mi ritiro”.
Tra un atto e l’altro, alla Cantina, in giro
rosseggia parco ai bicchieri l’amico
dell’uomo, cui rimargina ferite,
gli chiude solchi dolorosi; alcuno
venuto qui da spaventosi esigli,
si scalda a lui come chi ha freddo al sole.
Questo è il Teatro degli Artigianelli,
quale lo vide il poeta nel mille
novecentoquarantaquattro, un giorno
di Settembre, che a tratti
rombava ancora il canone, e Firenze
taceva, assorta nelle sue rovine.
(Dal Canzoniere, cit.)
Il torrente
Tu così avventuroso nel mio mito,
così povero sei fra le tue sponde.
Non hai, ch’io veda, margine fiorito.
Dove ristagni scopri cose immonde.
Pur, se ti guardo, il cor d’ansia mi stringi,
o torrentello.
Tutto il tuo corso è quello
del mio pensiero, che tu risospingi
alle origini, a tutto il fronte e il bello
che in te ammiravo; e se ripenso i grossi
fiumi, l’incontro con l’avverso mare,
quest’acqua onde tu appena i piedi arrossi
nudi a una lavandaia,
la più pericolosa e la più gaia,
con isole e cascate, ancor m’appare;
e il poggio da cui scendi è una montagna.
Sulla tua sponda lastricata l’erba
cresceva, e cresce nel ricordo sempre;
sempre è d’intorno a te sabato sera;
sempre ad un bimbo la sua madre austera
rammenta che quest’acqua è fuggitiva,
che non ritrova più la sua sorgente,
né la sua riva; sempre l’ancor bella
donna si attrista, e cerca la sua mano
il fanciulletto, che ascoltò uno strano
confronto tra la vita nostra e quella
della corrente.
***
Trieste
(da Trieste e una donna, 1910-12)
Ho attraversata tutta la città.
Poi ho salita un’erta,
popolosa in principio, in là deserta,
chiusa da un muricciolo:
un cantuccio in cui solo
siedo; e mi pare che dove esso termina
termini la città.
Trieste ha una scontrosa
grazia. Se piace,
è come un ragazzaccio aspro e vorace,
con gli occhi azzurri e mani troppo grandi
per regalare un fiore;
come un amore
con gelosia.
Da quest’erta ogni chiesa, ogni sua via
scopro, se mena all’ingombrata spiaggia,
o alla collina cui, sulla sassosa
cima, una casa, l’ultima, s’aggrappa.
Intorno
circola ad ogni cosa
un’aria strana, un’aria tormentosa,
l’aria natia.
La mia città che in ogni parte è viva,
ha il cantuccio a me fatto, alla mia vita
pensosa e schiva.
***
Città vecchia
(da Trieste e una donna, 1910-12)
Spesso, per ritornare alla mia casa
prendo un’oscura via di città vecchia.
Giallo in qualche pozzanghera si specchia
qualche fanale, e affollata è la strada.
Qui tra la gente che viene che va
dall’osteria alla casa o al lupanare,
dove son merci ed uomini il detrito
di un gran porto di mare,
io ritrovo, passando, l’infinito
nell’umiltà.
Qui prostituta e marinaio, il vecchio
che bestemmia, la femmina che bega,
il dragone che siede alla bottega
del friggitore,
la tumultuante giovane impazzita
d’amore,
sono tutte creature della vita
e del dolore;
s’agita in esse, come in me, il Signore.
Qui degli umili sento in compagnia
il mio pensiero farsi
più puro dove più turpe è la via.
***
Dopo la tristezza
(da Trieste e una donna, 1910-12)
Questo pane ha il sapore d’un ricordo,
mangiato in questa povera osteria,
dov’è più abbandonato e ingombro il porto.
E della birra mi godo l’amaro,
seduto del ritorno a mezza via,
in faccia ai monti annuvolati e al faro.
L’anima mia che una sua pena ha vinta,
con occhi nuovi nell’antica sera
guarda una pilota con la moglie incinta;
e un bastimento, di che il vecchio legno
luccica al sole, e con la ciminiera
lunga quanto i due alberi, è un disegno
fanciullesco, che ho fatto or son vent’anni.
E chi mi avrebbe detto la mia vita
così bella, con tanti dolci affanni,
e tanta beatitudine romita!
Umberto Saba Dal Canzoniere, ed. Einaudi, Torino 1961
Nasce a Trieste, in via Pondares, il 9 marzo 1883, da Felicita Rachele Coen ed Ugo Edoardo Poli. La madre, ebrea, viene abbandonata dal marito prima della nascita del bambino; Saba conoscerà il padre solamente in età adulta, rifiutandosi tuttavia di adottarne il cognome (quello attuale è un omaggio alla razza ebraica, nella cui lingua “saba” significa “pane”).
Dopo aver abbandonato gli studi, lavora da praticante in una casa di commercio e come mozzo su di un mercantile: militare nel corso della prima guerra mondiale, non verrà mai però chiamato al fronte.
Esordisce nella poesia con l’edizione privata de “Il mio primo libro di poesia” (1903), ma la sua autentica prima uscita pubblica è del 1911 con “Poesie”, introdotte da Silvio Benco.
Seguono, ambedue nel 1912, i componimenti di “Coi miei occhi” ed il saggio “Quello che resta da fare ai poeti”, pubblicato soltanto postumo nel 1959.
Alla fine delle attività belliche diviene proprietario d’una libreria antiquaria, cosa che si rivelerà negli anni assai giovevole pure come mezzo di sostentamento: nel ’21 pubblica il celebre “Canzoniere”, che raccoglie la produzione poetica di vent’anni, cui fanno seguito “Preludio e canzonette” (1923), “Autobiografia” ed “I prigionieri” (1924), “Figure e canti” (1926), “Preludio e fughe” (1928).
Peggiora intanto la sua sempre precaria salute psichica, tanto da indurlo a sottoporsi a serrata terapia analitica dal ’29 in avanti: inoltre, la promulgazione delle leggi razziali lo costringe a cercar rifugio prima a Parigi, poi a Firenze, dove gode della protezione di Montale e di altri intellettuali antifascisti.
Appaiono intanto le raccolte di liriche “Parole” (1934), “Ultime cose” (1944) e la seconda edizione del “Canzoniere” (1948), che gli guadagna il consenso pressoché unanime della critica. Ciò malgrado, le crisi di depressione non accennano a perdere d’intensità e lo obbligano a rifugiarsi nel quasi totale isolamento. Ricoverato presso una clinica romana nel ’53, alla morte della moglie Lina (avvenuta nel ’56) si stabilisce a Gorizia ; ivi si spegne, l’anno successivo.