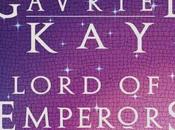Di LUIGI RAMENGHI *
Di LUIGI RAMENGHI *
La circolare periferica ogni tanto salta un giro, come la vita degli utenti. In queste occasioni l’attesa, imprevista ma non imprevedibile lungo una linea così irregolare, dura circa venti minuti, che, sommati ai tre o quattro già persi da chi ha raggiunto la fermata in anticipo, equivalgono a un tempo sufficiente per riposare le gambe prima dell’esercizio a bordo e svegliare le confidenze dopo l’uscita di casa.
Magari succede quando pioviggina e l’autobus si aspetta meglio a gruppetti sotto il portico, mentre qualche solitario o assonnato ciondola davanti ai negozi che stanno aprendo le saracinesche. Tra passeggeri della circolare ci si conosce, almeno di vista. E se le altre linee in transito possono offrire corse superflue, per esempio la pensionata appena salita sullo snodato diretto in centro per regalare ai nipotini le delizie reperibili esclusivamente nella drogheria del mercato vecchio, la circolare periferica invece si prende per necessità: studenti, impiegati, barboni, ognuno ha la sua fascia oraria, in cui qualcuno o qualcosa l’aspetta, alla fine del viaggio, attraversata la città, e un rapido censimento delle facce intorno alla palina strappa alle mani dei ritardatari un applauso se il mezzo anche oggi non è puntuale o uno schiaffo alla palina in caso contrario. Se poi la circolare salta il giro, nessuno si stupisce ma tutti si sconfortano, perché rinviare l’inizio del proprio dovere significa posporre il piacere della sua fine. Oggi si soffre mezzora di più, brontolano le labbra infreddolite, e, forse per rimediare, schiudono frasi inconsuete, che si muovono nella conversazione a tentoni, come appena alzate da letto. Alle confidenze si addice la mattina: la mattina ha qualcosa d’irreale, conserva il senso d’irresponsabilità dei sogni e nella sua penombra dà riparo alle verità più timide, che mai affronterebbero la luce meridiana.
Sotto il portico due impiegate della Regione parlano dei figli, scambiando molte parole, gesti e sguardi d’intesa. Poco lontano tre liceali dialogano nonostante indossino le auricolari degli I-pod accesi. La barbona che scende in via Mondo aspetta di trovarsi a bordo per attaccare con le richieste.
«Ciao care. Arriva o no ‘sto bus?» Le due impiegate sono state raggiunte da un terza, finora distratta dalle vetrine. «A proposito, è un po’ che non vedo quella ragazza alta che lavora ai tributi.»
«Ma chi, la Raffaella? Sarà un mese che non prende più la circolare. Va in ufficio in macchina, scorrazzata dal compagno.»
«Beata lei…»
«Mica tanto, gira con le stampelle. Si è giocata un’anca.»
«Ma cosa dici? Poveretta! Incidente?»
Finalmente la circolare arriva, fra sbuffi di aria compressa e sospiri di sollievo. Le portiere si spalancano, le braccia fanno leva sui sostegni, le terga si adagiano sui sedili, le gambe avviano la ginnastica. Nonostante il traffico da maltempo, l’autista pigia l’acceleratore, obbligando piedi e bacini a saggiare la loro prontezza. Oppure oggi fa bello e l’autista non ha fretta, tuttavia i passeggeri temono la frenata d’emergenza, e il rischio di perdere l’equilibrio viaggia con quello di perdere il filo del discorso, soprattutto se quello cominciato a terra era un discorso delicato. «Sapete, da domani non prendo più il bus. Colpa di questa gamba…»
Della sua improvvisa invalidità Raffaella Rotundo aveva accennato una mattina che l’autobus era troppo pieno per parlarne. Non che fosse chiaro il perché del suo ritegno. Ci si vergogna di un’artrosi all’anca? Va detto che questo male colpisce le donne dopo i cinquanta, mentre Raffaella ne aveva trentatré, ma comunque la risposta è no. In seguito si seppe che non di artrosi si trattava bensì di necrosi, patologia che nei giovani ha origine sconosciuta, per usare la terminologia dell’ortopedico, e allora tutti a chiedersi quali cure prevedesse la letteratura medica e se la parola fosse da pronunciare sdrucciola o piana.
Un giorno il tuo sangue smette, chissà perché, di affluire alla testa del femore, qualche giorno dopo ti congedi dai compagni di autobus per imboccare la strada del centro iperbarico, dove lo specialista ti ha indirizzato nel tentativo di scongiurare la chirurgia. Potremmo riassumere così, alludendo all’analogia tra scherzi della circolare e della circolazione. Si racconta per capire, del resto, dicono, e io questo sto facendo, ma non sono convinto. Poi io non amo parlare sull’autobus, preferisco leggere, se resto in piedi, o sonnecchiare, se trovo posto a sedere, oppure tendo a studiare gli intrusi. C’è sempre un intruso tra gli abitanti della circolare: il vecchietto che scende al poliambulatorio, la standista diretta a una fiera, il rumeno con i suoi giri, perfino una delegazione a un meeting. Un’intera tratta, anni fa, stetti a spiare, fingendomi assopito, una madre e la sua bambina. Dio, che belle. Erano identiche: la figura slanciata, i capelli fulvi a nuvola, la carnagione bianca, gli occhi grandi; non si lasciavano la mano; si parlarono pochissimo, scesero al sottopasso della suburbana. Un intruso meno gradevole presto sarebbe finito nell’anca di Raffaella, seppi mesi dopo, dato che la terapia iperbarica non aveva funzionato. «È anche costata parecchio, il sistema sanitario ne finanzia solo una parte…»
Ogni giorno per dieci settimane Raffaella si era blindata in camera iperbarica, alla pressione di venti metri sotto il livello del mare, che per i timpani non è un toccasana, e aveva inalato ossigeno puro, con il rischio di morire arsa viva, affinché quel sangue arricchito, spinto in fondo ai tessuti, rianimasse l’osso. E tutto per niente. Occorreva la protesi. Si sarebbe vergognata anche di questo?
Una mattina l’argomento venne sezionato. Se ne parlò per tutti i dieci minuti del tragitto che va da via Mondo alla sede della Regione. Lo ricordo perché si cominciò subito dopo la discesa, accompagnata da saluto corale, della barbona che sulla circolare chiede gli spicci per il cappuccino. Ricordo la chiacchierata anche perché ne presi parte, e attivamente, dato che, come molti, ho un parente con anca artificiale. Non so quantificare i passeggeri coinvolti nella discussione, saremo stati quattro o cinque. Scartata la spiegazione diciamo geografica, legata alla riservatezza tipica, pare, dell’entroterra abruzzese di dove Raffaella era originaria, si optò per la spiegazione familiare. Una delle colleghe negli ultimi tempi incontrava spesso Raffaella davanti alla macchinetta del caffè, e dai recenti scambi aveva tratto conclusioni. Quelle chiacchiere infatti le avevano riportato alla memoria uno dei maldestri tentativi con cui Raffaella, dopo l’assunzione in Regione, si apriva alle colleghe. In effetti aveva un carattere riservato e un’indole poco loquace, ma quell’accenno alla morte della madre, abbozzato alla fermata dell’autobus anni prima e ripreso alla macchinetta qualche settimana fa, dava da pensare. La collega di Raffaella, presumo quella che con lei era riuscita a stringere i rapporti dico non fino all’amicizia ma a un’intermittente confidenza, raccontava che la madre le era morta d’infezione all’ospedale, dopo un intervento chirurgico al cuore, senza che la figlia né gli altri famigliari avessero chiesto risarcimento. La piega burocratica presa dal resoconto m’infastidì, quindi abbandonai la conversazione e ora posso aggiungere solo frammenti di discorso, per esempio che l’operazione era stata fatta a Pescara e la setticemia era stata provocata dal solito stafilococco; anzi sono tentato di parlare d’altro, perché la dipendente regionale aveva la voce stridula e questa storia che le storie vanno raccontate a regola d’arte non mi convince, come non convincono i controllori quando farfugliano ipotesi sulle cause dei continui disservizi della linea per usufruire della quale hanno appena verificato che tu abbia titolo. Insomma perché dovrei scrivere com’è andata a finire Raffaella Rotundo, con la sua anca e la sua mamma morte? Non potrei passare ad altro?
«Zia, come sta la tua anca?»
«Bene, grazie, come sempre. Perché me lo chiedi?»
Non so di che cosa si occupasse quella dipendente regionale, ma se facessi il suo lavoro la voce stridula uscirebbe anche a me. Calcolo delle aliquote, ricalcolo dei canoni, formazione dei ruoli, ratei di pagamento, rimborso d’indebiti, aggiornamento dei modelli, rapporto con gli esattori, ore, settimane, anni passati al computer a far tornare i conti. Io sono odontotecnico, la vicenda di Raffaella deve avermi colpito per le implicazioni con la mia professione. Le coxoprotesi furono inventate da qualche pazzo a fine Ottocento e si facevano con l’avorio, le protesi dentarie risalgono a duemila anni fa ed erano d’oro. Comunque è un lavoro di pazienza, il mio studio apre alle otto e i miei turni variano, senza contare che non vengo pagato a ore: se ho un byte o un intarsio da finire, sono capace di trattenermi fino a mezzanotte, dunque gioisco quando rincaso per cena.
Sulla circolare periferica di sera i compagni di viaggio non sono quelli della mattina. Sarà che la sera invita all’anarchia e si danno fasce orarie anche per il ritorno a casa; poi di sera si ha meno voglia di parlare e più di guardare fuori, soprattutto se fa buio e si può solo immaginare. Per tacere della stanchezza, nemica delle chiacchiere. Se la mattina raccoglie le confidenze, la sera deve corteggiarle senza tregua, e gli utenti alle volte si rattristano. Succede per lo più alla curva del sottopasso, da ogni tramviere ritenuta occasione di svago o avventura. Quando il mezzo precipita per la parabolica e ne raggiunge il fuoco geometrico, inclinato dalla velocità al punto che i passeggeri si reggono con le braccia ai sostegni metallici e delle gambe quasi non sanno che cosa fare, in quel punto dello spazio-tempo serale gli abitanti della circolare, a differenza che di mattina, si sentono soli. Di mattina la piega in curva li fa sentire vivi, proiettati verso la fatica di trascorrere la giornata; di sera capiscono che li accomuna a mala pena la presenza a bordo, voluta dal caso e ignorata dal mondo. Sì, è vero, sono stanchi e stanno rischiando di morire, ma non tutti hanno perso le forze e all’incidente alcuni sopravvivrebbero. Assomigliano alle cellule dentro un osso: un agglomerato di vite solo apparentemente impegnate a funzionare insieme.
Quando la circolare vola giù per la curva del sottopasso e le gambe dei passeggeri diventano inutili, in quel punto dello spazio-tempo serale, fatto di denti stretti e luce fioca nel breve tunnel, a Raffaella Rotundo scappa un sorrisetto. Appartata su un sedile poco illuminato, per esempio quello tra il posto di guida e la vidimatrice automatica, abbraccia la borsa e guarda le stampelle appoggiate davanti a lei. La sede della Regione coincide con il capolinea, il che le permette di salire sul mezzo ancora vuoto. Poco fa ha telefonato al compagno: «Non venirmi a prendere, torno col bus.» Si concede questo vizio, di quando in quando, se fa tardi in ufficio. Così scongiura incontri con facce note, perché gli utenti serali della circolare si conoscono poco. Guarda intorno. I liceali sono rientrati a casa da un pezzo, la barbona adesso chissà dov’è, di colleghe chiacchierone non se ne vedono. Nell’abitacolo ristagna l’odore soffocante accumulatosi dall’alba corsa dopo corsa, però oggi è una buona giornata, la gamba non le fa male, non la sente mancare sotto il peso del corpo, il suo corpo alto e robusto, vestito degli stivali comodi, del solito spolverino e del vuoto che si è fatta intorno negli ultimi mesi, denso, opaco, quasi sprizzato dai muscoli contratti. In quel cerchio d’ombra girano le frasi che non riesce a dire, l’ortopedico nel suo studio con la libreria piena di volumi d’arte e le riproduzioni di schizzi di Lorenzo Lotto, l’altro ortopedico cui si è rivolta per un secondo parere, alto, occhi chiari, voleva sperimentare su di lei un trapianto di osso, e perfino il cardiologo giovanissimo dell’ospedale a Pescara, che le rimproverò di essere spaventata. Il sedile è scomodo e le torce la colonna vertebrale, peggio della sedia in ufficio, ma l’autobus fila e nessuno le si avvicina e lei non deve chiedere niente a nessuno e nessuno chiede niente a lei.
Oppure no, le cose non stanno esattamente così. Alla partenza si è accorta che mentre saliva non era sola. L’autista le ha domandato se le serviva aiuto con le stampelle e lei non ha risposto, distratta da quel tipo che passava per l’altro ingresso. Lo conosce. Non sempre si riescono a evitare le facce della mattina, nemmeno viaggiando mentre gli altri cenano. Sul marciapiede, l’attimo prima di porre suola e stampella sul gradino, è stata vista. Lui l’ha vista. E ha visto che lei l’ha visto. Perché si trova qui, adesso? Dovere? Piacere? Ha l’aria stanca. Avrà lavorato finora, poveraccio. Non si avvicinerà. È uno che si fa gli affari suoi. Resterà in fondo alla vettura a sonnecchiare o a sfogliare l’immancabile libro… E se invece si avvicina? Se attraversa il corridoio a posta per lei? Sta a vedere che è uno di quelli dotati di parola solo dopo il calar del sole. E se chiede? E se s’interessa? No, no, non sembra tipo… Ma poi, se anche fosse? Tutti hanno paura di qualcosa. Di venire bocciati, di non trovare gli spicci, di perdere i denti. Bene, qualcuno ha paura della chirurgia. E ha paura di spiegare perché. Ha paura di udire la propria voce mentre si rompe. Gli altri dopo capiscono che non sei a posto, che a trentatré anni non sei capace di accettare gli scherzi del destino. Però lui è uno taciturno: se fa domande, ascolta le risposte. Non interrompe, non commenta: lascia parlare. Lo capisce che è sera: tra un po’ staremo tutti sognando. Se va così, allora può andare. Ogni tanto una ha bisogno di sfogarsi.
______________________
* Questo racconto è già stato pubblicato su Squadernauti, ma l’autore l’aveva mandato contemporaneamente anche a Critica Impura. Il problema è che Sonia Caporossi si accorge sempre delle mail che contengono cose belle in ritardo.