Lu pueta canta pi tutti / The poet sings for all
============
di Marco Scalabrino. La manu alluongu e cuogliu spinziratu / lu fruttu di li rami chi su’ all’ariu, / azziccu li dienti e hiuhiu / lu sucu di lu truncu centenariu.
Parrebbe il significato di questa quartina assolutamente chiaro, del tutto scontato; tanto più che lo stesso autore ce ne fornisce, di suo pugno, la letterale traduzione italiana: La mano allungo e raccolgo spensierato / il frutto dei rami che sono in aria, / conficco i denti e risucchio / la linfa del tronco centenario.
La figurazione che ne se ricava è quella, d’emblée catapultati in un campo in un fresco mattino di tarda primavera o inizio d’estate, di staccare da una pianta secolare uno dei suoi frutti prelibati (una nespola, magari, un’albicocca, una pesca) e di mangiarlo a morsi golosamente.
Troppo liscio! Troppo facile! La sensazione è che qualcosa di basilare ci sfugga, che a questo idilliaco quadro difetti l’acconcia cornice.
“La poesia – assevera Charles de Saint-Evremond – richiede un genio che non va troppo d’accordo col buon senso: ora è il linguaggio degli dei, ora quello dei pazzi, raramente quello di un onest’uomo”. Questa osservazione suffraga le nostre perplessità, ci esorta a diffidare dalla nostra sommaria visione, ci aiuta viepiù a comprendere perché la poesia esiga che non si ci arresti a un primo livello, quello di superficie, a una fugace esteriore lettura, a una decifrazione d’orecchio (nel nostro caso l’apparente placido ambiente bucolico). Essa, difatti, consta di più livelli di lettura e di successivi ordini di decifrazione e a questi il lettore avvertito deve mirare, al fine di intercettarne (oltre, ovviamente, ai fausti esiti lirici e formali) lo spessore concettuale, l’accezione sostanziale di quel sistema specifico di termini che interagiscono fra loro e che unicamente nella loro interezza definiscono ogni singolo testo, il significato reale, ben oltre alla apparenza contingente, di quel cosmos epèon, di quel perfetto, cioè, universo di parole. Con tale operato, portando peraltro a compimento il lettore, a perfezione, il processo del poiein, della creazione, posto in essere dal poeta.
Allorché ciò avviene, allorché le parole vengono recepite e composte nella loro interdipendente relazione, allorché riusciamo a svellerne il presupposto di insieme, a decrittarne l’unitaria suggestione suscitata, ecco ci si apriranno ben altri scenari.
Cos’è il truncu? perché giusto centenariu? di quale fruttu e di che sucu si disputa? riteniamo, pertanto, opportuno interrogarci. I riscontri, sempre in versi, non tardano:
fa cuntu chi manii / la gran lingua di li greci / e lassatimi diri / chiddru chi un si po’ diri,
ovverosia, nuovamente avvalendoci della versione in italiano: fai conto che maneggi / la grande lingua dei greci / e lasciatemi dire / quello che non si può dire.
Racalmuto (AG) 1958, docente nella scuola pubblica, estimatore della tradizione e della cultura siciliane, gestore del blog http://archivioepensamenti.blogspot.it, Piero Carbone è poeta. E un poeta che sa fare, chi po’ fari, se non sventolare banneri di palori?
Parole però che, nell’alchimia che egli realizza, acquistano significati che eccedono la loro semplice lettera; parole quotidiane che nella loro inusitata cifra disegnano profili squisitamente singolari, assurgono a raffinato strumento espressivo mediante il quale esplicitare la propria Weltanschauung. “Nel poeta – ci conforta Franco Fortini – quelle parole che ciascuno poteva comprendere non sembrano più essere le solite; qualcosa le ha trasformate e fatte come nuove. Non vogliono più dire soltanto una cosa; dicono una cosa e insieme ne dicono un’altra e un’altra ancora. C’è dentro una musica nuova e un modo loro di presentarsi, di accostarsi e di echeggiare che non si richiede più se quel che dicono sia vero o falso e a che serva, anche se pur si sente dentro, come riunita e serrata, tanta sapienza, esperienza, amore.”
Ecco perciò, ricollegandoci al passo precedente, che ogni cosa si palesa in una sorprendente dimensione, l’unica, in verità, nella quale il quadro sopra descritto nelle due complementari parti va situato: il poeta, ovvero, che agguanta dalla pianta fertile e generosa del suo linguaggio (le cui radici millenarie affondano nella classicità) le parole più succose, sceglie una ad una quelle con le quali strutturare compiutamente sul foglio il suo mondo e, finanche, provare a vagheggiare quanto finora è stato indicibile.
E qual è il linguaggio di Piero Carbone è lampante, è presto detto!
“Non è naso, è dialetto” afferma Luisa Adorno in L’ultima provincia, il suo romanzo del 1963; la lingua di la minna rincalza Vito Tartaro; l’antra lingua rilancia Piero Carbone e chiama a dargli manforte i vibranti versi di Vincenzo De Simone, dal sonetto dal titolo Lu me dialettu: “Lu sai pirchì iu l’amu lu dialettu, / la matri lingua di lu me paisi? / Pirchì mi la nzignaru senza spisi / e senza sforzu di lu me ntillettu; // pirchì nun ci ni levu e ‘un ci ni mettu, / ca lu so meli, cu’ fu, ci lu misi; / pirchì è onesta, tennira e curtisi / e quannu canta attenta a lu me pettu. // L’amu pirchì ci sentu intra la vuci / di tutti li me’ nanni e li nannavi / di tutti li me’ vivi e li me’ morti; // l’amu pirchì mi fa gridari forti: / biddizzi chiù di tia nun c’è cu’ n’avi, / terra fistanti mia, cori me duci!”
“Mi accorgo di non avere mai rinnegato la lingua in cui ho espresso i primi vagiti; anzi, l’ho coltivata di nascosto a me stesso.” Piero Carbone, da lunga pezza, ama, studia, pratica il dialetto, ammira chi, come lui, ha seguito un percorso serio di avvicinamento ad esso e ne ha condiviso la scelta di dedizione. E in quanto tale, come Gnazziu lu cummircianti (Ignazio Buttitta, ovviamente), egli non intende essere emulo di nessun altro poeta, non gradisce calcare le impronte lasciate da altro poeta (già Callimaco, duemila anni fa, ci sollecitava a sfuggire la “strata cumuni, ca la fudda / scarpisa d’ogni parti”, ci incitava a inoltrarci per “trazzeri novi / puru si sunnu stritti”), vuole essere fieramente se stesso e con determinazione, dunque, egli va ppi la so strata.
Ben conscio che il dialetto siciliano nel rapporto ATLAS del 2009 sia stato collocato fra le lingue vulnerabili (rimarcandone il peggioramento rispetto alla precedente posizione rilevata nel Libro Rosso dell’UNESCO del 1999, che lo aveva incluso fra le lingue non in pericolo di estinzione con una trasmissione sicura alle nuove generazioni), che esso è cunnannatu / a ballari tarantelli (sia decaduto, cioè, a un “uso folcloristico e marginalizzato”), che ormai lo mastichìanu quattru gatti, Piero Carbone si duole di disporre di limitati mezzi da spendere a sua salvaguardia: vaju pi cantari e jettu vuci. Al contempo, è pure risolutamente edotto della nobiltà, della dovizia, della forza del proprio strumento, tramite il quale, basta che voglia, il poeta siciliano può levarsi negli spazi infiniti dell’estro e del sogno, è in grado di confrontarsi a testa alta con qualsivoglia altro codice di ogni latitudine e longitudine del pianeta: vola n cielu, / spunna n terra / e si serbi / vacci n guerra, giacché, concordiamo con Salvatore Camilleri, il siciliano può esprimere qualsiasi concetto: “la storia, la filosofia, la sociologia, tutte le scienze, non in quanto tali, ma come patrimonio culturale che chi scrive brucia nell’atto della creazione”.
In tale ottica, la dichiarazione di appartenenza alla cultura, alla lingua, alla poesia della Sicilia che in tutta trasparenza emerge dalle sue pagine (e nel novero ricomprendiamo le molteplici precedenti pubblicazioni nonché gli acuti interventi divulgati sul blog) è senza riserve, come pure sono autentiche la sua modestia e la sua genuina devozione nei riguardi dei Maestri (quelli che abbiamo incontrato e quegli altri che incontreremo) e la piena consapevolezza della sua vocazione, della sua elezione, del suo ruolo di poeta.
Novanta pagine, per oltre sessanta brevi testi, a metrica libera, con traduzione a fronte nel medesimo foglio, riferibili a disparate stagioni (fra il 1975 e il 2010), in due sezioni: Jettu vuci / I scream e Comu fu / As it was, il cui sottile spartiacque è segnato da due smaglianti versi di Pedro Salinas: El sol nace para todos / y en nadie termina (Il sole nasce per tutti e in nessuno ha fine).
Spartiacque che, per grandi linee, disgiunge testi riconducibili alla parola, alla poesia, a svariati aspetti della sicilianità, la prima; agli affetti, alla memoria, alle meditazioni esistenziali, la seconda. Più estesa la prima, quaranta elaborati, esordisce con Vaju pi cantari / I try to sing e chiude con Canta ppi tutti / A poet sings for all; ventitré elaborati, la seconda muove da Nni guarda la luna / The moon is looking at me per risolversi con Parlari di chistu e di chiddru / We walk on this and that del conclusivo Comu fu / As it was.
Sin dal testo di avvio (già anzi dalla “copertina” della prima sezione, con Vicente Aleixandre e il suo verso: Suena la voz que los lleva, dal componimento El poeta canta por todos – titolo in traduzione mutuato per l’odierno lavoro, nel quale il pronome “tutti” appare orientato ad affermare e a trasmettere il clima di totale coinvolgimento di una e in una comunità e della unanime condivisione di un patrimonio di identità, di cultura, di poesia siciliane), Piero Carbone non indugia a proclamare esplicitamente nomi e cognomi dei suoi Maestri, i suoi Maestri sulla carta, quelli conosciuti e riconosciuti sui libri in anni di assidua frequentazione, i Maestri che egli si è liberamente scelto per affinità di spirito e che rispondono ai nomi di: Ignazio Buttitta, Giovanni Meli, Giuseppe Pedalino Di Rosa, Pablo Neruda, Paul Verlaine, Miguel De Unamuno, Jacques Prévert, Arthur Rimbaud, Miguel Hernandez, Rafael Alberti, Luis Cernuda, Juan Ramón Jiménez, Dámaso Alonso, Gustavo Adolfo Béquer, Pedro Salinas, Rubén Darío, José Garcia Nieto, Jorge Luis Borges, confessando la sua estrazione poetica basilarmente affine al simbolismo e al modernismo e la sua implicita predilezione per la poesia, i poeti, la lingua degli Spagnoli: la Spagna / è comu la Sicilia.
1. La puisia. Vinni, dapprima, pura, / vistuta di nnuccenza; / e ju l’amai comu un picciriddu. / Doppu si jìu vistennu / non sacciu di cchi robbi; / e a sdignarla ju jìi senza sapirlu. / Fu a fini rigina / sfazzusa di trisori. / Ma cchi suduri friddu e nniffirenza! / Poi cuminciò a livarisi ddi robbi. / E ju la taliava risulenti. / Arristò cu la tunica / di l’antica nnuccenza / e novamenti mi ni nnamurai. / Si livò la tunica / e nfini tutta nuda m’apparìu. / Focu di la me vita, puisia, / nuda e mia pi sempri.
2. L’anima avevi. L’anima avevi / accussì chiara e aperta, / ma ju non potti mai / tràsiri in idda. / Circai n’accurzatura, / li trazzeri, li passi di muntagna / stritti e difficili. / Sulu pi strati larghi si jungeva / fina a l’anima to. / Mi priparai na scala / àuta, pirchì pinzava a mura àuti / chi avevi a guardiani / di l’anima. / Ma la to anima / era senza difisa, / senza mura e sticcati. / Circai la porta stritta / pi putìrici tràsiri, / ma non aveva porta / l’anima to, / tantu era libira. / Unni principiava? / E unn’è ca fineva? / Ristai sempri davanti / a n’immagini priva di cuntorni, / la sogghia / di la to anima.
Sono le traduzioni in dialetto siciliano, a cura di Salvatore Camilleri, rispettivamente dei testi di Juan Ramón Jiménez e di Pedro Salinas. Esse ci danno l’idea dei proficui, pregressi flussi fra la poesia europea (spagnola e francese in ispecie) e quella della nuova poesia siciliana e la riprova di un rilievo avanzato dai letterati per il quale la poesia siciliana moderna, quella del secondo Novecento, scaturì di colpo “al di fuori dalla logica progressione delle cose, sulle esperienze altrui”, italiana, francese, europea, e non sull’esperienza siciliana: “I maestri – testimonia Paolo Messina nel saggio La Nuova Scuola Poetica Siciliana – preferimmo andarceli a cercare altrove e ricordo che si parlava molto della poesia francese, da Baudelaire a Valéry, e delle avanguardie europee”.
L’introduzione del libro è a firma di Gaetano Cipolla. Professore emerito di Lingua e Letteratura Italiana presso varie università americane, la St. John’s University di New York per ultima, nato in Sicilia ed emigrato negli Stati Uniti nel 1955, Cipolla è direttore di Arba Sicula, rivista bilingue che ospita articoli in inglese e siciliano. Traduttore di numerosi poeti siciliani, di recente ha pubblicato: Learn Sicilian / Mparamu lu sicilianu, Edizioni LEGAS 2013, e Siciliana – Studies on the Sicilian Ethos and Literature, Edizioni LEGAS 2014.
“La collana Pueti d’Arba Sicula – sostiene egli – nasce dal desiderio di presentare al mondo anglofono alcuni dei migliori poeti che la Sicilia ha prodotto attraverso i secoli. Abbiamo pubblicato finora tredici volumi in formato bilingue (siciliano/inglese). Sei dedicati a poeti del passato: Antonio Veneziano, Giovanni Meli, Domenico Tempio e Nino Martoglio; gli altri sette, in un’ampia varietà di stili e tematiche, a poeti contemporanei: Vincenzo Ancona, Nino Provenzano, Senzio Mazza, Salvatore Di Marco, Nino De Vita e, appunto, Piero Carbone. Carbone, con ironia sottile e con brevi tocchi di penna, si lamenta dello stato nel quale il siciliano è ridotto, si scaglia contro i poeti che non respirano l’aria di oggi per ricordare il passato, declama la sua appartenenza a quel mondo e l’orgoglio di esserci, nonché i desideri, le contraddizioni e le falsità della vita moderna.”
Premesso che la trasposizione italiana dei testi (in calce a ciascuna pagina) è dello stesso Carbone, è tempo adesso di esporre talune succinte notazioni circa la sintesi individuale che del linguaggio Piero Carbone ha realizzato (la parole – per dirla con Ferdinand De Saussure – rispetto alla langue, che è invece il sistema linguistico indistinto nella disponibilità del poeta), circa gli esiti ai quali è pervenuto, circa le peculiarità del dialetto siciliano.
A cominciare da una pertinente, preliminare glossa che egli ha tenuto a inserire: “Il sistema ortografico adoperato è volutamente di tipo morfematico e perciò non fonetico. Ciò significa che ciascuna parola è conservata nella sua unità e individualità di morfema, indipendentemente dai processi fonologici che subisce nel continuum linguistico. Per tale sistema ortografico mi sono avvalso dei consigli dell’amico Professore Salvatore C. Trovato.”
Vagliato che Salvatore C. Trovato, oltre a essere ordinario di Linguistica generale presso l’Università di Catania, è stato, assieme con Giorgio Piccitto e Giovanni Tropea, uno degli autorevolissimi curatori del monumentale Vocabolario Siciliano, in cinque tomi, intendiamo rispettare incondizionatamente le responsabili scelte di Piero Carbone.
Verlaine passa pi foddri, / Rimbaud chi l’accumpagna / miegliu du foddri genii / ca tanta genti paglia (Verlaine è ritenuto folle, / Rimbaud gli è compagno / meglio due folli geni / che tanta gente paglia).
Quasi un aforisma, se non fosse per la lucida provocazione che ne prorompe, questo testo, dal titolo Genti paglia, la dice lunga e chiara circa la sacra considerazione che del ruolo della poesia e dei poeti (poeti che, più che conoscenti e amici, egli reputa fratelli: Ti sientu / comu frati di palora), nella storia, nella cultura, nella società, ha Piero Carbone, il quale, nel reiterare la sua schietta prossimità all’una e agli altri, combina felicemente stringatezza metrica e profondità concettuale e destina alla nostra valutazione diverse prerogative del siciliano.
Paglia, scrive Carbone; e ancora: sbagliu, cunsiglieri, cunigliu, tagliu, travagli, cummigliati, ricorrendo, in guisa girgentana, al gruppo “gl” e non al gruppo “ggh” come nella formulazione nell’isola più diffusa. Questo, il “ggh”, si impose dalla seconda metà del 1600, allorquando Giuseppe Galeano (alias Pier Giuseppe Sanclemente) pubblicò i cinque volumi de Le Muse Siciliane (ristampate nel 1996, a cura di Sebastiano Grasso, da Giuseppe Maimone Editore in Catania) nei quali esso comparve per la prima volta.
Parimenti alla agrigentina santari anziché sautari o satari e antri e non autri o atri come nelle voci più accettate.
In una striscia della medesima area geografica (area nella quale: Na vota si muriva, nichi e granni, / nni li pirreri di surfaru e sali) insiste il dittongo metafonico. Tipico delle parlate della Sicilia centro-orientale, esso è dovuto, secondo Giorgio Piccitto, al sostrato siculo insito nel dialetto siciliano. È bensì assente nel dialetto siciliano occidentale (ossia delle parlate del trapanese, dell’agrigentino centro occidentale e di parte del palermitano, zone di influenza del sostrato sicano). Piero Carbone ne fa largo uso: sintimientu, arriè, juochi; juornu, sientu, cuogliu, dienti, vientu, duoppu, muorti, parmienti, spagnuolu, nievuli, tuorti, addifienni, miegliu, furmientu, vuolu, viersi, viennu, castieddri, tiempu piersu, fierru e fuocu, duorminu, suonnu, cacuocciula, buonu, rasuolu, attuornu, piezzu, cientu, uogliu, uocchji apierti, tracuoddru, uortu, aspiettu, cuomu, scalunieddru, fuoru, sciddricaluoru, ciercu, liettu.
Aspittavu lu trenu di li setti / e un vinni. / Aspittavu chiddru di l’ottu / e un vinni. // Aspittavu tutta la jurnata / e un vinni. / Chi avera a ffari? / Mi nni jivu a l’appedi.
Questo conciso componimento, che riecheggia manifestamente la pièce teatrale Aspettando Godot di Samuel Beckett, ci offre il destro per parecchie riflessioni.
La j, dei termini jurnata e appresso jorna, è un segno che ha sovente suscitato l’attenzione degli studiosi. Salvatore Giarrizzo, nel Dizionario etimologico siciliano del 1989, definisce la j semivocale latina. Se viceversa, come da altri sostenuto, fosse una vocale la j dovrebbe ubbidire alla regola di tutte le vocali, a quella cioè di fondersi col suono della vocale dell’articolo che lo precede, dando luogo all’apostrofo. Così come noi scriviamo l’amuri (lu amuri) dovremmo pure scrivere l’jornu, l’jiditu … cosa che nessuno si sogna di fare, giusto perché, non essendo la j una vocale, non vi è elisione e quindi non è possibile l’apostrofo, il quale si verifica all’incontro di due vocali e mai di una vocale e di una consonante.
Nel siciliano è norma che la “e” e la “o” toniche mutino in “i” e “u” tutte le volte che perdono l’accento tonico, sia che si tratti di verbi, sostantivi, aggettivi o avverbi. In Carbone: tri jorna – tutta la jurnata; si mori – si muriva; cerca l’anima – vaju circannu, eccetera.
Culura, ruvetta, cafisa, corna, picuna, scaluna, chjova, pinzera. Di regola il plurale dei nomi, sia maschili che femminili, termina in “i”; ad esempio: quaderni, casi, pueti. Un certo numero di nomi maschili terminanti al singolare in “u” – certifica Salvatore Camilleri – fanno il plurale in “a” alla latina; sono nomi che di solito si presentano in coppia o al plurale: jita, vrazza, ossa, vudedda, gigghia, linzola, dinocchia, cucchiara. Ugualmente cospicui i plurali in “a” dei nomi maschili terminanti al singolare in “aru” (latino arius) significanti, in gran misura, mestieri e professioni. Se ne ripetono i più comuni: ciurara, furnara, jardinara, libbrara, marinara, nutara, putiara, ruluggiara, scarpara, tabbaccara, vitrara.
Rimarcato l’impiego delle preposizioni semplici più gli articoli: di li setti, a l’appedi, nni lu cielu, la dovizia lessicale del siciliano trova limpido riscontro nella corrente opera di Piero Carbone.
Gli studiosi hanno acclarato da tempo (ma crediamo non sia superfluo ribadire) che il siciliano non è una corruzione né una forma inferiore dell’italiano. Esso ha abbeverato le proprie radici nel greco e nel latino e, in epoche successive, ha attinto vitale linfa dall’arabo e dalle lingue dei vari dominatori che nell’isola si sono succeduti: siemmu na pasta di populi ammiscati, registra Carbone. È un idioma di nobiltà, dignità e valore irrefutabili, tanto che il Devoto attestò che “la Sicilia a partire dal XII secolo, nel periodo delle due grandi monarchie, la normanna e la sveva, ha elaborato la prima lingua letteraria italiana” e già Dante, nel De Vulgari Eloquentia, aveva asserito che “tutto ciò che gli italiani poeticamente compongono si chiama siciliano”. Per inciso, l’Assemblea Regionale Siciliana, nel 2011, ha approvato una legge che prevede lo studio del dialetto nella Scuola.
E pertanto una rapida rassegna di termini: picchjipacchju (intingolo), tumazzu (formaggio), filama (nomea), straminiatu (disseminato), purrazzi (asfodeli), zinzuli (giuggiole), fumieri (letame), sparacogna (asparago), catabonta (capriola), mi spagnu (temo), cafisa (brocche), scuttàriti (guadagnarti), sciarra (bisticcio), astracu (terrazzo), ticci (civette), nzira (fiaschi), jittena (sedile).
Lenzi lenzi, d’unni mi giru giru, adàçiu, adàçiu. Peculiarità ulteriore del dialetto siciliano è il raddoppiamento e/o la ripetizione dei termini. “Il raddoppiamento o la ripetizione di un avverbio (ora ora, rantu rantu) o di un aggettivo (nudu nudu, sulu sulu) – dichiara Luigi Sorrento in Nuove Note di Sintassi Siciliana del 1920 – comporta di fatto due tipi di superlativo: ora ora è più forte di ora e significa nel momento, nell’istante in cui si parla, nudu nudu è tutto nudo, assolutamente nudo. I casi di ripetizione di sostantivo (casi casi, strati strati) e di verbo (cui veni veni, unni vaju vaju) sono speciali del siciliano. Strati strati indica un’idea generale d’estensione nello spazio, un’idea di movimento in un luogo indeterminato, non precisato, tanto che non può questa espressione essere seguita da una specificazione, come strati strati di Palermo. L’idea di “estensione” viene espressa dalla ripetizione del sostantivo, così originando un caso particolare di complemento di luogo mediante il raddoppiamento di una parola. La ripetizione del verbo si ha con la pura e semplice forma del pronome relativo seguita dal verbo raddoppiato: cui veni veni intende chiunque venga, tutti quelli che vengono: il raddoppiamento del verbo, quindi, rafforza un’idea nel senso che la estende dal meno al più, la ingrandisce al massimo grado, anzi indefinitamente”.
Le traduzioni in inglese sono di Gaetano Cipolla. Benché assai rispettose del testo originario, esse non sono tuttavia carenti di soluzioni di pregio e, alla bisogna, di confacenti locuzioni idiomatiche; ne riportiamo degli stralci: mastichìanu quattru gatti: a few, count them on your fingers; Strummula strummulicchja e strummuluni: Spinning tops, little dolls and cards; Ccu la voli cotta / ccu la voli cruda: Some liked it hot, / some liked it cool; denti … nun è di latti: tooth … it’s not a baby tooth; Pueta, / terri terri, / sbinnuliasti / banneri di palori / p’addrizzari / lu munnu avariatu: Poet, / you have flown / banners of words / to staighten up / this crooked world / from one country to another; Ncapu li nievuli acchjanu e passiu: I climb up to the clouds and walk around; Arrizzulavu un furnu / a cuorpi di picuna, / lu pani mi l’accattu a la putia, / la testa l’aju sempri / a li fuazzi, / ddru furnu n menti / sempri è chi famìa: I destroyed an outdoor oven / with blows from a pick ax. / Now I buy bread at the bakery, / but my thoughts keep returning / to the focacce baked in there. / That outdoor oven in my head / is always burning hot; La notti / è di li vurpi e di li ticci … si lu suli veni / e iu nun cantu / o vurpi o tìccia / vuogliu addivintari: Night belongs / to foxes and to owls … if the sun rises / and I don’t sing, / either a fox or an owl / I want to become; Senza càrzari, carzaratu sugnu: Without a prison, I’m in chains.
Singolare, asserisce Cipolla, la somiglianza fra le due lingue: il siciliano, notoriamente una lingua romanza, e l’inglese condividono infatti un copioso patrimonio lessicale, giacché “circa la metà delle parole inglesi derivano dal latino”.
Alla pagina 32, Piero Carbone premette al suo testo Si nasci e si mori / People are born and die un passo (dal quale ha tratto evidente ispirazione) estrapolato dal volume della narratrice sambucese Licia Cardillo Di Prima Eufrosina, Dario Flaccovio Editore 2008. Protagonisti della vicenda (alla quale vi rimandiamo per l’ammirevole scrittura di Licia Cardillo e per la qualità della proposta che manco a dirlo annoda Sicilia e Spagna) sono Eufrosina Valdaura Siracusa, baronessa del Miserendino, “il volto spuma di zucchero, la pelle candida come cera di Venezia”, gli occhi verdi, i denti bianchi, 17 anni, e Marco Antonio Colonna, “sterminatore di Turchi, terror di barbareschi, eroe di Lepanto”, dal 1577 al 1584 viceré di Sicilia, 44 anni.
Sutta lu pignu di lu Zaccanieddru / tutti l’amici mi viennu a truvari. / Ci offru ficu, / ci offru piruna, / grapiemmu un libbru, / nni guarda la luna.
Zzaccanieddru (Zaccanello) è una contrada di Racalmuto, un luogo fisico, un preciso punto di coordinate geografiche: pino maestoso cullato dal vento, orticello irrigato di fiori e frutti, casolare, lustro di luna (la luna è compagna fra le più fedeli della poesia di Piero Carbone). Ma questa pur ineccepibile accezione risulta, a conti fatti, a dir poco stentata! La dimensione spirituale, invero, esorbita quella prettamente fisica: essa è tempio di affetti, oasi rigeneratrice, agorà culturale, nella quale si concreta e si rinnova la xenía, l’ospitalità ovvero, che i Siciliani dai Greci hanno ereditato. La “ξενία”, considerata un atto sacro, riassume il concetto dell’ospitalità e dei rapporti tra ospite ed ospitante nel mondo greco antico, della cui civiltà costituiva un aspetto di grande rilievo. Retta su un sistema di consuetudini e prescrizioni non scritte, essa era molto importante quando si pensava che gli dei potessero assumere sembianze umane: se il padrone di casa avesse trattato male un ospite, sotto le cui vesti si fosse celato un dio, avrebbe potuto incorrere nella collera divina. Troviamo nell’Odissea un esempio dell’ospitalità nell’Antica Grecia. Giunto stremato sull’isola dei Feaci, Ulisse venne lavato, vestito, invitato a un banchetto (senza che gli fossero poste domande su chi fosse o da dove provenisse) e ospitato nella reggia di Alcinoo, re di quella popolazione. Nella medesima Odissea rinveniamo, nondimeno, un secondo episodio e personaggio in totale antitesi: Polifemo. Polifemo – è risaputo – non fu esattamente benevolo con Ulisse, non lo ospitò allo stesso munifico modo. Essere ospitale, oggi, può voler dire “aprire con semplicità e con amore il proprio cuore e la propria casa agli altri soltanto per il piacere di farlo senza aspettarsi niente in cambio. Tale atteggiamento rigenera l’animo di chi compie e di chi riceve questo gesto”. D’altro canto, l’ospitalità è parimenti sacra per i credenti perché è un principio stabilito da Dio: “Chi accoglie voi, accoglie me. Chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato”.
Si è fatto, in più circostanze, riferimento agli esiti lirici e formali; eccone, allora, certuni relativi alla prova in argomento:
Comu un denti mi doli / stu paisi / ma cadiri nun pò / nun è di latti; Lu mari a cu lu vidi / è na balata; Mutu di seculi e sempri / chjacchjaria; Di notti nun si vidi e pienzu a Diu; Li corna di la luna su bannera; Ncapu li nievuli acchjanu e passiu. / Vuogliu truvari spiritu di munnu; Fumu c’acchjana sugnu nni lu cielu / ma truncu fuvu d’arbulu firrignu. / Tutti li cosi sunnu sutta un velu. / M’accupu nni stu munnu / e mi la svignu; Stanotti anzi, nni li matinati … ci ruppi a li pinzera li catini; M’accattavu lu suli. / Ogni matina / cci dicu d’affacciari / e iddru veni. Bella oltremodo quest’ultima immagine, come se – ve lo figurate! – il sole potesse essere agli ordini del poeta.
In dirittura d’arrivo, demandando ai lettori ogni altra utile impressione, con acceso random una masculiata di aggiuntive notazioni.
A mia mi piaci lu picchjipacchju. A mia mi consentito nel siciliano; Cu di Palermu ora va a Capaci. Il siciliano manca del segnacaso da; vengo da Palermo, per esempio, è reso con vegnu di Palermu, il segno del genitivo vale per l’ablativo; spinziratu, pinzera, pinzava. Da Salvatore Riolo una interessante deduzione: “Nei dialetti siciliani il gruppo consonantico ns si trasforma in nz, poiché la s nel dialetto parlato viene pronunziata sempre come z, per il principio della fedeltà alla pronuncia effettiva”; Ma chi è sta Sicilia / di muorti ammazzati?! Una esclamazione di sdegno e di stupore, una provocazione tesa a ribaltare un logoro topos; l’omaggio, alla pagina 44, a Ibn Hamdis, il poeta arabo-siciliano nato a Noto nel 1056 circa e morto in esilio nel 1133; E dici di scuttàriti lu pani?; Cadi lu pani n terra; Lu pani mi l’accattu a la putìa: un termine che si ripete; Un lampu … Eratu tu a vint’anni, amuri miu; C’è na bannera / ca sempri sbintulia … Iu cci leggiu: “Picciliddra mia”: una finestra schiusa sui propri affetti; Lu munnu … cchjù chi nzira fa / cchjù siti avi; Parlari di chiddru chi conza / la nzalata di la vita: (amare) questioni esistenziali.
Non possiamo concludere senza segnalare, fra i tanti, i testi: Vacci n guerra alla pagina 23 (del quale si è ampiamente discorso); Famìa alla pagina 67: da Arrizzulavu un furnu … a sempri è chi famìa (Ho abbattuto un forno / a colpi di piccone, / il pane lo compro al panificio, / il pensiero è rivolto sempre / alle focacce, / nella mente quel forno / sempre riarde) in precedenza riportato; A Barcellona chiddru chi ttruvavu! (ancora Spagna) alla pagina 42: A Barcellona jivu e mi mmriacavu. / Prima di partiri già mmriacu era. / Lu Spasimu a Palermu iu lassavu. / A Barcellona chiddru chi truvavu!
La poesia non deve dire ma essere! Archibald Mac Lesih.
La poesia può condurre l’uomo dallo stato di natura a quello di spiritualità. Miguel De Unamuno. La sopravvivenza di una lingua è legata alla capacità di adeguarsi al mondo che evolve. Ottavio Lurati.
A Bilingual Anthology (Sicilian/English)
Introduction and Translation
into English Verse by Gaetano CipollaEdizioni LEGAS – U.S.A. 2014
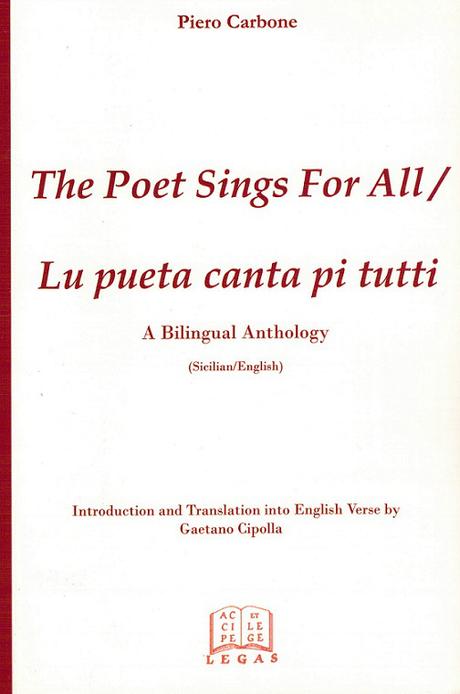 Lu pueta canta pi tutti / The poet sings for all
Lu pueta canta pi tutti / The poet sings for all
