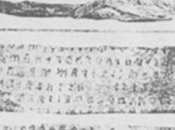Non scrivo di cinema da tanto, più o meno da quando il “dai che a farlo sono bravina” si è tramutato in “faccio schifo e dovrebbero lobotomizzarmi”.
Affrontare i fallimenti non è mai stata una mia dote.
E a quanto pare neanche scrivere di cinema, ma oggi mi gira bene e ci riprovo, senza aspettative né pressioni autoindotte: per la prima volta da anni, non ho preso neanche una riga di appunti guardando il film.
Non dico nulla di nuovo scrivendo che fin dagli albori del cinema, rappresentazione fedele del reale e spettacolarizzazione sono stati punti focali della pratica cinematografica; scendendo più nello specifico, la pratica documentaristica è stata (ma qui si va ancora più indietro nel tempo, alla nascita della fotografia) oggetto di seghe mentali studi che in breve volevano trovare una risposta alla domanda: l’atto stesso di inquadrare e fotografare (o filmare) una determinata porzione di realtà invece che un’altra determina una teatralizzazione della realtà? E il montaggio, non contribuisce forse a creare un’ulteriore finzione?
Lasciando le risposte a tali quesiti a persone più preparate della sottoscritta, e tralasciando le opere di registi che hanno scelto di girare film di finzione come fossero documentari, l’oggetto di questo già noiosissimo post è un documentario di circa un’ora dal titolo Il libraio di Belfast, diretto dalla valdostana Alessandra Celesia: un documentario anomalo, del tutto privo di colonna sonora non diegetica (aka esterna ai fatti narrati) e di commento fuori campo, che narra un paio di giorni della vita di John Clancy, libraio in pensione ed ex alcolizzato, di un ragazzo dislessico appassionato di storia e di suo fratello, rapper in erba, e di una giovane cameriera che sogna di cantare.
Già il titolo posiziona geograficamente l’azione, ma il passato recente di Belfast e dell’Irlanda del Nord emerge lateralmente, o meglio accompagna la vita dei personaggi come se vi fosse entrato di prepotenza e non avesse alcuna intenzione di andarsene: il libraio racconta della sua infanzia a Sailorstown, quartiere in cui convivevano protestanti e cattolici accomunati dalla povertà, e richiama le bombe incendiarie che nel 1974 distrussero lo storico mercato di Smithfield e con esso il suo negozio, mentre i versi composti dal giovane rapper torna costantemente il concetto di sopravvivenza (che io ho interpretato come un’opposizione agli slogan come No surrender, tipici del passato violento della città).
La macchina da presa segue i personaggi mostrandone i gesti quotidiani, lasciando intravedere le cicatrici conseguenti a trent’anni di conflitto senza analizzarle o renderle didascaliche: nella più pura pratica documentaristica, essa mostra.
Un aspetto interessante è l’assenza di collocazione etnica dei personaggi: non sappiamo se essi siano cattolici o protestanti, lealisti o nazionalisti, perché la loro appartenenza religiosa è meno importante dell’appartenenza al tessuto sociale della città, e al loro ruolo di memoria storica del passato recente; il tema della memoria ritorna con le “cacce” che John Clancy effettua per scovare dei libri rari per amici e clienti: infatti, molti di quei volumi richiamano la storia recente della città, alludendo ad una necessità dei suoi abitanti di ricordare.
Insomma è un bel film che vale i suoi 54 minuti di durata, sia dal punto di vista storico e sociale che da quello documentaristico, proprio per l’assenza di elementi cinematografici esterni.
So di essere stata particolarmente noiosa quest’oggi, prometto che il prossimo post sarà superficiale, vaneggiante e inutile come i precedenti.


![[Rubrica] Food ispiration books#7](https://m21.paperblog.com/i/288/2887365/rubrica-food-ispiration-in-the-books7-L-8vyRD0-175x130.png)